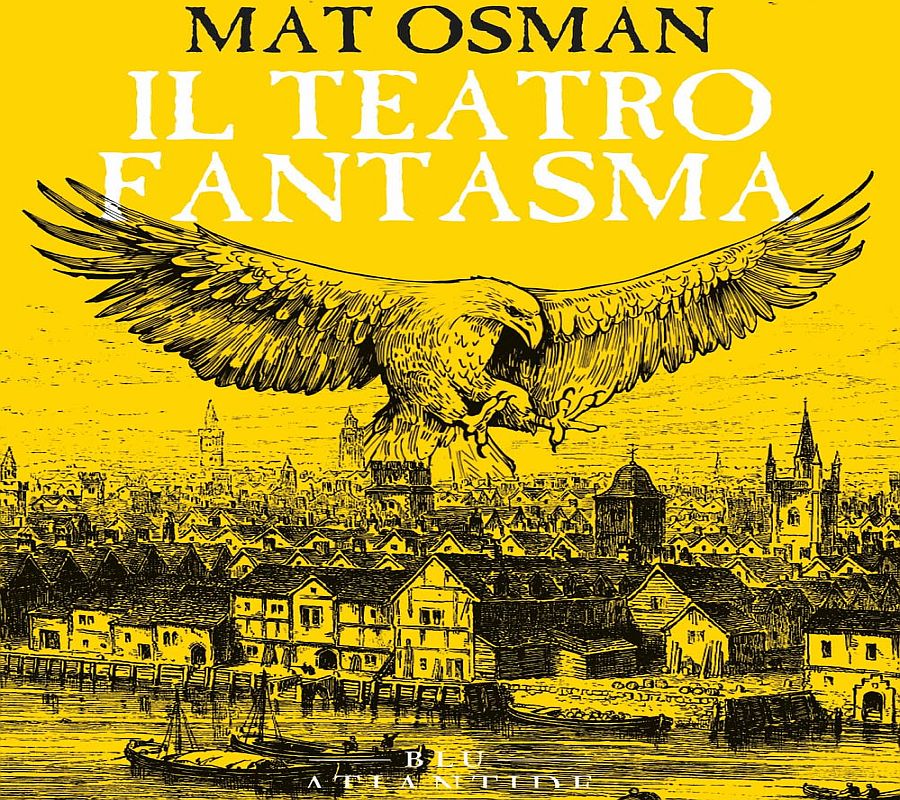Noterelle sul concetto di “capitale” in Thomas Piketty, o meglio sulla sua assenza
di Afshin Kaveh e Clément Homs
Premesse del traduttore
Questi brevissimi appunti a firma del compagno Homs, animatore in Francia delle edizioni Crise&Critique e dell’omonimo gruppo ruotante attorno alla “Critica del valore” (Wertkritik), mettono in luce i grossi limiti di base delle analisi di Thomas Piketty, economista, accademico e autore di bestseller francese. Eppure c’è dell’altro. Infatti ci danno l’opportunità di chiarire un concetto marxiano imprescindibile – tanto quanto l’aria che si respira per vivere – ma che viene sempre più a mancare nelle premesse delle critiche che si vogliono radicali – proprio come l’aria che diviene irrespirabile nella tossicità e nell’inquinamento dei nostri contesti sempre più invivibili. Tale premessa è che il “capitale” non è una “cosa” ma un “rapporto sociale”. Homs dimostra come, mancando questo cominciamento, Piketty (che, pover’uomo, non è né il primo né sarà l’ultimo) caschi puntualmente in letture monche e nell’utilizzo aspecifico e astorico delle categorie costitutive e generalizzate del modo di produzione capitalistico. Eppure i pochi osservatori italiani che hanno dato una breve sbirciata al castello teorico della “Critica del valore” sono arrivati alla medesima conclusione: questa corrente di pensiero “cosifica” il “capitale” perdendosi per strada il fatto che si tratti di un “rapporto sociale”. Così, per esempio, l’economista Bellofiore scrive che “in Postone e in Kurz l’accento è, unilateralmente, sul solo Capitale come Feticcio, che si fa Soggetto Automatico, e non (anche) sul capitale come relazione, come rapporto sociale, da cui quel feticcio emerge” [*1]; il sociologo Sivini, allo stesso titolo, scrive che “per la Critica del valore, invece, il capitale non è un rapporto sociale; è – un altro modo di interpretare Marx – il soggetto automatico che presiede all’accumulazione” [*2]. La “Critica del valore” rimprovererebbe ad altri un limite che conterrebbe essa stessa in nuce? Il bue che dà del cornuto all’asino? La verità è che Bellofiore e Sivini, così come altri, incappano in una svista bell’e buona dovuta allo spaesamento che suscita la centralità critica data al “soggetto automatico”. Scriveva Marx: “Il valore trapassa costantemente da una forma all’altra [nda. merce e denaro], senza perdersi in questo movimento, e si trasforma così in un soggetto automatico. Se si fissano le forme fenomeniche particolari assunte alternativamente nel ciclo della sua vita dal valore valorizzantesi, si hanno le dichiarazioni: capitale è denaro, capitale è merce. Ma di fatto qui il valore diventa soggetto di un processo nel quale esso, nell’assumere forma di denaro e forma di merce, passando continuamente dall’una all’altra, altera anche la propria grandezza e, in qualità di plusvalore, si stacca da se stesso in quanto valore iniziale: valorizza se stesso. Perché il movimento durante il quale esso aggiunge plusvalore è il movimento suo proprio, il suo valorizzarsi, quindi la sua autovalorizzazione. Per il fatto d’esser valore, ha ricevuto la proprietà occulta di partorir valore. Scarica figli vivi o, per lo meno, depone uova d’oro” [*3]. Questo passaggio ci aiuta a comprendere il funzionamento logico della moderna sintesi sociale basata sulla produzione di merci, il modo di produzione capitalistico che, in quanto “soggetto automatico” da cui si è agiti e non agenti [*4], impersonalmente, alle proprie spalle, come “maschere di carattere” [*5] («non sanno di far ciò ma lo fanno» [*6]), si autoalimenta come fine in sé, invertendo le attività materiali e i bisogni concreti nell’astrazione quantitativa della forma-merce e della forma-denaro, attività e bisogni la cui validazione passa per la realizzazione di queste stesse forme dal contenuto autoreferenziale. Che si producano bombe oppure olive è indifferente, se per di più le prime realizzano un valore di scambio su mercati anonimi e le seconde no, di fronte alla logica del capitale le prime sono ben più utili e le seconde trovano posto nelle discariche. Ciò disvela dialetticamente le contraddizioni insanabili (sia interne: crisi politiche, sociali ed economiche; sia esterne: collasso ambientale) e i limiti irrazionali di un tale modello sempre più insostenibile. Tutto ciò non nega il “capitale” come “rapporto sociale” ma anzi, la centralità e gli sforzi che la “Critica del valore” cede all’estrema e specifica storicizzazione delle categorie costitutive di questa particolare forma di sintesi della produzione e della riproduzione degli esseri umani associati (valore, merce, denaro, lavoro, Stato), rafforza la sua affermazione come “rapporto sociale”, vale a dire storicamente determinato, e non come “cosa” ontologicamente naturale nei secoli dei secoli. Bellofiore e Sivini possono dunque mettersi l’animo in pace rispetto alla loro critica infondata alla “Critica del valore”. Dal canto nostro, di fronte ai riformismi di Piketty, seguiremo i consigli del Virgilio dantesco, “non ragioniam di lor, ma guarda e passa”, ma lo faremo con in mano le preziose conclusioni a cui giunge Homs nel breve testo che segue.
(Afshin Kaveh, inverno 2023)
Noterelle sul concetto di “capitale” in Thomas Piketty, o meglio sulla sua assenza
di Clément Homs
Negli ultimi anni l’economista Thomas Piketty è diventato il beniamino della sinistra americana e, grazie al campo mediatico mondiale, una figura di tutela di tutti i “progressisti” nel resto del mondo. Questo economista si è sempre evoluto sullo sfondo reificato delle scienze economiche moderne e non avrebbe mai ricevuto gli elogi dei media e del pubblico se avesse formulato una critica sostanziale della società capitalista. Piketty non ha mai smesso di descrivere il suo progetto e le sue motivazioni nel modo seguente: democrazia e capitalismo sono i suoi obiettivi politici. Tuttavia l’evoluzione attuale, con il peggioramento delle disuguaglianze nella ridistribuzione, punta nella direzione di uno smantellamento della democrazia e della promessa di uguaglianza della Rivoluzione francese. In quanto democratico ed europeo Piketty si oppone a tutto questo. Il significato sociale del best-seller Il capitale nel XXI secolo consiste quindi nell’esaminare le contraddizioni del capitalismo in un modo che si conforma al sistema rendendole infine negoziabili. I riferimenti all’estremo peggioramento della situazione sociale – il crescente divario tra ricchi e poveri – sono ampiamente discussi, ma sempre con l’intenzione di salvare il sistema del capitalismo. Il senso è riformista: gli eccessi estremi devono essere affrontati e trattati dagli Stati attraverso l’attuazione di una “tassa globale e progressiva sul capitale” al fine di consentire il mantenimento del sistema del capitalismo e della democrazia. Alla domanda che fare? Piketty risponde: «inventare nuovi strumenti che aiutino a riprendere il controllo di un capitalismo finanziario praticamente impazzito, dall’altro occorre rinnovare e modernizzare in profondità e con continuità i sistemi di prelievo fiscale e di spesa che sono connaturati allo Stato sociale moderno» [*7].
Ma il riformismo di Piketty non può essere letto solamente nelle misure preconizzate, ma si ritrova concettualmente nel suo stesso metodo e nel suo stesso rapporto irriflessivo con le categorie economiche, le quali non colgono il nesso interno tra la genesi e il peggioramento delle disuguaglianze e il rapporto capitalistico stesso nel suo processo di crisi. Questo perché l’economista non ha alcun concetto di “capitale” o di “capitalismo” che si presenti anche solo lontanamente come serio. Sotto la sua penna «il capitale è uno stock», «corrisponde alla quantità totale di ricchezza posseduta in un dato momento» [*8], in altre parole, secondo questa definizione reificata, diventa «l’insieme degli attivi non umani che possono essere posseduti o scambiati sul mercato. Il capitale comprende in particolare l’insieme del capitale immobiliare (immobili, abitazioni) impiegato per l’alloggio privato e del capitale finanziario e professionale (edifici, infrastrutture, macchinari, brevetti, ecc.) impiegato dalle imprese e dalle amministrazioni» [*9]. «Per semplificare l’esposizione», riconosce, «utilizzeremo le parole “capitale” e “ricchezza” in modo intercambiabile, come due perfetti sinonimi» [*10].
Allo stesso modo in cui il pensiero economico borghese ha retroproiettato le sue categorie sull’insieme delle forme storiche della società umana, il capitale, con una tale definizione, si emancipa dal capitalismo e può essere esteso a qualsiasi società, capitalista oppure no. La naturalizzazione delle forme sociali di base del capitalismo percepito come trans-storico è in pieno svolgimento e Piketty, nella sua sconcertante ingenuità, non lo nasconde nemmeno: «In tutte le civiltà, il capitale svolge due grandi funzioni economiche: da una parte abitativa […] e, dall’altra come fattore per produrre altri beni e servizi» [*11]. La stessa osservazione apologetica vale ugualmente per la nozione di accumulazione del capitale: «Storicamente, le prime forme di accumulazione capitalistica sembrano riguardare sia gli utensili (selce, ecc.) sia gli interventi agricoli (recinzioni, irrigazione, drenaggio, ecc.), sia rudimentali tipi di abitazione (grotte, tende, capanne, ecc.) prima di passare a forme più sofisticate di capitale industriale e di investimento, e a soluzioni abitative sempre più sviluppate» [*12] (preistorici, antropologi e storici apprezzeranno).
Questa è la situazione di un “economista di sinistra” nel XXI secolo: allo stadio minimale della coscienza economica borghese in cui il capitale appare non come un rapporto sociale, ma come una “cosa”, una somma anticipata di denaro e/o una quantità di beni economici che devono essere anticipati all’inizio di un dato periodo per realizzare una produzione e permettere la ricostituzione di questi progressi alla fine dello stesso periodo. Partendo dal quadro inverso rispetto a quello proposto da Marx, per il quale «il capitale non è una cosa, ma un rapporto sociale fra persone mediato da cose» [*13], Piketty rileva l’aumento esponenziale delle disuguaglianze, senza essere in grado di fornirne una spiegazione. Tutti i critici delle disuguaglianze dovrebbero essere coscienti del fatto che una critica fondamentale di queste ultime e del loro aggravamento è possibile soltanto se si supera criticamente il quadro categoriale dell’economia borghese. Soltanto una riflessione capace di criticare i concetti di base del capitalismo nel contesto della crisi (segnata dal limite interno assoluto dato dallo sviluppo della logica autocontraddittoria del capitale) potrà prevedere un cambiamento sociale fondamentale. Chiunque continui a muoversi all’interno del quadro categoriale dell’economia borghese non sarà in grado di trascendere il nostro universo sociale globale in crisi e non lo sarà né teoricamente né praticamente. A questo proposito il superamento teorico dei limiti della coscienza borghese si presenta come un processo di riflessione sui concetti irriflessivi delle scienze economiche.
- Afshin Kaveh e Clément Homs - Pubblicato il 16/12/2023 su L'Anatra di Vaucanson -
Note:
1. R. Bellofiore, Le avventure della socializzazione, Mimesis, Milano-Udine 2019, p. 82.
2. G. Sivini, La fine del capitalismo. Dieci scenari, Asterios, Trieste 2016, p. 63.
3. K. Marx, Il Capitale, Libro primo, tr. it. di D. Cantimori, Editori Riunti, Roma 1980, p. 187.
4. «Come capitalista, egli è soltanto capitale personificato. La sua anima è l’anima del capitale. Ma il capitale ha un unico istinto vitale, l’istinto cioè di valorizzarsi, di creare plusvalore, di assorbire con la sua parte costante, che sono i mezzi di produzione, la massa di pluslavoro più grande possibile. […] L’operaio qui non è altro che tempo di lavoro personificato», in: Ivi, pp. 267 e 278.
5. «Le maschere economiche caratteristiche delle persone sono soltanto le personificazioni di quei rapporti economici, come depositari dei quali esse si trovano l’una di fronte all’altra», in: Ivi, p. 118.
6. Ivi, p. 106.
7. Thomas Piketty, Le Capital au XXIesiècle (Il capitale nel XXI secolo, tr. it. di S. Arecco, Bompiani, Milano 2018), Seuil, Paris 2013, p. 756.
8. Ivi, p. 89.
9. Ivi, p. 82.
10. Ivi, p. 84.
11. Ivi, p. 337.
12. Ibidem.
13. K. Marx, Il Capitale, cit., p. 828.