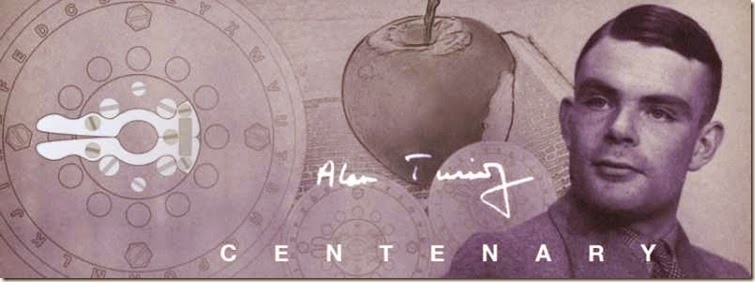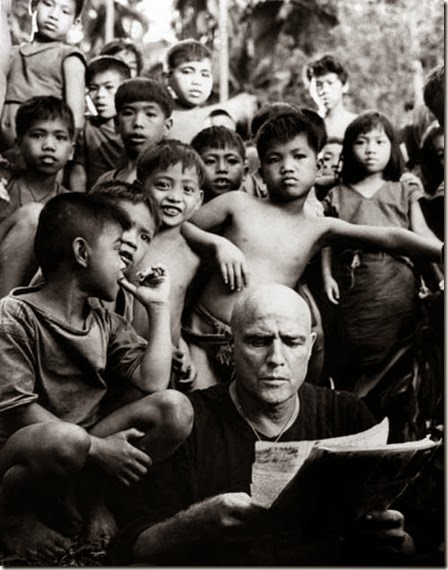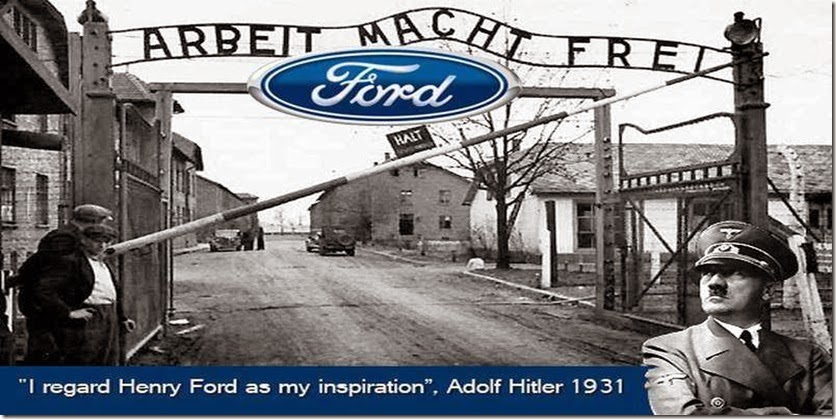A proposito del libro di Alfred Sohn-Rethel, "La pensée-marchandise"
di Palim Psao
«Non è solo il contenuto, ma sono le forme stesse del pensiero, a trarre origine dall'organizzazione sociale della produzione materiale. Gli inizi della logica, nel mondo dell'antica Grecia, sono legati alla comparsa delle prime monete. L'apriori di cui parlava Kant era la forma-merce. Sono queste le teorie innovative che Sohn-Rethel propone negli anni 1930, in controcorrente non solo a tutta la tradizione filosofica, ma anche al marxismo tradizionale. Queste teorie hanno influenzato profondamente gli inizi della Scuola di Francoforte, al prezzo però di un'emarginazione dell'autore, durata per molto tempo. Questa prima traduzione francese di tre dei suoi saggi, non solo riempie una grave lacuna nella conoscenza d el pensiero critico tedesco nella sua età d'oro, ma offre anche gli strumenti per elaborare al giorno d'oggi un'epistemologia fondata sulla teoria di Marx, vista nel quadro di una critica radicale dell'astrazione sociale, del mercato e della merce, che ci governano.»
Così, la quarta di copertina del libro di Alfred Sohn-Rethel, "La pensée-marchandise", il quale comprende tre saggi scritti negli anni 1930 dal filosofo della Scuola di Francoforte ("Forme marchandise et forme de pensée ? Essai sur l'origine sociale de l'entendement pur"; "Eléments d'une théorie historico-matérialiste de la connaissance"; "Travail intellectuel et travail manuel. Essai d'une théorie matérialiste"), preceduti da una prefazione scritta da Anselm Jappe che lega il dibattito, che ebbe corso nell'ambito della nuova sinistra tedesca degli anni 1970, intorno all'opera di Sohn-Rethel, al dibattito attuale in seno al movimento della Wertkritik (critica del valore).
Nonostante la "tripla infedeltà" nei confronti dell'analisi marxiana della forma-valore - come evidenzia Anselm Jappe - l'opera di Sohn-Rethel finisce per essere più interessante per le domande fondamentali che tratteggia, piuttosto che per le risposte che si dà. Sta in questo, l'interesse reale che possiamo nutrire per la lettura di Sohn-Rethel, quello di una promessa a partire dalla quale sia possibile ricostruire un'epistemologia, e che fa di lui "uno dei rari marxisti che abbia ancora qualcosa da dirci, al fine di comprendere il XXI secolo". E possiamo sottolineare come possa essere accostato alla lettura, o rilettura, della "Teoria generale del Diritto" del teorico russo Pasukanis, come aveva già osservato Jean-Marie Vincent.
La questione posta da Sohn-Rethel non è solo quella di liberare una spiegazione dei contenuti della coscienza ( come ha fatto il materialismo storico con il suo schema struttura-sovrastruttura e con la teoria del riflesso oggettivo della realtà per quel che riguarda la conoscenza scientifica ), ma di riflettere su un piano più profondo, interrogarsi sulle forme stesse (le categorie) che strutturano la coscienza, l'intelletto, la capacità di comprensione che riceve le molteplici impressioni sensoriali: "Qual è l'origine delle forme di coscienza, di quelle griglie che permetto a ciascun individuo di organizzare i dati molteplici che gli vengono forniti dalla percezione sensibile"? Queste forme ("stampi") del pensiero che sono il tempo, lo spazio, la causalità, la sostanza, l'infinito, il numero, la quantità, l'identità, la totalità, la contraddizione, ecc., queste forme stesse che strutturano la coscienza, la capacità di comprensione. Queste forme della coscienza devono essere considerate come dati universali, eterni e trans-storici? Quando si considerano le due soluzioni tradizionali, proposte dalla filosofia a tali questioni (è l'empirismo dell'esperienza che fonda le categorie, o preesiste una struttura ontologica nell'uomo?), Sohm-Rethel rifiuta quello che entrambe hanno in comune: il loro dualismo ontologico fra soggetto ed oggetto. QUesto dualismo non è affatto ontologico per Sohn-Rethel, ma è storico-sociale, ed è proprio a partire da questa intuizione che sviluppa il suo pensiero per poi proporre una terza soluzione: né empirismo né ontologismo, ma storicità della forme della comprensione. Storicità che non è altro che l'azione concreta degli uomini nelle loro condizioni specifiche. Non è la coscienza a determinare l'essere, è l'essere sociale, la vita concreta in società a partire dall'agire, che determina la coscienza. Senza però - e questa è la grande differenza con le teorie post-moderne e decostruttiviste - cadere in una teoria relativistica della conoscenza.

Se l'intuizione è buona - per cui "l'astrazione, benché essa non esista altro che nel pensiero, non nasce a partire dall'azione, ma a partire dall'agire"(Jappe) - è l'agire preso in esame che pone qualche interrogativo. Per Sohn-Rethel, l'agire umano, che è la fonte dell'astrazione, si situa dentro la circolazione delle merci, dentro lo scambio, cioè a dire dentro le azioni di acquisto e di vendita. E l'astrazione consiste in quest'azione di scambio, nella separazione temporale fra l'azioe d'uso e l'azione di scambio. L'agire sociale, l'essere sociale, la storicità, per Sohn-Rethel, avviene dopo la produzione, nella circolazione; mentre ciò che accade prima, la produzione delle merci, il lavoro, è ante-sociale, è dell'ordine della metabolizzazione della natura, dell'eterno, dell'ovvio, del trans-storico, dell'ontologico, che non può essere messo in discussione. Rifiutandosi di risalire fino al lavoro, Sohn-Rethel trascura il concetto centrale di "lavoro astratto" che è il fondamento essenziale della socializzazione capitalista (vedi Moishe Postone). Jappe afferma che Sohn-Rethel, in ultima analisi, rimane dentro il rapporto feticistico che lega il consumatore ai suoi prodotti. L'errore rinvia quindi alla domanda circa dove si trovi la fonte dell'astrazione sociale: nel lavoro o nello scambio? Anche il lavoro è storico-sociale (posizione della WertKritik), oppure è solo la circolazione dei prodotti oggettivamente supposti "naturali" ad essere storico-sociale? Sohn-Rethel rimanda tutto all'astrazione-scambio. E se parla di lavoro umano astratto, sembra farlo totalmente derivare dall'astrazione-scambio, come effetto dello scambio sul lavoro. La produzione è perciò naturale e trans-storica per Sohn-Rethel, è la socializzazione (la "connessione sociale", come la chiama) post-produzione ad essere fonte dell'astrazione sociale del valore che mette tra parentesi il valore d'uso, facendone astrazione dentro la merce. In questo, evidentemente, Sohn-Rethel resta completamente dentro l'ontologia marxista del lavoro, la quale ha corrisposto all'apologetica del lavoro da parte del movimento operaio, sia anarchico che marxista che socialdemocratico. Una critica tronca del capitalismo che è sempre consistita in un dibattito sull'ampiezza del salasso, da stabilire sulla valorizzazione capitalista, al fine di creare in seno alla società feticista dei diritti sociali, uno Stato-Provvidenza, un diritto al lavoro, una sicurezza sociale, pensioni, aumenti salariali, eliminazione della classe mercantile che organizza la circolazione (perché la produzione è naturale, è la circolazione ad essere sociale), lasciando del tutto intatta la logica folle della valorizzazione, del valore che si valorizza consumando in maniera bulimica il lavoro astratto. Una critica, perciò, "dal punto di vista del lavoro" (Postone), che è immanente alla logica stessa della valorizzazione. Non è per niente che si è è visto, negli ultimi 30 anni, la crisi del capitalismo che crolla,nella sua fuga neoliberista, insieme alla crisi di quello che è stato presentato nel XX secolo come la grande critica del capitalismo, il marxismo. Dappertutto, il movimento operaio ha alzato bandiera bianca, e non fa altro che cercare di trarre profitto dal ruolo centrale che il lavoro, in quanto specificità capitalista ( e solo capitalista, in quanto non esiste nelle altre società pre-capitaliste), gioca dentro il movimento automatico della valorizzazione.

La tesi di Sohn-Rethel è quella di considerare, non solo la comparsa sincrona della moneta e della filosofia, o della matematica (il pensiero concettuale), in Grecia, durante il "miracolo greco" a partire dal V secolo aC nella Ionia (Sohn-Rethel fa riferimento allo storico inglese George Thomson di cui fu amico e continuatore), ma, ancor più, si stupisce a proposito della somiglianza che esiste fra le proprietà dell'astrazione-scambio (che rifiuta di riferire totalmente al lavoro astratto - Jappe ricorda i commenti che fece Robert Kurz circa questi limiti assai importanti degli sviluppi di Sohn-Rethel) e le categorie pure della comprensione proposte dalla filosofia. L'astrazione dell'atto dello scambio (che comprende perciò assai male) sarebbe all'origine, a partire da esso, della nascita dell'astrazione nel pensiero, la cui radice si ritrova nello scambio di merci. Il "miracolo greco" viene così messo in relazione con la comparsa della moneta, cosa che permette ai filosofi di passare da un pensiero antropomorfico ad un pensiero concettuale, proprio grazie alla comparsa e all'utilizzo quotidiano della moneta nella Ionia, in quanto l'esperienza dell'astrazione della moneta non è stata (per loro) un'operazione mentale, bensì un'evidenza tangibile. Il mito del sapere, visto come conoscenza progressiva ed accumulativa dello spirito, è un'illusione. E Sohn-Rethel cerca di dimostrarlo attraverso la scolastica medievale o la rivoluzione scientifica galileiana. Per fare un solo esempio nell'antichità: "l'uno per Parmenide, come diceva George Thomson, come nozione ulteriore di 'sostanza', può perciò essere definito come il riflesso o come la proiezione della sostanza del valore di scambio". Si possono ritrovare oggi molti altri esempi in un continuatore delle tesi di Sohn-Rethel, nel libro del filosofo tedesco Eske Bockelmann, "La mesure de l'argent. Sur la genèse de la pensée moderne".
Per Sohn-Rethel, il fatto essenziale all'epoca, è la comparsa della separazione fra lavoro manuale e lavoro intellettuale (fatto attraverso l'espropriazione dei saperi propri del lavoro manuale, a vantaggio del lavoro intellettuale), è allora che "il lavoro manuale, privato della sua potenza mentale, non può più effettuare la coesione fra i differenti lavori e la società in generale, e bisogna garantire il legame sociale a posteriori attraverso lo scambio e l'attività intellettuale - dunque per astrazione". E' il lavoro intellettuale, perciò, che sembra operare la connessione sociale, al posto di una produzione immediatamente sociale come, per Sohn-Rethel, avviene nel comunismo primitivo(?) o nel comunismo moderno ... Qui si può porre la questione delle contraddizioni in seno all'opera di Sohn-Rethel, la contraddizione fra il suo interesse per la teoria soggettiva del valore (come nel "marginalismo") e l'analisi marxiana.
Se, sotto molti aspetti Sohn-Rethel rimane attaccato al marxismo tradizionale, aveva ben capito - in un'epoca in cui ausi nessuno ci era arrivato - che secondo Marx la caratteristica più esenziale del capitalismo è l'astrazione che fa subire alla vita sociale. Con il termine "astrazione reale", Sohn-Rethel ha dato un contributo molto importante all'elaborazione della critica del feticismo delle merci, anche se - come si può vedere - il suo rifiuto di ricondurre lo "scambio astratto" al "valore astratto" - come fa lo stesso Marx - ha limitato grandemente la portata delle sue intuizioni. Tuttavia, il vero obiettivo di Sohn-Rethel era tutt'altro: quello di dare una spiegazione storica e materialista delle forme stesse della conoscenza, analizzando soprattutto la prima apparizione del pensiero filosofico in Grecia, la nascita della scienza moderna con Galileo, e le forme a priori di Kant.
- P.P. -
fonte: Critique radicale de la valeur