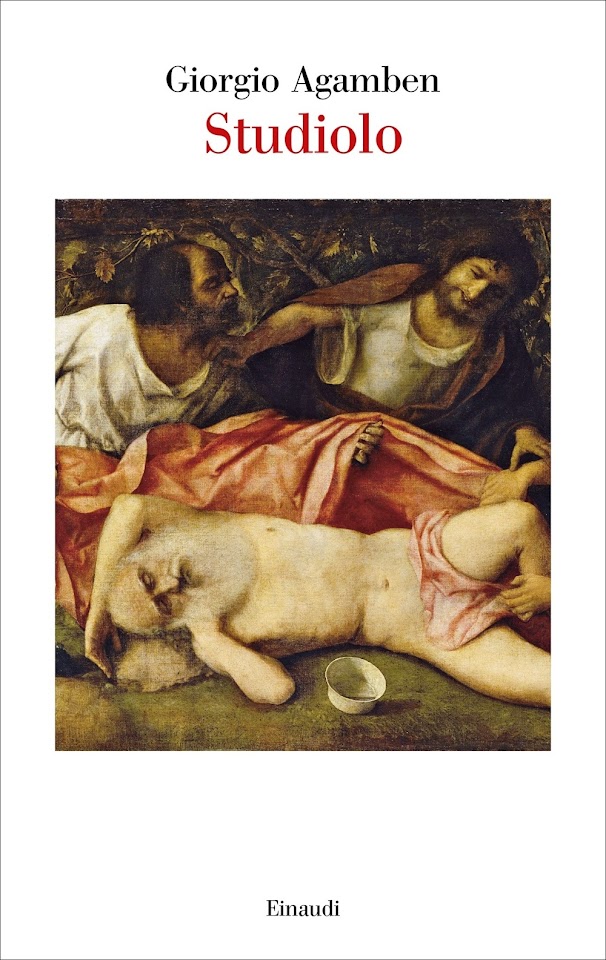Il Gemeinwesen è sempre rimasto qui con noi
- un confronto con le idee di Jacques Camatte -
di Peter Harrison
«Quanto meno tu sei, quanto meno realizzi la tua vita, tanto più hai; quanto più grande è la tua vita alienata, tanto più accumuli del tuo essere estraniato.» Karl Marx, Manoscritti economico-filosofici, 1844.
Gli scritti di Jacques Camatte, regolarmente aggiornati, si possono trovare sul sito Invariance. Nato nel 1935, nel corso degli anni '50 e '60 è stato un importante teorico marxista radicale nell'ambito della sinistra comunista europea. Tuttavia, gli eventi del '68, in particolare in Francia, hanno fatto sì che si allentassero gradualmente quelli che erano i suoi rapporti con la sinistra comunista. Si era reso conto che l'umanità ora si trovava in un'impasse. Da parte del proletariato, non ci sarebbe stato alcun rovesciamento della borghesia, dal momento che tutta l'umanità era stata oramai «addomesticata» dal capitale. Ragion per cui, d'allora in poi qualsiasi rivolta organizzata contro il capitale avrebbe solo favorito ulteriormente il suo sviluppo. La sua tesi è quella secondo cui, anziché combattere il capitale (una strategia che, se «avesse successo», ci restituirebbe il capitale in una sua forma ancora più forte), dobbiamo, in qualche modo, abbandonarlo. Prendere congedo da questo mondo capitalista implica la ricomposizione dei legami con il mondo naturale... e non significa andare in guerra contro il capitale per spodestarlo.
L'abbandono di «questo mondo» (Questo mondo che bisogna lasciare) e di tutto ciò che esso rappresenta, inclusa l'umana inimicizia per tutte le cose (gli altri animali, le altre cose, gli altri esseri umani) - qualcosa che è diventato parte integrante della moderna psiche umana e che ci costringe a creare in continuazione delle situazioni di «battaglia» , o di discontinuità - darà l'avvio, egli sostiene, ad un processo che condurrà alla formazione di una comunità autenticamente umana, che sarà in continuità con la natura e con sé stessa. Ciò trasformerà l'Homo sapiens (il cui significato letterale è «uomo saggio») in una nuova specie: Homo Gemeinwesen. Tale processo, insiste Camatte, è comunque già cominciato, e riemerge costantemente.
Camatte riprende da Marx il termine Gemeinwesen. Tale termine viene tradotto come «comunità», ma Marx insiste sul fatto che la vera essenza dell'individuo umano è la sua immutabile esistenza in quanto essere sociale, ed è questo a conferire alla parola quello che è un altro significato. Come egli ha scritto, seguendo Feuerbach: «L'individuo è l'essere sociale.» Gemein viene tradotto come «comune», e wesen come «essere», o «essenza». Quindi, può essere anche letto come «essenza comune», o «essere comune», ed è seguendo questa strada che Camatte adopera il termine Gemeinwesen per definire e riferirsi alla vera comunità umana, alla comunità, sia immediata, che non mediata... in altre parole, al vero obiettivo del comunismo, come concepito da Marx.
Marx scrive: «Questo comunismo s'identifica, in quanto naturalismo giunto al proprio compimento, con l'umanismo, in quanto umanismo giunto al proprio compimento, col naturalismo; è la vera risoluzione dell'antagonismo tra la natura e l'uomo, tra l'uomo e l'uomo, la vera risoluzione della contesa tra l'esistenza e l'essenza, tra l'oggettivazione e l'autoaffermazione, tra la libertà e la necessità, tra l'individuo e la specie. E' la soluzione dell'enigma della storia, ed è consapevole di essere questa soluzione.»
Marx asserisce che «l'essere umano è la vera comunità dell'umanità.» Camatte, in tutto il suo lavoro ha utilizzato questo particolare frase come una pietra di paragone per le sue idee (sebbene, come ha scritto nel 2010, avesse cercato di smorzare le connotazioni antropocentriche ed umanistiche associate al termine «essere umano», sottolineando come, allo stesso tempo, sia la «forma di vita» della specie particolare, se non l'individuo stesso, la vera comunità del genere umano).
Per meglio capire questa frase – la quale è un'altra versione dell'«individuo è l'essere sociale» - è utile sapere che Marx qui la sta usando nel contesto di quelle che sono delle rivolte contro «la vita disumanizzata»; sia che avvengano nella Francia del 1789, o che attraversino gli Stati Uniti nel 2020. Egli sta argomentando che simili rivolte contro le cose così come sono, costituiscono quello che è un profondo tentativo psicologico da parte delle persone di porre in atto un collegamento alla comunità umana originale, che la più parte di noi ha perduto molte generazioni fa. Essi stanno cercando di sovvertire le condizioni della loro vita, che sono segnate da una separazione di fatto sempre più grande rispetto ad una vita umana, rispetto alla natura umana, e rispetto a sé stessi. Queste periodiche espressioni di malcontento e di rivolta si verificano perché gli esseri umano si trovano separati dalla comunità che consente loro di essere pienamente, o propriamente umani. Il malcontento, persino quello di un solo piccolo quartiere - «proprio perché parte dal punto di vista del singolo, individuo reale» - è sufficiente, egli afferma, ad esporre quella che è la tragedia della nostra separazione dall'essenza comunitaria della natura umana. Camatte chiarisce la natura di questo genere di rivolte affermando che tale «ribellione è in prevalenza una ribellione dei corpi,», si tratta di «un atto di comprensione che avviene non solo a livello intellettuale, ma soprattutto sensoriale.»
Di fatto, Camatte ha usato quella che era la citazione originale più lunga che contenesse tali idee (dai Manoscritti Economico-Filosofici del 1844, e che viene interpretata nel paragrafo seguente) e che compare in un volantino distribuito durante gli scioperi francesi del maggio '68. Ciò che Marx sostiene, e che Camatte persegue nella sua teoria, è che l'umanità ha perduto la propria comunità. La comunità degli umani è stata sostituita, ad esempio, con la comunità del denaro, o dalla comunità del capitale, e a causa di ciò gli esseri umani sono diventati infelici e perduti, e non sono più nemmeno propriamente umani ... e percepiscono una tale perdita. Camatte ritiene che la perdita abbia avuto inizio quando i primi umani hanno cominciato a separarsi dalla natura, millenni fa. Da allora in poi, si sono sempre più distaccati dal mondo e da sé stessi - e dal momento che la loro propria natura è come un essere sociale - questo ha determinato un loro incessante vagabondare.
Il concetto di umanità "errante" è stata esplorato da Emil Cioran nel 1949, in "Sommario di Decomposizione" (Una breve storia della decadenza). Ciò che per Marx è un riferimento ad un un senso di perdita della comunità, da parte della specie, Cioran lo riferisce ad una nostalgia, con cui intende il desiderio di un luogo e di una casa, una "nostalgia di casa". Cioran scrive: «Da Adamo in poi ogni sforzo degli uomini ha mirato a modificare l'uomo. [...] Mentre tutti gli esseri hanno il loro posto nella natura, lui resta una creatura metafisicamente errante [*1], perduta nella Vita, incongrua nella Creazione. Alla storia nessuno è mai riuscito a trovare uno scopo plausibile; ma tutti ne hanno proposti, ed è un pullulare di scopi così divergenti e bislacchi che l'idea di finalità ne è annullata e si riduce a irrisorio articolo dello spirito.»
Cioran si chiede come l'umanità possa trovare un compromesso tra l'incessante desiderio interiore, vale a dire la nostalgia - egli usa le parole «Sehnsucht, yearning, saudade» - per una casa, o per un posto e la condizione peripatetica e sradicata di quella che è la nostra esistenza. La sua risposta dice che non c'è compromesso - non c'è alcun rimedio per la sofferenza: «Da un lato, la volontà di essere immersi nella comunione del cuore e del suolo; dall'altro, quella di assorbire continuamente lo spazio in un desiderio inappagato. E poiché lo spazio non ha limiti, e con esso aumenta la propensione a nuovi vagabondaggi, lo scopo arretra via via che si avanza. [...] Non c'è soluzione alla tensione fra la Heimat e l'Infinito: ciò significa essere radicati e sradicati a un tempo, non aver potuto trovare un compromesso tra il focolare e la lontananza.»
Nel mentre che egli, probabilmente a sua insaputa, riecheggia Marx, Cioran prefigura anche la rappresentazione del trauma fatta da Camatte - «il trauma fondante della discontinuità» - impresso nella psiche umana quando l'uomo si è separato dalla natura, o è diventato discontinuo con essa, quando scrive: «Essere strappati dalla terra, sopportare l'esilio, tagliate le proprie radici immediate... significa anelare ad una ritorno alla fonte originaria, anelare ad un ritorno al tempo precedente alla rottura della separazione.»
Camatte ha ampliato e riformulato questo concetto di separazione e di vagabondaggio. Con "vagabondaggio", Camatte insiste sul fatto che, a partire dalla loro separazione dalla natura, gli esseri umani non hanno mai smesso di cercare una giustificazione alla propria esistenza: essi sono costantemente alla ricerca di un significato per le loro vite e di uno scopo. Per Camatte, il problema gira intorno alla secolare questione se l'uomo sia parte della natura o se sia fuori da essa. Il "vagabondare", come sostengono sia Cioran che Camatte, è espressione della profonda crisi di identità che affligge la specie: se l'uomo è parte della natura, in che modo ne è parte, e se si trova oltre la natura, al di fuori, dov'è che si colloca esattamente l'umanità? (A tal proposito, il contenuto del vagabondare può essere inteso in maniera efficace ed utile - come ho scritto precedentemente - in quanto storia.) Ma se Cioran non vede alcuna speranza di fuga dall'attuale condizione umana, Camatte, avendo abbandonato le sue convinzioni marxiste e "rivoluzionarie", vede la possibilità che emerga un nuovo tipo di essere umano. Camatte ipotizza che sarà l'Homo Gemeinwesen «la specie che succederà all'Homo sapiens. Sarà in continuità con la natura e con il cosmo. La sua conoscenza processuale [il suo divenire o, volgarmente, la sua coscienza] non avrà alcuna funzione giustificatrice, poiché opererà unicamente all'interno delle dinamiche di godimento.»
In "L'erranza dell'umanità" (1973), Camatte scende un po' più nei dettagli su come potrebbe essere la nuova società dell'Homo Gemeinwesen, per quanto, non avendo formulato a quel tempo in maniera adeguata il concetto di Homo Gemeinweisen, egli si riferisca a quella nuova società semplicemente come al "comunismo":
«Col comunismo, finita la divisione del lavoro su cui ha potuto innestarsi il movimento del valore (che esso stimola ed esalta a sua volta), l’edificazione delle caste o delle classi; il comunismo è innanzitutto unione. Non è dominio sulla natura, ma riconciliazione con essa, il che presume pure che essa sia rigenerata. Gli esseri umani non possono più considerarla meramente come un oggetto per il loro sviluppo, una cosa utile, ma come soggetto (non in senso filosofico) da loro non separato non fosse altro perché essa è in loro; vi è realizzazione della naturalizzazione dell’uomo e l’umanizzazione della natura (Marx), e la fine della dialettica del soggetto e dell’oggetto. Ne deriva una distruzione dell’urbanizzazione e formazione di molteplici comunità ripartite sulla terra, il che implica la soppressione della monocoltura, altra forma della divisione del lavoro, ed una trasformazione completa del sistema delle comunicazioni: i trasporti saranno considerevolmente diminuiti. Il modo di vita comunitario è il solo che possa permettere all’uomo di dominare la sua riproduzione, di limitare l’aumento (attualmente demenziale) della popolazione, senza ricorrere a pratiche ignobili: distruggere gli uomini e le donne.» E continua ...
«È evidente che non si tratterà, per reazione, di tornare ad un nomadismo quale poteva essere praticato dai nostri lontani antenati raccoglitori; gli uomini e le donne acquisiranno un altro modo di essere al di là del nomadismo e della sedentarietà. Quest’ultima, coniugata con l’inattività corporea, è la fonte principale della quasi totalità delle malattie somatiche e psichiche degli esseri umani attuali; una vita attiva e non fissata risolverà tutte le difficoltà senza medicina né psichiatria.»
Scrivendo nel 2020, è ovvio che Camatte veda questa uscita dal mondo del capitale, e di arrivo alla destinazione di una nuova specie - l'Homo Gemeinwesen, o alla vera comunità umana - come un processo che richiede «migliaia di anni». Perciò, non si deve commettere l'errore di pensare che stia proponendo una qualche riduzione "forzata" della popolazione. È anche utile ricordare che non sta proponendo alcun genere di conflitto con il mondo così com'è. Egli afferma in maniera esplicita che costruire una "inimicizia" nei confronti del capitale, al fine di rovesciarlo, non farà altro che renderlo ancora più forte.
È stato questo il suo punto di vista, come risultato delle riflessione sugli eventi a partire dal 1968: «Più lottiamo contro il capitale, più lo rafforziamo.» Ragion per cui, la chiave è incominciare, in qualche modo, a creare nuovi modi di vivere: «Il problema è quello di creare altre vite.» Infatti, Camatte sembra trovare interessante ogni nuova sperimentazione sociale che indichi un diverso modo di vivere, o che contenga un rifiuto degli aspetti di questa società, come il movimento hippie, i metodi agricoli alternativi, sebbene egli sia, naturalmente, consapevole di come questi movimenti possono essere reincorporati all'interno del capitale. Ma esiste anche un'urgenza legata a questo abbandono delle cose così come sono, dal momento che la scelta si trova ad essere sempre più proiettata verso «o il comunismo, o la distruzione della specie umana». E tutti questi rifiuti o rivolte sono sempre suscettibili di recupero da parte del capitale: «Il capitale può ancora trarre profitto dalla creatività degli esseri umani, rigenerando e risostanzializzando sé stesso, depredando la loro immaginazione».
Tuttavia, l'impulso a dare inizio ad una rigenerazione della comunità e della natura, per Camatte non è così semplice e diretto. Non essendo un'alternativa "politica", non si tratta di un rovesciamento del vecchio regime e di una sua sostituzione con un nuovo regime, e non è nemmeno una rivoluzione così come viene comunemente intesa. Più recentemente, Camatte usa il termine "inversione" per descrivere il lasciare questo mondo. Un tale concetto non intende implicare un semplice rovesciamento delle cose come stanno, né vuole significare un ritorno ad un tempo precedente alla nostra disumanizzazione. Si tratta, piuttosto, della capacità di accedere al seme della naturalezza che si trova dentro di noi, che è stato a lungo represso ed è rimasto nascosto, e di aiutarlo a germogliare. Si può vedere come questa idea sia intimamente legata al modo in cui Marx ha descritto l'essenza della rivolta, ma nella concezione di Camatte ogni "politica" è stata rimossa. Egli insiste: « L'inversione non è una strategia, essa è totalmente al di fuori della politica, la quale è la dinamica dell'organizzazione delle persone, del loro controllo. Dobbiamo abbandonare qualsiasi cosa che si parte del suo mondo.»

Un Residuo Millenario?
Jacques Camatte proviene da quella moderna e marxista tradizione rivoluzionaria che
Yuri Slezkine, nella sua opera monumentale, "
La casa del Governo", descrive come millenaria. Il millenarismo, che può essere religioso o laico, è quella convinzione secondo cui la società umana ha bisogno di una grande trasformazione, e che dopo questa trasformazione le persone vivranno in pace e in armonia. È l'eterno impulso ricorrente che hanno coloro che vivono in società sfruttatrici e gerarchiche, e con questo, naturalmente, si intende uno Stato.
In uno Stato, le condizioni di vita - lavoro, sfruttamento, gerarchia, noia, povertà, ricchezza, disperazione - sono le cause del millenarismo e, come ha suggerito l'antropologo
Pierre Clastres parlando del movimento sociale dei
profeti karai in Amazzonia, anche la minaccia di uno Stato può produrre millenarismo. In maniera molto significativa, Clastres suggerisce anche che i millenaristi karai - che hanno mobilitato più di 10.000 persone affinché migrassero verso la
Terra senza il Male, in direzione del sole al tramonto - sono riusciti a realizzare «
ciò che è impossibile nelle società primitive: unificare, in una migrazione religiosa, quelle che sono le molteplici varietà delle tribù. In un colpo solo, sono riusciti a portare a termine l'intero [unificante] programma dei capi.» L'osservazione, sorprendente e profonda, di Clastres è che il millenarismo - il sovvertimento rivoluzionario, o la fuga dalle condizioni esistenti - contrariamente a quel che si pretende che sia, è il modo più efficiente per omogeneizzare le persone, unificarle per una causa esterna rispetto a loro. I rivoluzionari perciò, e questo può essere ricavato dalla storia, sono i costruttori dello Stato per eccellenza. Il millenarismo, quindi, è una risposta ricorrente, sotto varie forme, allo Stato, il quale, a sua volta, è una società profondamente insoddisfacente.
Quando nel 1972, lo storico
Christopher Hill, nel suo "
The World Turned Upside Down: Radical Ideas During the English Revolution", valutò l'analisi storica contemporanea, scrisse: «
noi ora vediamo il millenarismo come se fosse un prodotto naturale e razionale dei presupposti di questa società». Il millenarismo - un altro termine per "
rivoluzionarismo" - è quindi, oggettivamente, una funzione dello Stato. Esso ha anche, invariabilmente, un qualche genere di relazione con l'idea di una «
caduta in disgrazia», o con la perdita della naturalità e della comunità... in modo che così si possa vedere come l'impulso millenario abbia origine dal medesimo punto di vista di coloro che Marx descrive come ribelli - in quanto sentono di essere stati disumanizzati o, quanto meno, privati di quella comunità che li rende umani. In tutti noi, al nostro interno, è contenuto il germe del millenarismo, ed è un tratto della nostra reazione ad una vita insoddisfacente...
Albert Camus, ne "
L'uomo in rivolta", ci consiglia di non «
scatenarlo».
Forse, la prima manifestazione di millenarismo che troviamo nella storia proviene dall'Iran, con l'arrivo di Zoroastro, circa tremila anni fa. Come ha sostenuto
Karl Jaspers, lo sviluppo della civiltà quest'epoca - che egli definiva «
l'era assiale» - è stata un'era di cambiamenti e di incertezza, in cui abbiamo visto un proliferare di pensiero radicale e dove si è espresso malcontento. Slezkine scrive: «
Zoroastro fece la storia – letteralmente oltre che in senso figurato – profetizzando la fine assoluta del mondo. Ci sarebbe stata una battaglia finale tra le forze della luce e quelle delle tenebre, e un giudizio finale su tutti gli esseri umani mai vissuti – e poi non vi sarebbe stato altro che una universale, eterna perfezione: non più fame né sete, non più divergenze, né nascite, né morti. L’eroe avrebbe per l’ultima volta sconfitto il serpente; il caos sarebbe stato vinto definitivamente; solo il bene sarebbe rimasto – per sempre.»
«
Il millenarismo», sostiene Slezkine, «
è la fantasia vendicativa dei diseredati, la speranza di un grande risveglio». Naturalmente, questa fantasia vendicativa è assolutamente comprensibile, e probabilmente inevitabile, ed è perciò impossibile prevenirne il ritorno sotto nuove forme... ma il problema è che essa non porta mai alla pace sulla terra, e di solito rende le cose parecchio peggiori. Slezkine continua la storia: «
Le sette millenaristiche sono quasi tutte morte come sette. Alcune sono sopravvissute come sette ma hanno smesso di essere millenaristiche. Alcune sono rimaste millenaristiche fino alla fine perché la fine è arrivata prima che avessero l’occasione di creare uno stato stabile. La cristianità è sopravvissuta in quanto setta, ha smesso di essere millenarista e ha adottato Babilonia come credo ufficiale. Gli ebrei e i mormoni sono sopravvissuti alla loro traversata del deserto e hanno barattato latte e miele contro stati stabili prima di essere assorbiti da imperi più grandi. I musulmani hanno creato i propri grandi imperi vincolati a un millenarismo di routine e minacciati da ripetute riforme “fondamentaliste”. Gli anabattisti di Münster e i giacobini raccolsero politiche preesistenti e le riformarono a immagine della futura perfezione, per poi rimanere sconfitti nella guerra civile contro riformatori più moderati. Solo i bolscevichi distrussero la “prigione dei popoli”, batterono i “conciliatori”, misero fuori legge il matrimonio tradizionale, bandirono la proprietà privata e si trovarono solidamente al comando di Babilonia mentre ancora attendevano, da vivi, il millennio. Mai prima di allora una setta apocalittica era riuscita a prendere il controllo di un esistente impero terreno (se non si contano i safavidi, la cui agenda millenaristica sembra fosse molto meno radicale). È come se i quinto-monarchisti avessero vinto la guerra civile inglese, “riformato ogni luogo e vocazione”, preso atto di un’isola invasa da piante che il Padre celeste non aveva piantato, e si fossero dedicati a estirparle una per una, “radici e rami, ogni pianta e ogni pezzo di ogni pianta”. Il fatto che la Russia non fosse un’isola rendeva ancor più formidabile la sfida.» ((Slezkine).
Tutti i movimenti seri attraverso i quali si cerca di modificare radicalmente, di abolire o di sfuggire dalle società statali sono dei movimenti millenari. Il millenarismo è un prodotto della critica dello Stato nella quale le masse vengono percepite come gli zimbelli del male. Il rimedio necessita che vengano spazzati via tutti i meccanismi del male - le leggi, le norme, le tradizioni - insieme a tutti coloro che, per pura malizia, per debolezza o accidia, agevolano il mantenimento del male. Solo i buoni di cuore - vale a dire, i più fedeli alla causa - riusciranno ad arrivare sani e salvi dall'altra parte della rivoluzione. Ma esistono anche versioni meno drammatiche del millenarismo: alcune sette religiose si ostinano semplicemente ad aspettare - e ad essere pronti per - l'apocalisse, la quale verrà liberata quando deciderà Dio. Una simile strategia rispecchia il convincimento dei comunisti di estrema sinistra, dei rivoluzionari dell'ultrasinistra, o degli anarchici che aspettano pronti - restando vicini alla «
causa» e coinvolgendo altri, magari per convincerli - che confluiscano quegli eventi che potranno dare loro l'opportunità di diventare le levatrici del comunismo. Questa strategia dei gruppi di estrema sinistra, viene ad esempio avallata, in maniera equivoca, dal gruppo
Endnotes [*2] nel 2019, che descrive quale sia per l'ultra-sinistra contemporanea, per i comunisti di estrema sinistra, o per la sinistra comunista
[*3] la scelta apparente, ma falsa - per come viene considerata - in quanto descritta come una scelta tra «
intervento rivoluzionario e attendismo».
Vale a dire che, «
o c'è un modo comunista rivoluzionario di relazionarsi alle lotte, oppure uno dovrebbe disinteressarsene del tutto». Loro risolvono quella che è una falsa scelta, tornando a riferirsi al concetto (di Marx ed Engels) di comunismo in quanto «
movimento reale»
[*4], affermando che «
non siamo noi, ma è la lotta di classe che produce teoria.» Ma
Endnotes non si rende conto che non esiste qualcuno che possa «
non essere coinvolto per niente». Anche i morti sono coinvolti in quello che è il nostro presente, come aveva notato Marx: «
Le mort saisit le vif!» .
Certo, in pratica, sia i millenaristi tranquilli e senza partito, anti-"politici", che i rivoluzionari anti-avanguardia (come
Endnotes) sono comunque coinvolti negli eventi - che si tratti di prepararsi ad imparare ad essere più vicini a Dio, oppure di avvicinarsi, come diceva Marx, al «
vero [reale]
movimento che abolisce le attuali condizioni»
[*5], o che si tratti semplicemente di attrarre gli altri verso il proprio punto di vista in modo da far crescere il numero dei beati, cosicché all'ora stabilita, quando Dio appare in tutta la
Sua furia, o quando il proletariato si solleva, ci siano abbastanza credenti per portare dalla propria parte coloro che ne sono degni. Va notato che anch'io, come metà dei produttori del libro - o «
artefatto archeologico» -
Nihilist Communism, sono stato un millenarista. Il nostro consiglio a coloro che, come noi (ci chiamavamo
Monsier Dupont), voleva la grande trasformazione che avrebbe portato pace e armonia, ma che vedeva il suo arrivo come proveniente dalla lotta di classe e dall'intervento dei "
rivoluzionari", piuttosto che da Dio, era quello di: «
prepararsi ad una lunga attesa, non avere grandi aspettative, essere pronti a fallire, e continuare per decenni.»
Ora, si confrontino queste ultime istruzioni, con quest'appello, con la
Parabola del Seminatore, dalla
Bibbia di Re Giacomo: «
Ora, la parabola è questa; Il seme è la parola di Dio... [e si reputa che sia caduta su un buon terreno quando coloro che ascoltano la parola]
la conservano e la fanno fruttificare con pazienza. » Oppure, con questo proveniente dal
Libro dell'Apocalisse, in cui Dio scrive lettere a "
sette chiese" per mezzo di visioni date ad un profeta, «
Conosco le tue opera, e la tua fatica, e la tua pazienza... E [il modo in cui] hai sopportato , ed hai avuto pazienza, e per amore del mio nome hai lavorato e non hai perso i sensi. » Forse, il ripetersi inconsapevole di una simile direttiva, quasi 2.000 anni dopo, è un esempio di un'eterna ricorrenza...
Lo Stato - o quello che ci opprime, qualunque cosa esso sia - verrà sempre criticato. Lo Stato necessariamente, o naturalmente, crea le condizioni per tale critica, e, quindi, i millenaristi - vale a dire, i rivoluzionari - sono funzioni dello Stato. Essi non appaiono laddove non c'è uno Stato. Non compaiono nelle società non statali. Ma, in maniera contro-intuitiva, la critica dello Stato o quella delle "
condizioni attuali" non è dannosa per lo Stato (sebbene ciò possa essere dimostrato per mezzo di alcuni particolari elementi della gerarchia statale). Infatti, essa è necessaria per quello che è il suo sviluppo oggettivo, come attestato dagli esempi registrati almeno a partire dalla guerra civile inglese. Ovunque ci si stata una rivoluzione, lo Stato è diventato più forte, e lo sfruttamento della classe operaia è stato intensificato, è diventato più brutale, ed è stato reso più efficiente, quanto meno per un breve periodo.
Le rivoluzioni inglese e francesi hanno consentito l'ascesa istituzionale della borghesia: la nuova classe dirigente, così come la nuova classe media, la burocrazia. Entrambe le rivoluzioni hanno permesso ad ambedue i Paesi di mantenere ed espandere la loro posizione di potenze mondiali. La Rivoluzione russa è facilmente riconoscibile come rivoluzione dei figli delle classi medie emergenti - i burocrati - i quali hanno introdotto l'industrializzazione ad una velocità e su una scala senza precedenti. Anche i comunisti cinesi hanno introdotto il capitalismo industriale a velocità vertiginosa; e non fatevi ingannare dal fatto che si siano chiamati "
comunisti". La stessa cosa si può dire di quei paesi «
in via di sviluppo», come Cuba, dove l'industrialismo è stato introdotto in una regione rurale sotto la bandiera del comunismo o del socialismo. Ragion per cui, i rivoluzionari, nel grande schema, non sono una contro-funzione dello Stato e del capitale, me ne sono solamente delle funzioni: aiutano lo sviluppo dell'economia ed il controllo delle classi lavoratrici.
Camatte, osservando la storia del ventesimo secolo, ha scoperto che in questo periodo la natura del capitalismo è cambiata di modo che, come si è detto, «
più lottiamo contro il capitalismo, più lo rafforziamo », ma si sarebbe potuto fare quest'osservazione anche a partire da tutte le rivoluzioni dell'era capitalistica, a cominciare da quella inglese. Per cui, è forse più corretto , o quanto meno universale, dire: più lottiamo contro lo Stato, più lo rafforziamo. Ovviamente, nella nostra epoca non esiste una chiara linea di demarcazione che divide lo Stato e l'economia - o lo Stato ed il capitale, anzi, nel capitalismo lo Stato ha realizzato il matrimonio perfetto - la natura ubiqua, globale e totalizzante del nostro sistema economico fa sì che immaginare l'esistenza di uno Stato che non sia sia capitalista costituisca solo una stravagante fantasia risibile e ridicola.
Camatte ha di certo cercato, più o meno consapevolmente, di sottrarsi alle bassi millenarie delle sue originali appartenenze politiche. Ciò è dimostrato dal suo assoluto rifiuto di dar parte di qualsiasi "
organizzazione", e il suo insistere sul fatto che ciò per cui ora si batte non ha a che fare con nessun tipo di politica. Eppure, anche nella sua visione dell'arrivo di una nuova specie umana egli continua a soddisfare il criterio millenario: il Millenarismo, che può essere religioso o laico, è la convinzione che la società umana abbia bisogno di una grande trasformazione, e che dopo questa le persone vivranno in pace ed in armonia. E continua ancora a coinvolgersi con le persone, ancora produce testi, e fa sapere agli altri circa quale possa essere un modo migliore di pensare. Il suo millenarismo, però, come quello di
Endnotes, o quello di
Monsieur Dupont, è di quelli tranquilli.

Una Contraddizione?
Camatte sostiene che la lotta di classe è finita da tempo poiché, come hanno dimostrato i protagonisti nel corso degli eventi "rivoluzionari" nel periodo intorno alla prima guerra mondiale, l'unica cosa che la classe operaia è in grado di realizzare non è il comunismo ma il capitalismo autogestito, dal momento che i suoi obiettivi sono «la piena occupazione e l'autogestione». Pertanto, egli sta sostenendo che qualsiasi lotta rivoluzionaria contro il capitale che si basi sulla classe operaia (ora defunta in quanto potenziale creatrice di comunismo), dopo la gloriosa menzogna del momento rivoluzionario, ci restituirà solamente il capitale in una sua forma più forte e più feroce.
Ma è ancora peggio. Così come non esiste più alcuna vera classe operaia - assorbita all'interno del capitale - allo stesso modo non ci sono più classi, la società non è più organizzata sulla base di una relazione sociale viva (per quanto cattiva potesse essere)... il capitale è «sfuggito» al controllo della borghesia ed ora funziona come un sistema autonomo. Tutti gli esseri umani ora sono capitalizzati, vale a dire, sono tutti disperatamente appesi alle falde della giacca del «mostro automatico» del capitale che prosegue - come se fosse un robot, o uno zombie (visto che esso ormai è una cosa morta, e non più una relazione sociale) - nel proprio percorso.
Come fermare il mostro? Camatte ha già scartato la possibilità di opporsi ad esso, dal momento che questo non farebbe altro che rafforzarlo - poiché nel nostro opporci agiamo sul suo stesso terreno, vale a dire, alle sue condizioni. Quindi Camatte sostiene che per fermare il mostro bisogna abbandonarlo, e non in maniera politicamente organizzata - dal momento che questo sarebbe la creazione immediata di un'opposizione: di un'inimicizia. Tutti noi, dobbiamo cominciare ad abbandonare «questo mondo così com'è», in qualche modo, organicamente, scegliendo di vivere delle vite differenti. Se faremo questo allora non solo lo zombie-capitale morirà di fame, ma dopo qualche migliaio di anni la nuova specie sarà emersa pienamente, e gli esseri umani vivranno in comunità con la natura e con sé stessi.
Ma se le persone sono già capitalizzate (Camatte descrive questo come la loro follia), ciò significa che se combattono il sistema non fanno altro che renderlo più forte, e questo non implica forse che se abbandonano il sistema si porteranno dietro con loro anche il proprio cervello capitalista, sebben, in quanto oppositori, non intendono farlo? Non è forse vero che ogni fuga dal capitale o dallo Stato, o dalle cose come sono, da ogni setta, o movimento - dai vichinghi, che sono sfuggiti al fiorente potere del regno in espansione di Harald Finehair stabilendosi in Islanda, alla tragedia di Jonestown – andati da qualche altra parte a fondare un mondo nuovo, ha finito per portare dietro con sé anche la malattia? Il problema è incentrato sulla possibilità che si possa ottenere un vero cambiamento nella propria vita, come individuo o come gruppo. Se si è disposti al cambiamento, ecco che allora è logico supporre che immaginare il cambiamento emerga a partire dalle circostanze stesse della cosa cui ci si oppone; il cambiamento desiderato è condizionato dai parametri della cosa originale alla quale si cerca di sfuggire. Siamo esseri sociali, siamo costituiti socialmente, possiamo vedere il mondo solo attraverso la nostra prospettiva, sebbene siamo in grado di riconoscere che ci possono essere anche altre prospettive. Qui, è utile, al fine di spiegare cosa intendo, pensare a come il concetto di tempo viene percepito in due epoche diverse: l'era moderna (capitalismo), ed il Medioevo europeo (feudalesimo). Così noi riusciamo, per esempio, a capire ciò che ci viene detto quando c'è chi sostiene che i contadini medievali vivevano secondo un calendario ciclico che era il prodotto dell'esistenza agraria ma che, nonostante ciò non siamo in grado di vedere il tempo come se fosse una rotazione, dal momento che non possiamo partire da questo per accettare con facilità di buttare via il concetto che il tempo sia lineare. Come scrive lo storico A.J. Gurevich a proposito della transizione dalla concezione del tempo feudale a quello capitalista urbano: « L'alienazione del tempo dal suo contenuto concreto ha fatto sì che aumentasse la possibilità di vederlo come se fosse una pura forma categoriale, come se la sua durata non fosse appesantita dalla materia. » È stato questo il successo dell'economia moderna, la quale aveva bisogno di coordinamento per poter operare in maniera efficiente, e questo ha cambiato la nostra concezione del tempo. È stata l'introduzione delle catene di rifornimento, di distribuzione, e del lavoro di fabbrica, culminato negli orari ferroviari, che ha portato ad abbandonare ogni senso di quel tempo che era «ciclico», «stagionale», o connesso con la terra. E questa espressione lineare del tempo si trova ad essere ormai radicata nei nostri cervelli.
Non possiamo vedere attraverso gli occhi di una persona abituata ad una modo di vita diverso. La nostra coscienza è determinata dalla vita quotidiana che viviamo, ed i principi ed i valori generati da questa esistenza retroagiscono a loro volta su tale esistenza quotidiana. Una volta che una società si è stabilita, ecco che allora questa società diventa un insieme organico, un modo di vivere (non necessariamente un'«economia»). Un parigino del ventunesimo secolo può decidere di comprendere il tempo come se fosse ciclico quanto un contadino medievale europeo avrebbe potuto decidere di comprendere il tempo come se fosse stato una linea categoriale separata dell'universo. Ci si può rendere conto come un cambiamento possa assai spesso essere impossibile a partire solamente dalla volontà. Il vero dolore per una persona cara, per esempio, non può essere semplicemente allontanato e cancellato, esso si attenua lentamente nel tempo, oppure viene dimenticato grazie al sopravvenire di un altro interesse, di un'altra passione (a condizione però che tali interessi non vengano assunti specificamente, al fine di dimenticare il proprio dolore, perché in tal caso si trasformerebbero in un continuo promemoria). Di conseguenza, ecco che allora diventa vero dire che la soluzione per disabilitare il dolore non proviene dal nostro pensare ad esso in modo da collocarlo in prospettiva, bensì dal tempo. I veri cambiamenti - o soluzioni - ci vengono sempre proposti ad un livello diverso dalla nostra volontà cosciente.
In un'articolazione, o estensione, della proposizione materialista storica di Marx – « Gli uomini fanno la propria storia, ma non la fanno in modo arbitrario, in circostanze scelte da loro stessi, bensì nelle circostanze che trovano immediatamente davanti a sé, determinate dai fatti e dalle tradizioni preesistenti e tramandate. » - lo studioso marxista Ernest Mandel ha formulato quello che è il meccanismo "determinismo parametrico". Si tratta di un concetto utile nel momento in cui si pensa a quelli che sono i limiti relativi alla nostra comprensione di altre epoche, o di altre culture ... o di altri animali: « La gran parte, se non tutte, delle crisi storiche hanno diversi esiti possibili, non innumerevoli, fortuiti o arbitrari; è questo il motivo per cui usiamo l'espressione "determinismo parametrico" per indicare diverse possibilità all'interno di un dato insieme di parametri. »
Possiamo sostituire la parola «crisi storiche» con «situazioni», o persino con «chimere». Dal momento che il punto è che siamo i prodotti della società in cui siamo nati. Non possiamo semplicemente voler essere di per sé i prodotti o le funzioni (o i riproduttori) di un'altra società (per esempio, di «una società veramente comunista»), non importa quanto ci sentiamo vicini a comprendere quella particolare organizzazione sociale che stiamo osservando o che stiamo considerando. I cambiamenti radicali nella società - come la transizione dal feudalesimo al capitalismo - non accadono a partire dalla volontà umana, ma avvengono ad altri livelli. Le rivoluzioni che hanno reso ufficiale il capitalismo - come quella inglese, quella francese e quella russa - sono state l'istituzionalizzazione, o la ratifica, di una forza economica che aveva già raggiunto un predominio reale. Certo, Camatte stabilisce che l'emergere del nuovo essere umano richiederà migliaia di anni e che forse, perciò, sta riconoscendo quale sia il problema nel cambiare la propria prospettiva, o nel cambiare il proprio modo di vivere. E forse sta sostenendo che se noi facciamo solo ora certi cambiamenti - cambiamenti che sono connessi alla «naturalezza» che continua a permanere dentro di noi - allora ci metteremo sulla strada per poter diventare la nuova specie... Io non sono poi così sicuro della mia «resistenza» alle idee particolari di Camatte, e mi torna alla mente quella che è in Candide la soluzione di Voltaire, cui arriverò più avanti.
In fondo, nell'esortazione di Camatte che ci spinge a lasciare questo mondo c'è un «problema»... la logica dei suoi scritti ci obbliga a domandarci in che modo, nel «lasciare il mondo», non ci limiteremo solamente a prendere il mondo ed a portarlo con noi. Se non siamo in grado di combatterlo senza che questo lo renda ancora più forte, allora può essere che forse non possiamo nemmeno lasciarlo senza che questo lo renda ancora più forte. Dopo tutto, il capitale è il recuperatore per eccellenza. Ed anche il détournement è diventato un mezzo per fare soldi.
La Comunità Umana Già Esistente
Camatte propone che tutte le ribellioni che si legano alla brama di una comunità umana, vale a dire, quelle ribellioni, o movimenti che per esempio in passato si richiamavano alla «fratellanza universale»[sic] o al mutuo appoggio - dal momento che si tratta di appelli che si ricollegano alla Gemeniwesen perduta - devono essere visti come l'inizio del processo di inversione: il processo di riconquista della vera comunità umana. Il problema è che il capitale si è sviluppato a tal punto che la maggior parte di questi inizi, se esistono sotto forma di progetti politici organizzati, sono del tutto inutili. Affinché tali inizi - come abbiamo visto con il muto appoggio e con la solidarietà reciproca durante i recenti avvenimenti attinenti al Covid-19 e al movimento Black Lives Matter - possano essere efficaci e non recuperabili, essi devono svilupparsi in delle situazioni nelle quali gli individui comuni non fanno più affidamento o riferimento al sistema al fine di cambiarlo. Bisogna che le persone inizino piuttosto a vivere in maniera differente, che vivano una vita che possa abbracciare questi valori umani. Il rovesciamento, l'inversione può avere inizio solamente quando viene meno un sentimento di inimicizia, e quando non c'è più la sensazione che ci sia bisogno di qualche puntello ideologico, tipo la «classe operaia», o la «giustizia», per poter giustificare le proprie azioni. Se facciamo a meno del concetto e dell'immagine nefasta del nemico e dell'amico - per esempio, i padroni e la classe operaia - possiamo provare a cercare di vivere. La speranza di Camatte è quella che ci sarà un abbandono di quello che è l'attuale modo di vivere quando la gente si renderà conto della follia che ha dovuto sopportare. Come si è già detto, Camatte prevede che la nuova specie umana impiegherà migliaia di anni per poter emergere pienamente. Per poter assistere la nascita di una tale nuovo essere, Camatte suggerisce una serie di misure pratiche che devono essere in qualche modo attuate il più presto possibile. In "Emergenza e Dissoluzione", Camatte elenca alcuni di questi cambiamenti, che includono: « La cessazione immediata della costruzione di strade, autostrade, aeroporti, porti e città; l'abolizione del turismo, la più elaborata forma di distruzione dell'uomo, della donna e della natura; e l'abolizione dello sport, "un'attività assurda, una forma teatrale di competizione capitalistica, e un sostegno fondamentale per la pubblicità. »
Quando si legge la "lista delle richieste" di Camatte su questo articolo del 1989, è difficile non percepirle come se fossero delle misure potenzialmente autoritarie da mettere in atto per il bene del pianeta, e in una nota a piè di pagina aggiunta nel 2008 Camatte commenta che: « sarebbe stato meglio avere scritto [solo] "cessazione", poiché "proibizione" [così come per cessazione, nella lista, usa il termine "proibire" o "vietare"] inevitabilmente evoca e richiama la repressione. » Tuttavia, c'è da chiedersi come si possa riuscire a fermare cose come i progetti edilizi, il turismo e lo sport senza entrare a far parte di un governo, o senza combattere contro questi fenomeni. A meno che tutti gli operai edili, i turisti e gli appassioni di sport non rimangano a casa a curare il proprio orto e i loro giardini, e non rimangano a casa con il televisore acceso... causando il collasso di tutte queste industrie.
In questa visione di una massa di umanità che semplicemente «lascia il mondo» per prendersi cura del proprio giardino - un fenomeno che ovviamente richiede uno sforzo collettivo, o una cooperazione comune - c'è un fascino stranamente potente. Forse, l'essenza dell'inizio dell'«inversione» di Camatte - vista come un «abbandono di questo mondo» - può essere compresa in termini pratici facendo ricorso al suggerimento di Candido alla fine dell'omonimo romanzo di Voltaire - quando dice che nel momento in cui ci chiediamo cosa ci piace di più del mondo, la cosa più utile è quella di «coltivare il proprio giardino». Candido dice questo dopo che lui e la sua «petite société» si sono ritirati dalle attività mondane e si sono concentrati sul proprio sostentamento con i loro mezzi, imparando ogni sorta di abilità, e ad essere utili l'uno all'altro. Come sottolinea uno di loro: « Lavoriamo senza discutere, in quanto è il solo mezzo per rendere la vita sopportabile. » Se si decide di seguire Camatte, bisogna seguire anche Candido?
Tornando al concetto secondo cui ci vorranno migliaia di anni affinché questa nuova specie umana comunitaria possa crescere fino a raggiungere la maturità, forse bisogna - nonostante l'indicazione di Camatte sia quella che la specie formerà una vera comunità umana - sentire che non possiamo sapere come sarà veramente questa comunità. La nuova comunità, la nuova specie che egli predice è qualcosa di impossibile da descrivere, se non per mezzo di indicazioni parziali, e ciò ha delle profonde implicazioni nel momento in cui si ricordano le società di «tribù» in tutto il mondo, le quali hanno pochi, o nessun contatto con l'economia globale: anche per noi diventa impossibile riuscire a comprendere appieno queste popolazioni. Queste sono le società - come ha spiegato Pierre Clastres - che sono «contro lo Stato». Camatte si riferisce al lavoro di Pierre Clastrers un paio di volte, ma solo brevemente. Ne "La Rivoluzione Integrata" (1978), Camatte sembra riconoscere l'organizzazione sociale centrifuga delle "primitive" società (non statali) descritte da Clastres, in quanto preziose al fine di resistere alla minaccia dell'omogeneità e alla perdita delle diversità tra comunità - cosa che si realizza attraverso la "violenza", o la "guerra" - ma egli non ritiene che «per noi» questa possa essere una strategia appropriata, dal momento che la società è già stata omogeneizzata, e qualsiasi ricorso ad una violenza che amplifichi le diversità non sarebbe altro che una mera violenza "cieca" senza alcun riferimento adeguato. È un peccato che Camatte consideri le osservazioni e le teorie di Clastres come se fossero solo uno strumento per rettificare i difetti della società civile, respingendole troppo alla svelta, anziché esplorarle ulteriormente. Clastres stesso non ha mai suggerito che l'organizzazione sociale delle società non statali che ha conosciuto in Amazzonia dovesse essere ripresa, nella civiltà, dai movimenti radicali. Egli si è limitato semplicemente a notare come «i selvaggi» abbiano resistito allo Stato - in qualche modo - per molto tempo, e come essi rappresentassero effettivamente gli ultimi esseri umani.
Cosa possiamo imparare - usando una lente camattiana - dall'etnografia di quelle popolazioni che vivono al di fuori dello Stato? Clastres suggerisce che l'obiettivo di queste società non è «pace ed armonia», non è l'unificazione. La «comunità» che esiste all'interno dei gruppi e tra i gruppi è operativa a livelli diversi da quelli che possiamo comprendere. I loro "nemici" sono più vicini a loro di quanto potranno mai esserlo i nostri "amici", l'inimicizia si trova ad essere radicata nella loro concezione di relazioni con sé stessi, e con gli altri, anche con i morti. Questa è una delle indicazioni del problema che Camatte definisce parlando di come sarà una vera comunità umana... non può saperlo. Le basi di questo concetto di vera comunità umana proviene dall'Illuminismo e dalle idee di democrazia. Egli, come tutti noi, è un erede delle idee di Spinoza e di Marx, le quali riflettevano le implicazioni radicali dell'Illuminismo, una fenomeno che a sua volta rifletteva la crescita del capitalismo come forma di società. "I selvaggi", come ha osservato Clastres, non vogliono la pace. La pace, fin dalla costituzione del primo Stato, è stata sempre il premio per gli schiavi. In quanto sudditi di uno Stato, naturalmente, è questo quello che vogliamo anche io e Camatte. Ma ci si dovrebbero tenere simili obiettivi per sé stessi, e non proiettarli sui popoli non statali. L'altra cosa che si potrebbe scoprire, se si estende l'analisi di Camatte, o quella di Cioran - che conclude che gli esseri umani sono in discontinuità con la natura, e quindi psicologicamente traumatizzati, ed ora anche obsoleti - alle «tribù non contattate», è che ci sono due tipi di «esseri umani» sul pianeta... ma solo un tipo può davvero chiamarsi "umano".

Il Secondo Tipo
Secondo Camatte, gli "esseri umani" che non possono essere definiti veramente umani, incluso me stesso e tutti gli altri che sono prodotto e funzione - non della Terra da cui abbiamo avuto origine ma - dell'economia che conosciamo come capitalismo... sia che essi raccolgano i benefici provenienti dalla «ricchezza» demente che il capitalismo genera, sia che lottino per poter sopravvivere nelle profondità della follia che è costituita dal rovescio della follia del progresso e dell'avanzamento tecnologico. Sono assolutamente d'accordo con Camatte, sul fatto che i cosiddetti umani (tu ed io) sono delle finzioni, o delle creazioni - come se fossero dei gusci vuoti - riempite da un'incontrollabile ed autonoma economia che ha reciso tutti i loro legami - ben oltre qualsiasi fantasticheria romantica e al di là di ogni falsa rivendicazione - con gli altri animali e con la Terra stessa. [*6] Come ha fatto questo essere umano a venire al mondo? Visto che sto parlando di una specie di essere umano che vive in uno Stato, devo perciò chiedermi perché e come sia emerso lo Stato. Su questo, da parte di tutti i settori dello spettro politico ed accademico, esiste un bel po' di mistificazione, ma, come ho cercato di dimostrare altrove, anche se non possiamo conoscere le circostanze specifiche dalle quali hanno avuto origine - "originarie", vengono chiamate - gli Stati, ne possiamo capire il perché: lo Stato è una soluzione manageriale al problema della popolazione, la quale è diventata troppo numerosa per poter continuare a mantenere i modi di vivere tradizionali.
La maggior parte delle narrazioni che riguardano l'emergere dello Stato cominciano con l'ascesa di un capo che bullizza la gente, e la cosa porta ad una Famiglia Reale, che porta a sua volta al costituirsi di una corta che alla fine forma una burocrazia. Ed è poi questa burocrazia, quella che esercita il vero potere. Poi la burocrazia si diffonde sul territorio e diventa una sorta di proto-democrazia chiusa. Alla fine, ci sono così tante persone che contribuiscono alla gestione diretta dello Stato per mezzo di supervisori - la nascente «classe media» - per cui all'imprenditorialità appare chiaro che il potere reale si trova in quelle mani e che dovrebbero riconoscere tale potere. Viene così dato inizio ad un movimento che si basa sulle nuove circostanze. Oliver Cromwell era un proprietario terriero. Gerrard Winstanley - il leader dei Diggers, l'estrema sinistra dei rivoluzionari della "Guerra Civile Inglese" - era un uomo d'affari della classe media. Robespierre era un avvocato. Lenin apparteneva notoriamente alla classe media. Fidel Castro era nato in una ricca famiglia di agricoltori e aveva studiato legge all'università. Guevara era un medico. I lavoratori e i contadini vanno loro dietro perché anche ad essi piace questa nuova idea "democratica", e perché hanno bisogno di un miglioramento della propria vita - infatti, naturalmente, la vocazione rivoluzionaria può fare la sua comparsa, e può svolgere la sua funzione, solo se i lavoratori e i contadini si trovano già ad un certo livello di rivolta. Allora ha luogo una rivoluzione (qui, non stiamo parlando di "rivolte"), a volte sanguinosa. I nuovi leader si rendono conto che i lavoratori e i contadini hanno un'idea leggermente diversa circa come dovrebbero procedere le cose e danno inizio alla repressione. Spesso, i primi leader della rivoluzione vengono eliminati, e ne subentrano di nuovi, con un'agenda più ragionevole.
Condivido tutta questa narrazione, tranne che per la primissima parte. Le mie ricerche su come le popolazioni precedenti all'ascesa dello Stato (compre le attuali «tribù non contattate») si erano organizzate socialmente, mostra come una delle priorità fosse quella di mantenere ridotto il numero di individui che facevano parte del gruppo, e qualora il numero iniziasse ad aumentare questi gruppi dovevano "scindersi" - suddividersi. Robin Dumbar ha svolto una famosa ricerca su quali fossero le dimensioni ottimali dei gruppi, e sostiene che, per operare con successo senza alcuna coercizione, essi devono essere in grado di avere delle regolari interazioni faccia a faccia - ciascuno deve conoscere tutti gli altri. Una volta che il gruppo dovesse diventare troppo numeroso perché tutti si conoscano, ecco che diventa necessario stabilire delle leggi. La mia ricerca suggerisce che l'elemento chiave nell'emergere di un nuovo Stato - Mesopotamia, Indo, Meso-America, ecc. - non sia stata né l'agricoltura né le valli alluvionali, bensì il fatto che ci sia stata una crescita della popolazione, e che per qualche motivo inconoscibile il gruppo non sia stato in grado di dividersi. La narrativa classica relativa all'ascesa di un capogruppo/Stato è quella dove un teppista rapace organizza un gruppo e assume il controllo della tribù. Ma quella che è la documentazione antropologica suggerisce che gli esseri umano sono stati in grado di resistere ai furfanti vanitosi per migliaia di anni. E come mai continuano tuttora ad esistere delle tribù "egualitarie" al di fuori degli Stati? Ci dev'essere qualcos'altro. Molti antropologhi e storici suggeriscono che i progressi della tecnologia - per esempio, l'irrigazione - aprono la strada alla crescita del numero di persone e alla riduzione in schiavitù delle persone. Ma come mai le moderne «tribù non contattate» non hanno inventato tecniche agricole moderne, incrementando così il proprio numero e non hanno creato una dittatura spietata in cui servire? Sono semplicemente stupidi?
Il motivo per cui sono emersi dei capi potenti è dovuto al fatto che la popolazione ha accettato con riluttanza che le nuove circostanze richiedessero un nuovo modo di organizzare le cose. Ciascuno non conosceva più tutti quanti gli altri, e chi voleva poteva farla franca, si potevano formare delle combriccole, potevano essere commessi dei "crimini". Dovevano essere fatte delle leggi e le persone dovevano osservarle - ma quelli che non amavano le leggi, si limitavano ad ignorarle. Alla fine, e questo probabilmente è successo rapidamente, una persona carismatica ha colto l'occasione per auto-esaltarsi... e alla fine la popolazione ha accettato. Un leader forte sostenuto da dei furfanti avrebbe quanto meno mantenuto un po' di pace. Naturalmente, di solito il potere finisca per dare alla testa del Capo e le atrocità divenivano la norma, e nel caso che il popolo non fosse del tutto sottomesso avrebbe potuto appoggiare il tentativo da parte di un Capo rivale di prendere il posto di quello attuale... e così è stata scritta la storia... fino alla Democrazia Rappresentativa. In sé, lo Stato non è né il bene né il male, ma è solo una soluzione manageriale al problema di una popolazione numerosa. Si immagini la scena, due persone sedute sotto una parete rocciosa che discutono del futuro:
« Sì, Enki e la sua banda ritengono di poter risolvere ogni problema, a patto che tutti facciano quello che dice e gli rendano omaggio mandando le figlie ed i figli a lavorare per lui, costruendogli in tal modo un buon posto dove dormire. In questo modo, il posto in cui viviamo sarà un posto migliore in cui vivere, ci sarà meno caos, però dovremmo restare dove siamo e lavorare ancora più duramente, in modo da risolvere i suoi problemi, così ci potrà ricompensare. Quello che non vogliamo è che egli aizzi i suoi scagnozzi contro di noi, però sarebbe bene che egli sistemasse quei pigri ladri bastardi che vivono vicino ai cespugli di ceci...»
Lo Stato viene visto spesso come se fosse un ostacolo agli ideali di pace e di amore - ed al comunismo - ma forse il fatto potrebbe essere che non c'è alcuna via di fuga da uno Stato autoritario quando ci sono così tante persone ammassate tutte insieme? Forse è proprio questa una delle tante lezioni della Rivoluzione russa? (Chiunque suggerisca qui che forse la via della pace, dell'amore e del comunismo doveva appunto essere quella di ridurre la popolazione umana - ed oltre ad esprimere quale sia il vero Male - non si rendo conto che, in quanto funzione del capitalismo, avrebbe semplicemente ricreato il capitalismo in una nuova situazione, proprio come hanno fatto i bolscevichi nel 1918.)
Jean-Jacques Rousseau scelse la libertà che esisteva prima dell'avvento dello Stato e della civiltà, ma riconobbe il fatto che vivere in una società in cui ciascuno - a prescindere da quale fosse il suo ruolo nella gerarchia - dipendeva da ogni altro significava anche che gli esseri umani non potevano tornare indietro. Egli decise che bisognava trarre il meglio da quello che era un pessimo lavoro, e fu questo il messaggio che diede nel suo libro "Il Contratto Sociale". Naturalmente, il libro di Rousseau venne usato dai Giacobini per giustificare la loro dittatura parigina nel 1793-4, come scrive David Wootton nella sua introduzione a "Basic Political Writings" di Rousseau: «Robespierre e i Giacobini lo ammiravano molo, ma lo avevano profondamente frainteso (il loro Rousseau era stato inventato per servire quelli che erano i loro scopi).» L'approccio pratico ed umano - ed anti-millenarista - di Rousseau, secondo cui saremmo intrappolati in quello che potrebbe essere ironicamente definita una società meno che soddisfacente, è stato ripreso molto più tardi da parte di scrittori che erano stati testimoni, o avevano considerato l'esito millenario della Rivoluzione russa, come Albert Camus.
Nel 1951, rivendicando la ribellione - vale a dire, un'opposizione a tutte le forme di dittatura - in contrapposizione alla rivoluzione, egli scriveva: «invece di uccidere e morire per produrre l’essere che non siamo, dobbiamo vivere e far vivere per creare quello che siamo.» E continuava: « O il rivoluzionario esprime simultaneamente la rivolta o non è più un rivoluzionario, ma un poliziotto e un funzionario che alla rivolta si oppone. Ma se è fedele a questa, finisce per insorgere contro la rivoluzione. Cosicché non c’è progresso da un atteggiamento all’altro, ma simultaneità, e contraddizione continuamente crescente. Ogni rivoluzionario finisce per essere un oppressore o un eretico. Nell’universo puramente storico che ha scelto, rivolta e rivoluzione sfociano nello stesso dilemma: polizia o follia. »
Vasily Grossman, scrivendo a proposito della collettivizzazione sovietica e della carestia in Ucraina nel 1932-3, per mezzo del personaggio di Anna Sergeyevna, in "Tutto scorre": « Adesso, quando ricordo l'abolizione dei kulaki, vedo tutto in modo diverso, l'incantamento è passato. Vedo in loro degli uomini. Perché mi ero tanto indurita? Come soffriva la gente, quante gliene facevano! E io a dire: non sono uomini, questi, è solo kulakaglia. E poi rivango, rivango e penso: chi ha inventato quella parola: kulakaglia? Che sia stato Lenin? Quale tormento si è addossato! Per ucciderli, si è dovuto spiegare che i kulaki non erano uomini. Sì, come quando i tedeschi dicevano: i giudei non sono uomini. Allo stesso modo Lenin e Stalin: i kulaki non sono uomini. Ma questa è una menzogna! Uomini! Uomini erano. Ecco ciò che principiai a capire. Tutti uomini! » [*7]
Il Primo Tipo
L'altro tipo di essere umano è quello che vive ancora nelle foreste, sulle colline o nelle pianure, evitando l'avanzata della civiltà. Ma la loro esistenza è precaria e sta diventando più fragile ogni giorno che passa. Queste popolazioni sono gli ultimi esseri umani.
Non possiamo sapere chi siano veramente questi uomini poiché incontrarli significa portare loro tutte le nostre malattie psicologiche e biologiche. Ma ciò che riusciamo a sapere, dalla letteratura degli antropologi ( e ne abbiamo abbastanza di essa - non c'è bisogno di alcun studente di antropologia in erba , o di qualche professore esotico che possa invadere gli spazi di questi esseri umani), è che questi popoli non lavorano; essi non hanno un'economia; non hanno gerarchie; non hanno il controllo sociale come noi lo conosciamo; non hanno denaro; non hanno storia, ma hanno una memoria collettiva; non cercano di conquistare il mondo; non hanno libri; non distruggono la natura; non mancano di rispetto agli altri; non trattano con disprezzo gli altri animali; vivono per il godimento e per la gioia reciproca... A proposito dell'Homo Gemeinwesen, "la specie che succederà all'Homo sapiens", come si è già detto, Camatte scrive:
«Sarà in continuità con la natura e con il cosmo. La sua conoscenza processuale [il suo divenire o, volgarmente, la sua coscienza] non eserciterà una funzione giustificatrice, dal momento che essa opererà unicamente all'interno della dinamiche di godimento. [...] È ovvio che questo non potrà essere un ritorno al genere di nomadismo praticato dai nostri lontani antenati, i quali erano dei raccoglitori. Uomini e dono acquisiranno un nuomo modo di essere che va al di là del nomadismo e del sedentarismo. La vita sedentaria, combinata ed aggravata dall'inattività corporea, è alla radice, e la prima causa di quasi tutte le malattie somatiche e psicologiche degli attuali esseri umani. Una vita attiva e non fissa curerà tutti questi problemi senza dover fare uso di medicina o di psichiatria.»
La descrizione che fornisce Camatte è notevole dal momento che essa descrive delle comunità che già esistono, delle tribù che oggi non sono state contattate - questi esseri umani sono già qui. Essi vivono accanto a noi.
Anche la citazione di Marx usata all'inizio di questo testo , viene qui utilmente ripetuta – « Quanto meno tu sei, quanto meno realizzi la tua vita, tanto più hai; quanto più grande è la tua vita alienata, tanto più accumuli del tuo essere estraniato. » - poiché l'elenco di ciò che possiedono i popoli non statali può essere scritto solo da persone civilizzate come noi. i quali in linea di massima non hanno ciò che hanno loro. Si tratta di un'indicazione di quanto siamo separati da loro sotto tutti gli aspetti.
Le popolazioni non contattate e i popoli indigeni ( i quali sono difesi dall'organizzazione "Survival Internazional") sono gli ultimi esseri umano. Essi sono la rivoluzione che c'è sempre stata qui. Non sono «caduti in disgrazia» come abbiamo fatto noi. Non si sono imbarcati in un'inesorabile erranza - o storia - che ha portato il mondo fino al punto di un completo collasso ecologico. Non vivono nella fatica del lavoro e nella vuota disperazione; non hanno avuto il loro spirito e la loro umanità svuotata per mano loro.
Quanto a noi, ci troviamo intrappolati in un mondo che non potrà mai essere rese perfetto dal momento che dovrà essere sempre gestito e amministrato. E forse non abbiamo nemmeno davvero tutto questo gran controllo su quello che facciamo, sulle scelte che possiamo fare... dato che non abbiamo alcun controllo su ciò che siamo. Forse il meglio che può essere realizzato «politicamente» è continuare a cercare di opporsi all'«ingiustizia», e all'«oppressione», continuare a resistere alla dittatura, anche se continuerà inevitabilmente a ritornare. Si potrebbe anche cercare di aiutare i popoli senza stato a rimanere nelle loro terre, separate dal nostro mondo... ance se tutto questo ha superato i suoi limiti ed è andato troppo oltre... ed il collasso ecologico - che si prevede comincerà seriamente a partire da circa il 2040 - finirà per portarci via tutti.
- Peter Harrison – Pubblicato nel Giugno2020 su Il Covile-
NOTE:
[*1] - Il termine usato da Cioran, appare essere la parola "divagante", che sarebbe forse meglio tradotta con "vagabondo", o "randagio". Altrove, egli usa il termine "divagazione" in una varietà di contesti, che andrebbero tutti tradotti con "vagabondaggio" e simili. La parola "divagazione" - sia in inglese che in italiano - ha anche il significato di digressione, deviazione, ecc. Camatte [curiosamente, come avviene anche nella traduzione del libro di Cioran offerta da Adelphi] preferisce la parola "erranza", che significa anch'essa vagabondaggio. Camatta farà uso del termine "divagazione", in un testo, per un titolo in cui sostiene di usarlo nel suo vecchio significato, di «errer ça et là».
[*2] - Endnotes è un gruppo che esiste dal 2005, con una preistoria (risalente al 1992, in un gruppo inglese chiamato Aufheben), e che è diventato "sempre più internazionale". Nella loro angoscia pe sapere chi essi sono e come si relazionano alla «lotta di classe», nell'articolo "We Unhappy Few" hanno deciso che nella condizione attuale sono teorici della loro stessa abolizione (e non reclutatori di una causa), e che il gruppo dovrebbe durare «solo fino a quando sentono di star contribuendo a qualcosa di utile». Ma come fanno a sapere sei stanno davvero contribuendo a qualcosa di "utile", anche se si tratta solo di una "sensazione", e poi utile a chi? Cosa intendono con "utile"? Le cose sono "importanti" solo se hanno "un uso"? Il loro millenarismo tranquillo, anche se insistono sul non essere mai stati una setta «nel senso normale», viene spiegato in questa frase: «Un obiettivo che abbiamo trovato e che ci interessa, anzi, verso cui ci siamo sentiti spinti, è la teoria comunista, il pensiero sul capitalismo e sul suo superamento». Questa è l'attesa, in studiosa e ferma disponibilità, dell'arrivo di "Dio".
[*3] - È sempre difficile fare questo genere di liste per i lettori che non hanno "confidenza" con l'ambito al quale mi riferisco, che include anarchici, consiliaristi, consiliari di sinistra, situazionisti, bordighisti, e comprende anche la sinistra libertaria. Il modo più facile per immaginare un simile ambito è pensare a tutti quelli che Lenin ha attaccato nel suo libro del 1920, "L'estremismo, malattia infantile del comunismo.
[*4] - Quel che va capito, è il concetto di «movimento reale» nel contesto del supporto incondizionato da parte di Marx ed Engels al «metodo scientifico», che poi è il modo in cui hanno sviluppato quel che è stato il loro concetto di dialettica come forza motrice della "storia". C'è una famosa frase di Marx, la quale raramente viene compresa: « I filosofi hanno finora solo interpretato diversamente il mondo; il problema è cambiarlo. » Questa frase non è mai stata solo una semplice esortazione affinché i filosofi si "attivassero" per il bene comune; il significato era quello che i filosofi dovevano abbandonare il mondo degli «Universali Assoluti» (si pensi alla teoria delle Forme di Platone) ed operare all'interno dei processi sociali ed ambientali che esistevano nella realtà. Marx riteneva che se lo avessero fatto, non sarebbero più stati degli «inutili filosofi», ma sarebbero stati degli scienziati - ai tempi di Marx, era lo scienziato ad essere visto come colui che cambiava il mondo, e i proletari ed i filosofi avrebbero potuto fare altrettanto se fossero diventati anche loro degli "scienziati" o, per essere più precisi, dei dialettici della concezione materialista della storia (materialismo storico).
[*5] - In "We Unhappy Few", ci sono diversi riferimenti al «movimento reale». Di solito, la citazione di Marx viene tradotta con qualcosa di simile a: «il movimento reale che abolisce lo stato di cose attuale», e viene frequentemente usato nella letteratura della teoria della "comunizzazione". La frase di Marx, per intero, è «Il comunismo è per noi il movimento reale che abolirà le condizioni attuali.» A partire dall'inizio degli anni '70, per i comunisti di sinistra la riga che comincia con «il movimento reale...» è diventata una sorta di magico incantamento. Il concetto di «movimento reale» è stato citato, ma non referenziato, in "Eclipse and Re-Emergence of the Communist Movement", degli ultra-sinistri Gilles Dauvé (Jean Barrot) e François Martin, ed è stato qui che per la prima volta è comparso il concetto di comunizzazione. Nel 2000, Dauvé ha dichiarato che la teoria della comunizzazione è derivata dalla «critica della separazione» dell'Internazionale Situazionista. Scherzando, nel 1983, Camatte, rispondendo a quelle che sono state le loro critiche all'«ottimismo» di Camatte, ha definito «Dauvé e i suoi compagni» come dei «morti viventi».
[*6] - Gran parte di questo, così come il testo della prossima sezione, è tratto da un articolo precedente che si può leggere a: https://www.counterpunch.org/2020/04/10/the-last-humans-or-why-revolutionaries-should-drop-their-millenarianism-and-support-survival-international/
[*7] - I kulak venivano descritti dai bolscevichi come contadini «ricchi» che ostacolavano la socializzazione delle terre ma, in realtà, erano semplicemente tutti dei contadini. I contadini - e la relazione tra campagna e città - è sempre stato un problema perenne per i rivoluzionari, come scriveva Marx nel 1875: « Su scala di massa, il contadino esiste come proprietario privato della terra, laddove egli forma addirittura una maggioranza più o meno considerevole, come avviene in tutti i paesi del continente europeo occidentale, dove non è scomparso ma è stato sostituito da braccianti agricoli, come in Inghilterra - in futuro vedremo: o i contadini cominceranno a creare degli ostacoli e faranno fallire qualsiasi rivoluzione operaia, come hanno fatto in precedenza in Francia, oppure il proletariato (perché il contadino proprietario non appartiene al proletariato; e anche quando la sua situazione lo colloca come tale, egli pensa di non farne parte) deve, in quanto governo, prendere dei provvedimenti, in conseguenza dei quali la situazione del contadino migliorerà direttamente, portandolo dalla parte della rivoluzione. »
Il gruppo "Theorie Communiste", vicino al gruppo "Endnotes", scrive nel 2011: «La questione essenziale che dovremo risolvere, è quella di capire come estendere il comunismo... come integrare l'agricoltura senza dover scontrarsi con i contadini.»
Sembra che una volta Maxim Gorky abbia detto: «Perdonami se te lo dico, ma il contadino non è ancora umano... È il nostro nemico, ll nostro nemico.»
fonte: Il Covile