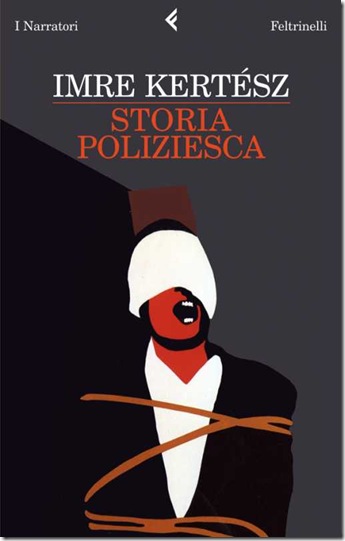Sempre contro il lavoro
- Elogio dei libertari olandesi del gruppo "De Moker" -
di Clément Homs
Se risulta evidente che per troppo tempo si è proiettato sulla lotta di classe una rivoluzione radicale che dall'inizio del 19° secolo aveva cominciato a girare solo nella testa di qualche teorico della sinistra hegeliana (e in Marx nell'Introduzione al Contributo alla critica della filosofia del diritto di Hegel), oggi le "manie metafisiche" circa la lotta di classe, come dice Norbert Trenkle [*1], vengono resuscitate dalla loro tomba sotto forma di farsa. A grandi colpi di defibrillatore teorico, alcuni fanno ancora del nuovo proletariato (quello "incondizionatamente" vero e puro, come testimonierebbero i fantasmi attuali che vedono muoversi intorno al proletariato cinese, indiano, ecc.) una classe sociale suscettibile di rispondere alle esigenze dello schema dialettica, e di perdersi in un'alienazione radicale pur di realizzare una liberazione radicale (per altri ancora, si tratta del "Bloom" che, in questo schema, rimpiazzerà il proletariato...).
La morte della metafisica della lotta di classe
È possibile sentir dire, uscite dalle labbra di un individuo che legge concentrato sul suo e-reader, le parole secondo le quali la critica della dissociazione-valore avrebbe abbandonato la lettura "classista". Sottintendendo in ciò un crimine di alto tradimento rivoluzionario. Per questo, essa non ha mai trascurato i concetti di "classe" o di "lotta di classe" ed ha soprattutto cercato di criticare radicalmente la matrice metafisca dentro la quale per troppo tempo ci siamo rovinati la vista cercando di pensare questi due concetti, che rimangono così radicati in un riduzionismo sociologico incapace di porsi al livello di astrazione e di comprensione della formazione sociale capitalista elaborata nell'opera marxiana della maturità.
Le classi sono rimaste sempre là, e la lotta di classe continua ad essere una realtà contemporanea, con buona pace di Adorno ed Horkheimer. Ma questa lotta che costituisce una delle due principali forme di antagonismo nella società capitalista (dove l'altra è quella, desunta dalla dinamica "effetto valanga" del capitalismo - vedi Moishe Postone - che oppone il "nuovo" al "vecchio", e questo dall'epoca del romanticismo) è una realtà che fa parte del funzionamento immanente alla società capitalista, dal momento che la classe proletaria non può e non potrà affermare, nella sua forma di pensiero e nella sua lotta, nient'altro che il suo essere sociale dato da una società che lo ha costituito come "classe". E ciò, attraverso la difesa positiva del lavoro, attraverso la lotta sul tempo di lavoro, sul rifiuto dell'estorsione del plusvalore nel conflitto di distribuzione fra salari e profitti e attraverso una lotta per il riconoscimento dei suoi altri interessi e "diritti" sempre modellati dalle condizioni di base capitaliste.
Nella costituzione feticista della realtà sociale capitalista, la costruzione a priori del proletariato in soggetto rivoluzionario non corrisponde a niente. E non corrisponderà mai a niente. Il proletariato non è mai stato, non è, e non sarà mai, il "soggetto della storia", checché ne dicano i tanti che non vogliono guardare in faccia la realtà. È questa illusione ormai sepolta quella che qualche medico legale vuole dissotterrare per portare a termine una "nuova autopsia del cadavere". Questa retorica-metafisica di un certo modo di intendere la lotta di classe fa venire le lacrime agli occhi solamente ad una manciata di ritardatari del marxismo tradizionale, i quali non vogliono smettere di coltivare una "identità operaia" che non ha più un proprietario. Nella riappropriazione critica di Hegel che si svolge nell'opera marxiana della maturità, il soggetto-oggetto identico non è il proletariato, come pensavano Lukács e tanti altri prima e dopo di lui. Marx attribuisce specificità storica al solo feticcio-capitale [*2]. O più precisamente, Marx «non identifica [...] questo soggetto con alcun gruppo sociale - il proletariato non più dell'umanità - ma lo riferisce alle forme delle pratiche oggettivanti espresse dalla categoria del capitale» [*3]. Per cui, rompere con la metafisica della lotta di classe e non con le qualità euristiche delle categorie di "classe" e di "lotta di classe" (e che per Marx non si riferiscono al nucleo di ciò che è il capitalismo, ma soltanto alla sua struttura sociologica fenomenica), significa per noi che «la rottura con le categorie del lavoro non può contare su un campo sociale bell'e pronto ed oggettivamente determinato» [*4]. È una teoria critica del capitale, e quindi una teoria rivoluzionaria, ciò che si tratta di ricostruire fin dalle sue fondamenta. La teoria critica radicale (vale a dire, non quella della Scuola di Francoforte, anche se Adorno dice cose interessanti sulla dialettica) deve contribuire a «creare un nuovo concetto di rivoluzione» [*5].
Fine dell'economia
Se la lotta di classe capitalista ha come contrapposizione, la classe proletaria contro la classe borghese, con questa riscoperta della religione del "soggetto rivoluzionario", una lotta rivoluzionaria conseguente deve avere come linea di demarcazione strategica la dicotomia fra, da una parte, la lotta alter-capitalista dal punto di vista del lavoro, per la redistribuzione del valore e del denaro, e dall'altra parte, la lotta contro il lavoro, l'abolizione del valore e del denaro (e tutto il resto che va insieme a questo nella relazione di dissociazione), attraverso la costituzione di una nuova forma di sintesi sociale che permetta di farci uscire collettivamente dall'economia. E questa linea di demarcazione passa innanzi tutto in quella che pretende di essere la sinistra "anticapitalista" ed antiliberale. Poiché il cavallo di Troia dell'ontologia capitalista si trova all'interno delle mura delle nostre lotto, oggi il compito storico è quello di distruggerlo e rompere polemicamente con questa forma di alter-capitalismo dominante a sinistra che, dai decrescitori all'NPA [Nuovo Partito Anticapitalista] fino ai comunisti libertari, naturalizza ancora il lavoro, la merce, il valore e il denaro, cioè a dire il livello di essenza sociale del capitalismo, pensando in maniera illusoria di trasformarne solo le forme fenomeniche. Questa linea di demarcazione diventa fondamentale per superare le lotte in quanto trattamento immanente delle contraddizioni del capitalismo (vale a dire un trattamento di tali contraddizioni all'interno delle categorie e delle forme sociali del capitalismo che non vengono messe in discussione).
A partire dal 19° secolo, la "parola operaio" è apparsa nello spazio pubblico borghese, è la «voce di un'intelligenza che è quella del nuovo principio: il lavoro» [*6]. Una parola che non domanda altro che il riconoscimento del suo posto: «ciò che reclamiamo non sono dei favori, dichiarano con Proudhon gli operai tessili, sono i nostri diritti e nient'altro che i nostri diritti» [*7]. Questa critica svolta dal punto di vista del lavoro rimarrà per due secoli il presupposto comune al movimento operaio classico, dal collettivismo al comunismo libertario, passando per il sindacalismo rivoluzionario, l'anarcosindacalismo, ecc.. Per mezzo del suo piccolo commercio che fa passare di contrabbando l'ontologia capitalista ed il suo sostegno alla "modernizzazione di recupero", il movimento operaio classico non è stato altro che l'acceleratore dell'organizzazione della vita sociale attraverso e per il lavoro, che è fondamentalmente la società capitalista [*8]. Basti pensare ai manifesti della CNT spagnola nel 1936 [*9]. Tutte le canzoni dell'identità operaia hanno ripreso, nel loro canone, il gusto dello "orgoglioso lavoro" della borghesia (l'espressione è di Victor Hugo). La critica svolta dal punto di vista del lavoro, pertanto, non costituisce una sorta di inganno, di tradimento o di menzogna da parte del movimento operaio. Come mostrato da Alfred Sohn-Rethel, «le forme di pensiero socialmente necessarie di un'epoca sono quelle che sono conformi alle funzioni di sintesi sociale di tale epoca» [*10]. Questa forma di pensiero naturalizza ciò che è socialmente costituito e che è storicamente specifico al capitalismo, non perché questo pensiero si inganni o perché i lavoratori siano degli utili idioti che fanno il gioco del capitalismo, ma perché il carattere storicamente specifico del lavoro è tale che esso appare come "lavoro" trans-storico [*11].
Ieri come oggi, "il lavoro è un crimine".
Si dice che, nella migliore delle ipotesi, i "critici del valore" potrebbero ancora ritrovarsi in una filiazione rispetto alla lotta contro il lavoro che è stata fatta soprattutto negli anni 1930 dalle frange di alcune avanguardie artistiche. Si pensi alla "guerra al lavoro" condotta dai surrealisti, e alle parole di Paul Eluard, contro «l'ordine comodo e ripugnante del lavoro». Tuttavia, nelle frange marginali del movimento operaio classico, ed in aperta opposizione con esso, alcuni, rari, hanno rifiutato il "punto di vista del lavoro" e la sovra-identificazione con esso. Intorno al loro giornale "De Mocker", un gruppo libertario di giovani olandesi, fra il 1923 ed il 1928, sviluppa delle posizioni delle quali non ci sarebbe da vergognarsi in questo 21° secolo di rivoluzionari. Vi si possono leggere delle parole che rimarranno sempre attuali fino a quando esisterà il capitalismo:
«Il lavoro è il più grande affronto e la più grande umiliazione che l'umanità ha commesso contro sé stessa»; «Il capitalismo esiste grazie al lavoro dei lavoratori, ecco perché non vogliamo essere dei lavoratori e perché sabotiamo il lavoro». «Rendiamo i giovani coscienti del fatto che il capitalismo esiste a causa del loro lavoro e che essi devono perciò negargli la loro forza lavoro»; «Quando smetteremo di lavorare, per noi finalmente avrà inizio la vita. Il lavoro è il nemico della vita. [...] Quando l'uomo diverrà cosciente della vita, non lavorerà mai più» [*13].
Il gruppo Mocker pubblica nel 1924, a firma di Hermann J. Schuurman, un testo breve ma sorprendente, in completa contrapposizione con l'assolutismo del lavoro del movimento operaio che dopo l'inizio del 19° secolo aveva deciso di seguire la borghesia, ridefinendo l'addomesticazione dell'individuo convertendolo in materiale umano della valorizzazione, per fare di questo un "diritto" ed un futuro principio positivo della società postcapitalista. Il lavoro non è un "diritto", scrive Schuurman, «Il lavoro è un crimine». Recentemente questo testo è stato tradotto in francese e pubblicato dalle edizioni Antisociales, nel 2007. Sotto numerosi aspetti, appare come un precursore di una critica radicale del lavoro. Grazie ad Else van Daele, l'opera contiene anche una presentazione storica di rara qualità che mostra l'insieme delle posizioni, dei dibattiti e delle lotte del gruppo Mocker contro il movimento operaio classico e contro il capitale.
Il concetto ingannevole e mai troppo chiaro di "alienazione" (Adorno lo ha ben mostrato in "Dialettica negativa") è assente in Schuurman, e lo è per una buona ragione: il lavoro non è alienato, come si sente dire troppo spesso, ma è in sé, nella sua stessa esistenza, un'alienazione. Anche quando viene scarabocchiato da Debord, il termine "lavoro alienato" lascia intendere che esisterebbe un lavoro non alienato. L'opposizione al "lavoro alienato" rimane così caratteristica del paradigma di una critica svolta dal punto di vista del lavoro, si critica il "lavoro alienato" in nome di un presunto "lavoro non alienato". Da parte sua, Schuurman critica esplicitamente il carattere trans-storico del lavoro, soprattutto opponendo "lavorare" a "creare": «Creare è una gioia intensa, lavorare è una sofferenza intensa». «Nei rapporti sociali criminali attuali, non è possibile creare».
Similmente alla metafisica del "fare" in John Holloway, la categoria di "creazione" è certamente problematica. Essa continua a costituire una categoria astratta che è senz'altro inclusa sotto il segno del lavoro concreto produttore di valore d'uso, anche se Schuurman sembra estraneo alla terminologia marxiana. Nondimeno lo si può sospettare nel momento in cui Schurrman parla ancora di "bisogni vitali". Porre l'insieme delle attività umane incastrandole dentro una sintesi sociale non capitalista in un comune piano d'astrazione - "creare", "creazione" o "fare" (come in Holloway) - rimane ancora caratteristica della forma di pensiero capitalista determinata dal suo essere sociale. C'è sempre il rischio di proporre una rivoluzione sotto la forma di un nuovo principio astratto di sintesi sociale, che non è altro che il naso finto della solita astrazione annidata nel cuore della vita sociale presente. Se l'attività di "creare" diventa il principio di socializzazione degli individui, la costituzione feticista capitalista si ricostituirà "alle nostre spalle" e "al di là della coscienza", dal momento che l'astrazione reale qui non viene generata in quanto idealità, ma a partire dalla situazione in seno ai rapporti sociali di un'azione. È la posizione situazionale del lavoro mostrata da Postone, la sua capacità di mediare gli individui l'un l'altro, che "astrattifica" il lavoro, che fa necessariamente del lavoro un'astrazione, un'astrazione posta dalla dimensione pratica e reale di questa posizione situazionale. Quindi qualcosa di ben reale, però un reale sociale e storicamente specifico ad un'ontologia storica particolare, quella del capitalismo. È il piano pratico-situazionale di un'attività che permette di potersi rapportare gli uni agli altri, che la rende generale costituendo il piano d'astrazione di tale attività. Si tratta di un'astrazione pratico-situazionale, una "astrazione reale" e non concettuale. Si tratta perciò di una "sostanza sociale-pratica". Qui la "realtà" dell'astrazione non proviene da un'astrazione concettuale, seppure incosciente, o da una "convenzione". Questi termini - "creare", "creazione", "fare" - non sono quindi altro che gli avatar del lavoro concreto (e d'altronde viene esplicitamente rivendicata come tale da Holloway, che nella sua critica tronca del lavoro finisce per rientrare nella nicchia del marxismo tradizionale) che esiste solo come categoria specificamente storica relativa alla sola formazione sociale capitalista, in quanto forma fenomenica del lavoro astratto, ed è "l'astrazione di un'astrazione" (Norbert Trenkle). Oggi, mentre con il senno di poi delle ricerche antropologiche, questo è ben documentato (cfr. Bonte & Becquemont, Mythologies du travail. Le travail nommé, L’harmattan, 2004) e serve a comprendere la prassi sociale in seno alle formazioni sociali premoderne, ci troviamo invece di fronte ad una prassi incognita quando si tratta di evocare i tratti che potrebbe prendere un agire non capitalista nel quadro di una sintesi sociale postcapitalista.
D'altronde, è tutta la componente classica della lotta di classe che viene criticata dai giovani del gruppo De Mocker:
«In breve, "lo spirito del socialismo" è in contraddizione con "lo spirito della lotta per i salari". Consapevolmente, il cammino verso la rivoluzione non passa per: la lotta per i salari, la giornata di otto ore, ecc. [...] Se per forza di cose devi lavorare come salariato e se puoi arrivare ad avere condizioni di lavoro migliori grazie all'azione diretta nell'impresa (consigli operai!), allora ogni anti-sindacalista sarebbe d'accordo con questo, a condizione che allo stesso tempo si ponga, come primo e più alto compito, come scrive l'Unione Spartacus nel suo programma, "quello di denunciare il carattere ingannatore di tali movimenti" [...]».
Qui il gruppo Mocker comprende attraverso la denuncia di questo "carattere ingannatore", il normale conflitto di interessi, quotidiano e permanente, nel quadro della società capitalista, che è la lotta di classe. Rifiutando la lotta sindacale, la lotta per il salario, la lotta per il miglioramento di un Rudolph Rocker, la lotta per i diritti e per il riconoscimento, la lotta rivendicativa, la lotta di fabbrica, il gruppo sottolinea già in che cosa questa lotta di classe sia l'espressione stessa del funzionamento contraddittorio del capitalismo, senza che per questo si debba proiettare su questo antagonismo di classe, il soggetto hegeliano della storia. I libertari di De Mocker saranno degli anti-sindacali, e continueranno ad opporsi alle manie altercapitaliste dell'anarco-sindacalismo. Questo, osserva il gruppo De Mocker, cerca solo di mettere le mani sulla gestione dell'economia:
«Se gli anarcosindacalisti avevano voluto rivoluzionare il sindacalismo, osserva Els van Daele, i Mokers ed i loro compagni hanno messo a nudo fin dall'inizio l'ambiguità di una simile impresa. La storia dell'anarcosindacalismo negli anni 1930: la lotta fra le tendenze, le scissioni, la burocratizzazione insieme alla lotta contro questo fenomeno in seno all'AIT ed in seno alle sue federazioni, che ha avuto come apoteosi, durante la guerra civile spagnola, la completa scissione fra una burocrazia collaboratrice ed una base che dava inizio alla realizzazione del comunismo libertario senza di essa, ostacolata da essa, che dava così loro rapidamente ragione».
Anti-lavoro, ozio, sabotaggio, anti-sindacato. Se questo gruppo assume l'atteggiamento classico ed irrilevante che raccomanda l'ozio contro il lavoro, similmente a Lafargue, il gruppo Mocker non cadrà nell'apologia della crescita delle forze produttive attraverso le tecnologie del capitale (criticheranno il taylorismo, per esempio), cosa che, al contrario, rende "Il diritto all'ozio" un'opera assai limitata che non ha mai espresso la minima critica del lavoro. Come Jacques Ellul, Lafargue aveva piuttosto criticato la "ideologia lavorista" senza mettere mai in discussione il presunto carattere trans-storico del lavoro. Ma, pur riprendendo la tematica dell'ozio individuale, i giovani olandesi appaiono anche assai chiaramente coscienti dello stallo di una tale posizione. Bisogna piuttosto identificarli nella "grammatica socialista" definita nel libro di Irène Pereira [*14]. Così, ai loro occhi, l'opposizione al lavoro nella lotta rivoluzionaria non si pone sul piano di un semplice rifiuto individuale, in quanto "il lavoro è un male sociale". È la totalità sociale che viene assunta come oggetto da criticare e cui opporsi, «questa società è nemica della vita» - scrive Schuurman - «ed è solamente distruggendola, insieme a tutte le società del lavoro che seguiranno - vale a dire facendo rivoluzioni su rivoluzioni fino a quando il lavoro sparirà».
Sia ieri che oggi, si tratta sempre di approfondire la critica che investe le radici sociali della formazione sociale capitalista e dislocarne le linee in seno alla sinistra "anticapitalista", al fine di ricomporre delle nuove polarizzazioni contro ed al di là dei dinosauri della vecchia critica inefficace dal punto di vista del lavoro. È attraverso quello che "Il manifesto contro il lavoro" chiama "contro-spazio pubblico" - e che la critica della dissociazione-valore potrà contribuire, portando la sua pietra, ad edificare - che bisogna approfondire con tutti i mezzi il fossato fra la critica anticapitalista, fondata sulla critica delle categorie capitaliste, e l'anticapitalismo tronco della sinistra, sia della vecchia scuola che postmoderna, che sarà sempre soltanto un alter-capitalismo senza orizzonti (e nella migliore delle ipotesi un insurrezionalismo vuoto). Nel parlare delle lotte che sorgono sempre nel quadro del trattamento immanente alle contraddizioni del capitalismo, quelli che vanno avanti e che non sono stupidamente affermativi dell'esistente, ossia quelli che non riferiscono immediatamente i bisogni sociali ad una valorizzazione del capitale sulla base del lavoro astratto (in genere, redistibuzione, politica della domanda, ecc.), devono attraversare dei muri invisibili, e non solo nel momento delle grandi ondate episodiche della mobilitazione, prima del "ritorno alla normalità". Per mezzo di circoli di lettura e di riflessione, conferenze, pubblicazioni, film, radio, interventi pubblici ed agitazioni varie, la critica dell'economia in quanto tale si può diffondere, approfondire e trasformare. Oggi, evidentemente, a sinistra della sinistra del capitale, c'è qualcosa di cui si è alla ricerca (per parlare solo della Francia): che riguarda la critica dell'ideologia del progresso, della crescita, dell'industria, del lavoro, del valore, dello Stato, dei generi, delle classi, della nazione e del denaro, così come della forma giuridica borghese, ecc.. Ma tutto questo non costituisce ancora un "polo", e nemmeno una "dislocazione di linee".
- Clément Homs - agosto 2016 -
NOTE:
[*1] - Norbert Trenkle, "Le sottigliezze metafisiche della lotta di classe". Dello stesso autore, si veda anche: "Lotta senza classe: perché nel processo di crisi capitalista non risorge il proletariato? "
[*2] - Moishe Postone, « Le sujet de l’histoire. Repenser la critique de Hegel dans l’œuvre marxienne de maturité », in Actuel Marx, n°50, 2011
[*3] - Ivi, p.67
[*4] - Krisis, "Manifesto contro il lavoro"
[*5] - Robert Kurz - "Nessuna rivoluzione da nessuna parte"
[*6] - Jacques Rancière, La parole ouvrière, 1830-1851, La fabrique, 2007, p. 9.
[*7] - ivi p.11
[*8] - Vedi Krisis, il capitolo X del Manifesto contro il lavoro. Vedi anche: Robert Kurz, " Les destinées du marxisme. Lire Marx au XXIe siècle"
[*9] - Michael Seidman, Ouvriers contre le travail. Paris et Barcelone pendant les Fronts populaires, Senonevero, 2009; Myrtille Gonzalbo, "L'anticapitalismo degli anarchici e degli anarco-sindacalisti spagnoli negli anni trenta"
[*10] Alfred Sohn-Rethel, "Lavoro manuale e lavoro intellettuale".
[*11] - Ci si riferisce qui alla dimostrazione di Moishe Postone, in "Temps, travail et domination sociale", Mille et une nuits, 2009.
[*12] - La révolution surréaliste, n° 4, juillet 1925
[*13] - Herman Schuurman, « Le travail est un crime » et « De Bloedhonden zijn los » [« Les chiens sanguinaires sont lâchés »], De Moker, n° 12, 1er novembre 1924.
[*14] - Irène Pereira, Les grammaires de la contestation. Un guide de la gauche radicale, La découverte, 2010.
fonte: Critique de la valeur-dissociation. Repenser une théorie critique du capitalisme