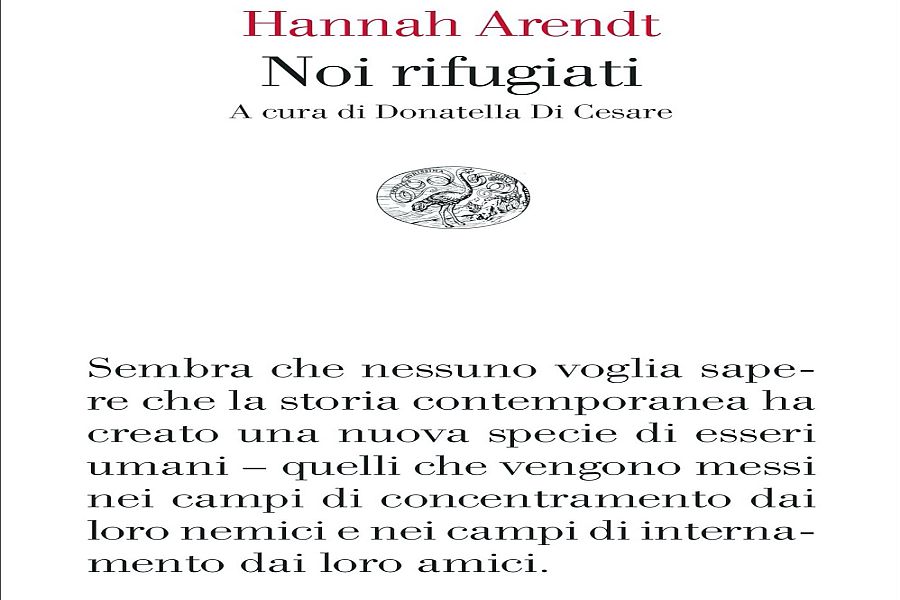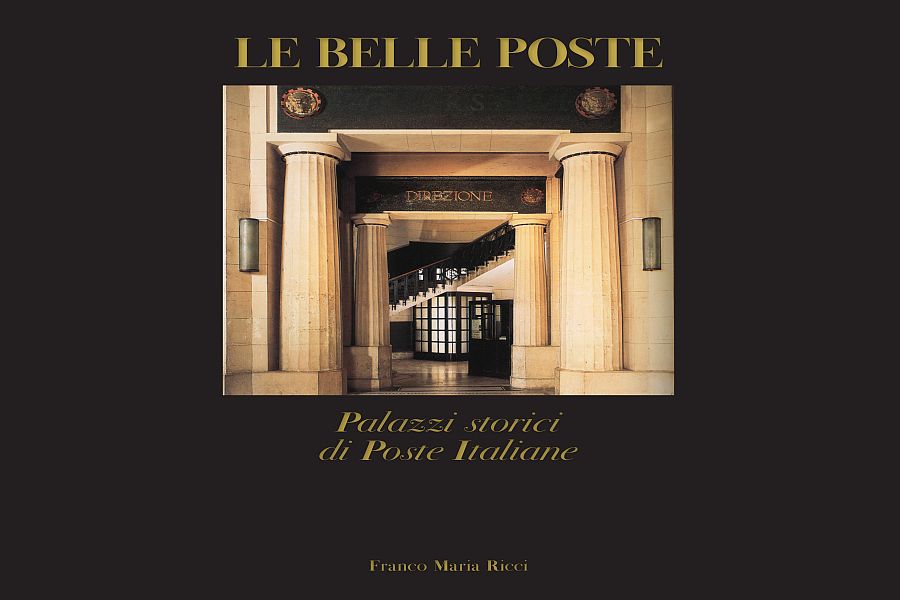La miseria della teoria critica di un teorico critico
- Una nota storica -
Frank Grohmann presenta un testo di Hans Jürgen Krahl
L'opera di Hans Jürgen Krahl (1943-1970), rimasta in forma di bozza o addirittura frammentaria, deve molto al suo contrapporsi con l'opera di Jürgen Habermas - come dimostra in particolare il progetto del 1968 [*1], anch'esso incompiuto, qui di seguito riprodotto. Un anno dopo la sua relazione "Sull'essenza della logica dell'analisi marxiana della merce" [*2] (1966/67) - svolta nel corso di un seminario di Adorno e che ancora oggi colloca il pensiero di Krahl accanto a "Sulla dialettica della forma-valore" (1970) [*3] di Hans-Georg Backhaus e a "Sulla struttura logica del concetto di capitale in Karl Marx" (1972) [*4] di Helmut Reichelt - il progetto di Krahl non solo critica Jürgen Habermas, ma allo stesso tempo suggerisce dov'è che Krahl vede i limiti della teoria critica dei suoi maestri Max Horkheimer e Theodor W. Adorno: ossia, come si dirà più avanti, egli vede tali limiti nel pericolo di «razionalizzare la necessità dell'astrazione filosofica, in ragione dell'autonomizzazione speculativa». In altre parole, «la critica, da parte di Adorno, della società tardo-capitalista rimaneva astratta e negava l'esigenza di definire una negazione risoluta» - per l'appunto – «di quella categoria dialettica, quindi, a cui sapeva di essere legato dalla tradizione di Hegel e Marx» [*5].
Il testo che qui sotto presentiamo, non va letto tanto come se fosse un documento storico, quanto piuttosto come un esortazione a svolgere una lettura critica della posizione dell'agitatore e teorico Hans-Jürgen Krahl, organizzatore dell'SDS [*6]. Questo testo è il seguito alla sua "Risposta a Jürgen Habermas" [*7], nella quale Krahl esprimeva già in maniera chiara la sua contrapposizione.
Nel «momento storico» [*8] (Robert Kurz) del movimento globale dei giovani e degli studenti, che insorgeva contro il sistema dominante, colui che era l'allora membro del Consiglio Direttivo Federale dell'SDS qui precisa in maniera inequivocabile quale sia il proprio punto di partenza: di fronte alla propria «crisi di collasso», il capitale «si salva per mezzo della costruzione politica dello Stato autoritario, attraverso le regolamentazioni economiche statali e con lo smantellamento della sicurezza giuridica borghese a favore della sicurezza in quanto strumento di oppressione». Questo Stato autoritario tedesco, che allo stesso tempo, «con l'adozione delle leggi di emergenza, ha dato espressione giuridica al suo carattere socialmente coercitivo» [*9], è - secondo Krahl - «tanto un'espressione della crisi del capitale quanto una dimostrazione del suo temporaneo successo nel dominarlo a proprio vantaggio».
Sebbene vada sottolineato che Krahl - come Backhaus prima, e Reichelt un po' più tardi - raggiunge il livello categoriale della logica essenziale della relazione feticista capitalista [*10], possiamo qui vedere anche in che modo il suo approccio differisca da quello degli altri due. Certamente Backhaus e Reichelt sottolineano anche il «carattere puramente "logico" dell'analisi marxiana della forma-valore» [*11], ma in loro «manca completamente qualsiasi mediazione con la teoria della crisi» [*12], e il loro lavoro si distingue per la «rinuncia pressoché totale a qualsiasi analisi concreta dei processi sociali e a ogni localizzazione della propria situazione storica» [*13].
Per Krahl è del tutto diverso, e lo è nella misura in cui, per lui, la «frammentazione delle masse» e «l'isolamento degli individui, gli uni dagli altri», tipici del capitalismo, sono stati «spinti ad andare ben oltre le "sole" condizioni economiche, grazie al perfezionamento degli strumenti di governo e di manipolazione, nell'epoca del tardo capitalismo, legando i vincoli economici all'intervento politico dello Stato».
Eppure Hans-Jürgen Krahl avrebbe potuto ancora sperare in qualcosa, grazie alla «crisi del crollo del capitale», e questo proprio nella misura in cui il «successo» avuto dal capitale nel «dominare la crisi a suo vantaggio» gli poteva ancora apparire come «temporaneo». Cinquant'anni più tardi, le «conseguenze strategicamente sicure», che Krahl oppone ad Habermas, appartengono a un'epoca lontana, e sembrano oggi solo un pio desiderio: vale a dire, la «funzione di minaccia del sistema», svolta dall'«attività autonoma della popolazione, che oggi le istituzioni del dominio sociale non tollerano in linea di principio»; la conseguente «resistenza dell'opposizione extraparlamentare»; e l'«unità internazionale della protesta anticapitalista» in quanto «nuova costellazione storico-mondale».
Ciò che viene qui espressa, è la convinzione ancora intatta che in questo contesto ci sia la possibilità di un «processo di educazione collettiva» - un processo che, per Krahl, porta alla «realizzazione dell'individualità» - «così come viene descritto metafisicamente nella "fenomenologia dello spirito" di Hegel, materialisticamente nel "Capitale" di Marx e formulata psicoanaliticamente nella teoria di Freud» - prosegue Krahl, «descrivendo questa società come un sistema di sfruttamento totale nella quale l'attività vitale produttiva della natura umana si inaridisce» [*14].
Ed è su un tale sfondo che la frase seguente ci porta al bivio dove il percorso di Hans-Jürgen Krahl si separa da quello dei suoi predecessori, dei suoi successori e di molti suoi contemporanei: «Stiamo attraversando dei processi formativi che, per prima cosa, ristabiliscono l'individualità e ricostruiscono ciò che l'individualità è in senso emancipatorio, accomunandoci nella lotta pratica contro questo sistema» [*15]. Tenendo a mente la «determinazione della negazione risoluta» (a differenza di Adorno), Krahl non si limita a «collocare la propria situazione storica» nell'«analisi concreta dei processi sociali» (a differenza di Backhaus e Reichelt), ma va dritto e diretto all'ineludibile «lotta pratica» (a differenza di Habermas).
Nel 1968, secondo Krahl, «il concetto di teoria rivoluzionaria [...] era ancora di là da venire», per il tardo capitalismo, e la lotta pratica contro questo sistema era anch'essa ancora di là da venire! Alla luce di questi due compiti necessari - visti come i le due facce evidenti della relazione tra teoria e pratica - la dichiarazione di guerra contro la posizione di Jürgen Habermas era per lui inevitabile.
Nella loro introduzione agli scritti, ai discorsi e ai progetti degli anni 1966-1970, i curatori dei testi antologizzati di Hans-Jürgen Krahl considerano lo stato incompiuto della maggior parte dell'opera di Krahl vedendola come «l'espressione di una situazione politica nella quale le teorie tradizionali del movimento operaio venivano problematizzate in maniera pratica, senza tuttavia poter essere sostituite da una teoria formulata dai movimenti rivoluzionari nelle metropoli del tardo capitalismo» [*16]. Da questo punto di vista, la «difficile situazione del movimento studentesco» rifletteva la problematicità del rapporto tra teoria e pratica: i suoi obiettivi non potevano essere orientati, né verso una pratica politica della lotta di classe né verso i nuclei organizzativi esistenti del movimento operaio [*17]; e, allo stesso tempo, non si poteva trattare semplicemente di una questione di problemi tecnici organizzativi per l'attuazione più efficace di una teoria riconosciuta e accettata come vera [*18].
A partire da questo, non solo diventa comprensibile come la «ricostruzione critico filosofica della teoria rivoluzionaria» [*19] di Krahl tenti di mostrare una via d'uscita dal dilemma teoria-prassi, ma diventa anche chiaro perché, per lui, il rapporto tra teoria e pratica abbia raggiunto il suo punto più acuto nella questione dell'organizzazione [*20].
Secondo l'analisi svolta da Robert Kurz, il movimento del 1968, nel senso dell'emancipazione sociale, ha fallito completamente «perché non ha perseguito fino in fondo la linea di critica del "lavoro astratto, del feticismo della merce e della razionalità economica", e non è arrivato a una concezione negativa e abolizionista dell'auto-relazione capitalista. Invece, si è trovato sul versante sbagliato della "politica" ed è ben presto caduto vittima della medesima illusione democratica del vecchio movimento operaio» [*21]. C'è ogni ragione di credere che in tale contesto il movimento si sia anche scontrato su un problema teoria-pratica [*22], a cui Hans-Jürgen Krahl non solo fu estremamente sensibile, ma riuscì anche in parte a elaborare e a presentare ai suoi compagni.
Se il movimento della gioventù e degli studenti non solo non ha riconosciuto quale fosse «l'identità interna della democrazia e del capitalismo» [*23], ma non ha nemmeno «ridefinito il rapporto tra la riflessione teorica e la cosiddetta dimensione dell'azione», vale a dire, non è riuscito a produrre un'altra «determinazione teorica» che «si allontanasse deliberatamente dalla comprensione tradizionale del "rapporto tra teoria e pratica" che» - a priori - «era stato tagliato secondo il profilo di esigenza dell'azione all'interno dell'involucro formale capitalista» [*24] - resta allora da chiarire in che misura il fallimento di questo movimento di rivolta sia avvenuto con o contro Hans-Jürgen Krahl. La risposta a questa domanda dipende essenzialmente dall'importanza che attribuiamo alla cosiddetta «questione dell'organizzazione», cioè alla questione di trasformare la «spontaneità diffusa delle masse» in delle forme più «intransigenti» di azione di protesta, in «azione diretta», «resistenza violenta», o in qualche altra «strategia» [*25]. Krahl non solo era consapevole che dietro questa domanda c'era sempre una domanda più grande: che fare? Egli ha riconosciuto anche il pericolo che la «questione organizzativa» - se non interpretata - avrebbe potuto essere soffocata dalla «pratica dell'organizzazione» [*26]. Da qui la necessità di un confronto critico con la sua opera: perché una critica radicale di tale questione è ancora oggi - seppure sotto diversi auspici storici - un approccio fecondo, che non può che modificare il problema teoria-pratica.
Per quanto riguarda Jürgen Habermas, la sua teoria contribuisce ancora meno ai «problemi teorici e pratici aperti» in questo contesto, secondo l'Hans-Jürgen Krahl del 1968, poiché essa aderisce fin dall'inizio a uno «schema accademico della pratica» - secondo lo slogan «prima l'illuminismo, poi l'azione». Il giudizio del più giovane dei due allievi di Adorno - che doveva diventare, come lui stesso ha detto, «l'avversario politico del suo maestro di filosofia» [*27] - su colui che ha quattordici anni in più, Habermas, e che è stato anch'egli alla scuola di Adorno (e anche insieme), è a dir poco schiacciante: non solo quest'ultimo non raggiunge sul piano teorico la radicalità teorica che la teoria critica promette, ma con i suoi «approcci insignificanti alla pratica» - come aveva già detto Krahl all'epoca - Jürgen Habermas «rimane indietro rispetto al vero movimento di resistenza, come una nottola di Minerva dalle ali tarpate» [*28].
- Frank Grohmann, settembre 2022 - Pubblicato su GRUNDRISSE Psychanalyse et capitalisme -
[1] Inteso come contributo all'opera collettiva curata da Oskar Negt "Die Linke antwortet Jürgen Habermas", Francoforte 1968. Apparso in Hans-Jürgen Krahl, "Costituzione e Lotta di classe", Jaca Book, 1973 p. 269-278.
[2] In Hans-Jürgen Krahl, Costituzione e Lotta di classe, op. cit. p. 39-96.
[3] Hans-Georg Backhaus, "Zur Dialektik der Wertform", Dialektik der Wertform. Untersuchungen zur marxschen Ökonomiekritik, ça ira, Freiburg, Vienna, 2018.
[4] Helmut Reichelt Zur logischen Struktur des Kapitalbegriff bei Karl Marx, ça ira, Freiburg, Vienna, 2006.
[5] Hans-Jürgen Krahl, "La contraddizione politica della Teoria Critica di Adorno" ; articolo pubblicato nella Frankfurter Rundschau del 13.8.1969 in occasione della morte di Adorno. In Hans-Jürgen Krahl, Costituzione e Lotta di classe, op. cit, p. 313.
[6] Il Sozialistischer Deutsche Studentenbund (SDS) era un'associazione studentesca politica della Germania Ovest e di Berlino Ovest, esistita dal 1946 al 1970.
[7] In un teach-in alla presenza di Habermas e lo stesso giorno in cui il suo articolo "Die Scheinrevolution und ihre Kinder" è apparso sulla Frankfurter Rundschau. In Hans-Jürgen Krahl, Costituzione e Lotta di classe, op. cit. pp. 265-269.
[8] Robert Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus. Ein Abgesang auf die Marktwirtschaft, Eichborn, Frankfurt, 1999, p. 596.
[9] Gli emendamenti alla Legge fondamentale approvati dal Bundestag tedesco il 30 maggio 1968 e adottati dal Bundesrat il 14 giugno sono chiamati "Notstandsgesetze". Permettevano al governo tedesco di limitare temporaneamente o sospendere completamente i diritti fondamentali dei cittadini. Si veda la "Römerbergrede" di Krahl a Francoforte il 27 maggio 1968, che inizia con le parole: «La democrazia in Germania è in punto di morte; le leggi di emergenza attendono l'approvazione definitiva». Hans-Jürgen Krahl, "Römerbergrede", in Costituzione e Lotta di classe, op. cit, pp. 171-177.
[10] Si veda Robert Kurz, Grigio è l'albero della vita, verde è la teoria. Il problema della prassi come critica eternamente tronca del capitalismo e della storia delle sinistre, Crise & Critique, Albi, 2022, pag. 140.
[11] Robert Kurz, Geld ohne Wert, Horlemann, Berlino, 2010, p. 38. «La "logica" qui è [...] meno determinata, in sé, come logica effettiva del capitale, che semplicemente come rappresentazione teorica di Marx [...]». Ivi.
[12] Robert Kurz, "Krise und Kritik", Exit! - Krise und Kritik der Warengesellschaft, 10/2012, pag. 43.
[13] Robert Kurz, Geld ohne Wert, op. cit, p. 22.
[14] Hans-Jürgen Krahl, "Dati personali", Costituzione e Lotta di classe, op. cit. p. 27.
[15] Ivi.
[16] "Introduzione", Costituzione e Lotta di classe, op. cit. p. 7. Enfasi aggiunta.
[17] Ivi.
[18] Ivi, p. 9.
[19] Ivi, p. 10, come una «dottrina i cui enunciati descrivono la società in termini di capacità di cambiamento». Cfr. Hans-Jürgen Krahl, "La miseria delle teoria critica di un critico teorico", Costituzione e Lotta di classe, op. cit. p. 269.
[20] "Introduzione", Costituzione e Lotta di classe, op. cit. p. 7 e p. 15. Si veda anche Hans-Jürgen Krahl, "La miseria delle teoria critica di un critico teorico", op. cit. p. 269: «La miseria della teoria critica è la sua incapacità di porre la questione dell'organizzazione».
[21] Robert Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, op. cit. p. 596.
[22] Si veda anche Robert Kurz, Grigio è l'albero della vita, verde è la teoria, op. cit.
[23] Robert Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, op. cit. p. 596.
[24] Robert Kurz, Grigio è l'albero della vita, verde è la teoria, op. cit. p. 18.
[25] Si veda Hans-Jürgen Krahl, ""La miseria delle teoria critica di un critico teorico"", op. cit.
[26] "Introduzione", Costituzione e Lotta di classe, op. cit. p. 7.
[27] Hans-Jürgen Krahl, "La contraddizione politica della Teoria Critica di Adorno", op. cit, p. 313.
[28] Hans-Jürgen Krahl, "Una risposta a Jürgen Habermas", Costituzione e Lotta di classe, op. cit.

La miseria della teoria critica di un teorico critico
- Una risposta a Jürgen Habermas -
di Hans Jürgen Krahl
Habermas celebra oggi, come fantasiosa invenzione di nuove tecniche di manifestazione, quel che un anno fa, al congresso di Hannover, lo indusse all'accusa di fascismo di sinistra, ricca di fatali conseguenze pratiche e di una drastricità teorica che assomiglia piuttosto a un corto circuito: la forma di azione che consiste nella protesta provocatoria [*1]. Habermas non ha lasciato alcun dubbio sul senso terminologico di quest'accusa voracemente assorbita dalla pubblicistica liberale: provocare la sublime violenza istituzionalizzata a manifestarsi con evidenza terroristica, sarebbe un atto fascista perché sfida il fascismo [*2]. L'accusa si muove entro alternative soltanto apparenti, e astrae dalla comprensione teorica della dinamica del capitale monopolistico cui il fascismo - secondo le analisi del giovane Horkheimer - inerisce come una potenzialità sempre attualizzabile, presente come stalinismo. Habermas invece suppone che sia un prodotto della soggettività rivoluzionaria in situazioni non ritenute oggettivamente rivoluzionarie, e si schiera così nel coro univoco dei pubblicisti liberali che, da K.H. Flach attraverso Augstein fino a Kai Hermann, con citazioni di fatto formalizzate e destoricizzate, fanno scendere in campo i rivoluzionari del passato, da Marx a Lenin, per sbarazzarsi di eredi attuali che sarebbero soltanto dei romantici pseudorivoluzionari.
Questa critica della malattie infantili utopistiche, anarchiche ed estremiste di sinistra, che si rese necessaria a un livello storicamente anteriore del socialismo rivoluzionario, era legata a una precisa fase di sviluppo organizzativo del movimento operaio: allora si doveva, e ancora si poteva, strutturare un processo oggettivamente rivoluzionario di educazione della classe all'autoliberazione, nel medium di un partito centralistico che fungesse come indicatore pratico e interprete teorico delle esperienze della lotta di classe e che rischiarasse con la propaganda e l'agitazione la vaga spontaneità delle masse. L'incapace liberismo del presente rovescia le vecchie accuse, staccate dal contesto storico, su un movimento storicamente nuovo, per razionalizzare il suo disagio affettivo nei confronti di un movimento di protesta plebiscitario-egualitario che si sottrae a tutte le tradizionali istituzionalizzazioni, ufficialmente riconosciute, della rappresentanza politica degli interessi, che si sottrae cioè alle consolidate idee di partiti e di alleanze d'interessi. Lo sguardo liberale, che muove da una coscienza lacerata, si appunta così, con fissità maniacale, sulla semplice forma fenomenica della protesta. Una tale fissazione irrazionale permette di associare alla forma fenomenica sensibilmente evidente delle manifestazioni studentesche, alle masse unificate in una collettività e alla rottura immediata delle congelate regole del gioco che stabilizzano il dominio, attraverso l'azione diretta, l'immagine del terrore compiuto da un fascismo di sinistra. Con una procedura simile si potrebbero senz'altro inserire in una fenomenologia dell'azione pura i simboli visibili della protesta, il grido di Ho Chi Minh e la bandiera rossa, segni della protesta emancipativa e dell'indignazione di una politica rivoluzionaria: in tal modo si ridurrebbero all'indifferenza i contenuti politici del movimento di protesta e diverrebbe possibile la tranquillante identificazione delle «estreme». Infatti, la prigione della tradizionale politica del compromesso, ancorata alle istituzioni, e che il dominio ha svuotato delle sue libertà repubblicane e della sua sostanza democratica, impedisce al critico liberale di sperimentare riflessivamente, in un modo teoricamente adeguato, le categorie politiche di un movimento di protesta nuovo nella storia, e deforma lo sguardo, nascondendo i contenuti emancipativi di forme in azioni che rifiutano il compromesso. Fin dai tempi della fallita rivoluzione tedesca di novembre, ma più profondamente dalla vittoria del fascismo, la legittimità di una prassi rivoluzionaria e di una resistenza anche violenta è stata cancellata dalla coscienza storica dei tedeschi; e l'annullamento fu troppo brutale perché una coscienza reificata, che dipende da alternative interne allo status quo, possa cogliere subito i concetti storici che articolano una prassi diretta alla trasformazione rivoluzionaria del mondo.
Può darsi che Habermas sia stato indotto a correggere la sua accusa di «fascismo di sinistra» dal rispecchiamento irriflesso della coscienza radicalmente destoricizzata nelle relazioni pubblicistiche dei liberali e dall'esperienza della resistenza militante dei neri negli USA. Ma il fatto che Habermas ricada sempre di nuovo nell'ambito categoriale della tradizionale politica del compromesso, risale a quella teoria critica a cui sa di dovere la sua filosofia della storia. L'incapacità specifica di questa teoria - già nella sua versione horkheimeriana e anche marcusiana - a tematizzare, cioè teoricamente, una dimensione pratica determinata dal socialismo rivoluzionario, spinge Horkheimer e Marcuse verso conseguenze anarchiche, mentre induce Habermas a conclusioni liberali. Se il tipo di illuminismo, cui mira Horhkeimer, e mutatis mutandis anche Marcuse, contiene implicazioni anarchico-volontaristiche, in Habermas conduce, invece, a una strategia di reazione liberale che scredita l'azione. Il vizio, che nel giovane Horkheimer e nel tardo Marcuse è piuttosto accidentale, in Habermas diventa una inevitabile fonte di errori teorici. È vero che egli riconosce alle tecniche dimostrative del movimento di protesta degli studenti la capacità di produrre le condizioni di una strategia socialista per «rovesciare strutture sociali profondamente radicate» e per instaurare un modo di produzione socializzato in cui si attui l'emancipazione. Eppure, anche questo movimento cadrebbe in balia della coercizione astorica di un'ortodossia tradizionale e cadrebbe perciò in un offuscamento illusorio della coscienza di tipo pseudorivoluzionario. La correzione della sua posizione antecedente è meramente formale; la sostanza non è affatto cambiata. L'illusoria auto-interpretazione del movimento degli studenti, e soprattutto dell'SDS, provocherebbe la controrivoluzione: «La tattica della falsa rivoluzione finisce per esprimersi in un atteggiamento che cerca a tutti i costi una polarizzazione delle forze» [*3]. La vecchia accusa di fascismo di sinistra, rinunciando alla terminologia politicamente discriminatoria, si presente in una nuova veste.
La critica di Habermas all'SDS si concentra in due argomenti [*4].Egli attribuisce all'SDS un'ortodossia teorica irriflessa e un dogmatismo praticamente irrealistico nei confronti della teoria marxiana del valore, delle crisi, delle classi e dell'imperialismo [*5]. L'SDS imporrebbe ai fatti sociali storicamente nuovi le vecchie lezioni della dottrina marxiana. Ne conseguirebbe una strategia fatale che finirebbe per isolare gli studenti [*6] e che produrrebbe un errato comportamento politico. Ciò potrebbe essere descritto ormai solo con le categorie cliniche di una patologia infantile. La confusione patologica fra azioni simboliche di protesta e lotta fattuale per il potere disgregherebbe il principio politico di realtà in senso falsamente rivoluzionario [*7]. L'accusa habermasiana di dogmatismo, che ignora in blocco le discussioni teoriche dell'SDS degli ultimi anni, non riflette sul livello storico della teoria.
Per quanto riguarda l'SDS, nel seguente schizzo lemmatico si cercherà di compiere una tale riflessione. Vi sono due esperienze storiche - nel cui contesto si costituisce il nuovo movimento di protesta, in un primo momento studentesco - che nelle discussioni dell'SDS hanno riattualizzato i problemi di una ricostruzione della teoria rivoluzionaria e della sua trasformazione in una prassi sovversiva: si tratta, da un lato, della fine del periodo di ricostruzione del capitalismo nella Germania Occidentale e della sempre più reale statalizzazione autoritaria della società complessiva (lotta contro le leggi di emergenza e la manipolazione) e, dall'altro lato, della attualità storico-mondiale della liberazione rivoluzionaria (protesta contro la guerra nel Vietnam) alla periferia della Zivilisation tardo-capitalistica nei paesi del terzo mondo [*8]. Il prospero periodo di ricostruzione del capitalismo dell'Europa occidentale, dopo la seconda guerra mondiale, sembrava aver eliminato per sempre l'attualità di una prassi sovversiva e aver rinviato alle calende greche la rivoluzione. In questa situazione, l'SDS ricorre al marxismo critico, riflesso nella teoria della conoscenza, quale era stato formulato, all'indomani della prima guerra imperialistica, anzitutto da Lukàcs e Korsch. Essi erano sotto l'influenza, determinata dall'esperienza della rivoluzione russa d'ottobre e tedesca di novembre, che impresse il suo segno al pensiero di Lenin e di Rosa Luxemburg, alla fase di costituzione del Comintern e all'ultrasinistra scuola olandese. Lukàcs e Korsch tentarono di ricostruire, nel medium pratico di un rapporto genuinamente negativo fra marxismo e filosofia, la posizione della soggettività rivoluzionaria, il ruolo della coscienza e della volontà del processo storico. Questo ricorso riuscì di certo a liberare la ricezione della teoria di Marx, Engels e Lenin, da un lato, dalla reificazione stalinistica e, dall'altro, dalla neutralizzazione antropologica da parte dell'industria scientifica tardocapitalistica, ma non era capace di dare una risposta alla mutata costituzione del sistema complessivo della società tardocapitalistica né di problematizzare sul serio quelle che Habermas chiama "pezzi di dottrina".
Sullo sfondo di queste domande, teoricamente aperte e praticamente irrisolte, paiono presentarsi - senza alcuna pretesa di compiutezza sistematica - quattro modi tipici di recensione della teoria rivoluzionaria, ricchi di conseguenze pratiche per l'SDS:
1. L'ortodossia dogmatica tratta la teoria in modo astorico, come se non fosse suscettibile di una continuazione. Si ispira nella prassi ai paesi rappresentati dall'Unione Sovietica e ai partiti comunisti dell'Europa occidentale, nei quali la Realpolitik della coesistenza pacifica ha praticamente estinto il bisogno di un cambiamento rivoluzionario dello status quo. Essa inserisce descrizioni empiriche della realtà sociale in un sistema categoriale reificato e aprioristico, nel materialismo storico, riducendo così la teoria rivoluzionaria del proletariato a una collezione di brani classici e a scienza della legittimazione. Essa è ancor sempre affetta da quella tendenza stalinistica a ontologizzare la teoria, che Sartre ha acutamente definito come un comportamento aprioristico [*9].
2. L'«economicismo» segretamente dogmatico tratta la critica marxista dell'economia politica con la pretesa critica di aver di fronte una positiva teoria della scienza. Il modo di produzione capitalistico viene isolato dalle istituzionalizzate forme di relazione della società borghese. Le analisi economiche empirico-critiche sono inquadrate in una costituzione sistematica della società che di fatto si considera immutata. Si escludono trasformazioni strutturali dell'antagonismo di classe e della soggettività rivoluzionaria [*10].
3. L'appropriazione storicistica (historische) della tradizione teorica tenta di soddisfare le esigenze di una storiografia materialistica e di attuare il programma critico di Karl Korsch di applicare il materialismo storico a sé stesso. Questo tentativo di ricostruzione della teoria rivoluzionaria intende evitare il dogmatismo nella prassi, in particolare, attraverso una recezione teoricamente spregiudicata dell'opposizione di sinistra nel movimento operaio rivoluzionario, dell'anarchismo della I Internazionale e della scuola olandese nella III Internazionale. Eppure questo tentativo non può fare a meno di regredire a una storiografia borghese finché si preclude una problematizzazione dei fondamenti teorici e, invece di risolvere i problemi per via teorica, si limita a indicarne storicisticamente le condizioni genetiche. Con premesse tali, l'attenzione che si rivolge alla storia materiale produce un ambiguo concretismo che suggerisce illusoriamente la vicinanza alla prassi da parte della teoria, perché risparmia problemi fondamentalmente irrisolti e ricompensa il loro trattamento con l'accusa di astrazione speculativa.
4. La ricostruzione della teoria rivoluzionaria attraverso una critica della filosofia sta in un immediato rapporto con i tentativi di Lukàcs e Korsch e trae la sua determinazione principale da quella concezione sistematica, di critica della conoscenza e di filosofia della storia, che è la Teoria Critica di Horkheimer e Adorno, di Marcuse e Habermas. Essa è consapevole delle fratture fra teoria e prassi, ma si espone al pericolo di razionalizzare il vizio dell'astrazione filosofeggiante a virtù dell'autonomia speculativa. Mi pare comunque che per due motivi questo tipo sia il più vicino alla problematica di una ricostruzione storica della teoria rivoluzionaria, di una dottrina cioè che descrive la società sotto l'aspetto della sua trasformabilità [*11]. Le problematizzazioni dei fondamenti teorici richiedono un'esplicita autocomprensione della teoria rivoluzionaria, attuata come critica della conoscenza, che inerisce tacitamente alla teoria marxiana. Tutti i tentativi di Lukàcs, attraverso Horkheimer fino alla sartriana «Critica della ragion dialettica», non sono finora riusciti a risolvere il dilemma di formulare una teoria materialistica della conoscenza, evitando il realismo speculare ingenuamente ontologico e senza regredire dalla critica hegeliana della conoscenza a Kant, che indica come l'analisi del «puro» processo conoscitivo, il quale precede in senso trascendentale i contenuti, non fa altro che spostare la verità oggettuale: una critica che Marx rivolgeva materialisticamente contro le necessarie premesse idealistiche dell'astrazione filosofeggiante [*12]. Fino a oggi, tutti i tentativi di un'esplicita teoria materialistica della conoscenza sono rimasti impigliati nel dilemma del trascendentalismo. Tale problema non può essere risolto neppure dal tentativo habermasiano di mediare, nella filosofia della storia, la ragion teorica e pratica kantiana con sé stessa, materializzando il soggetto trascendentale nel senso di una storia del genere, secondo il punto di vista antropologico del concetto marxiano di lavoro [*13].
La problematica della critica della conoscenza svela la sua pregnanza solo sullo sfondo dell'impostazione in chiave di filosofia della storia, propria della Teoria Critica. Manca ancora una teoria rivoluzionaria come teoria rivoluzionaria del tardo capitalismo. E rimane ancora da chiarire se essa sia da intendersi come critica dell'economia politica, oppure già - com'è implicitamente supposto da Marcuse e sistematicamente ripreso da Habermas - come critica della tecnologia politica [*14]. La Teoria Critica cerca di tematizzare la costituzione sistematica della società borghese nella sua modificazione tardocapitalistica, i mutamenti qualitativi nel rapporto fra lavoro oggettivato e lavoro vivo, fra valore d'uso e valore di scambio, fra produzione e circolazione, fra base e sovrastruttura. I tentativi di ricostruzione critica del sistema da parte di questo tipo di teoria muovono di regola da quei punti estremi dello sviluppo capitalistico, stabiliti da Marx ed Engels stessi, in cui tale sviluppo rinvia al modo di produzione associato: muovono dalla teoria della forma imprenditoriale delle società per azioni e dal processo tecnologico che incorpora la scienza al sistema di macchine ormai automatiche, che consta di capitale fisso [*15]. Rilevano una peculiare dialettica del punto storico di inversione: di fronte alla possibilità pratica della sua abolizione, il rapporto di capitale pare protrarre la propria fine. Horkheimer traccia la crescente statalizzazione autoritaria della società, che è parallela a una sempre più evidente socializzazione delle forze produttive tutt'interna al capitale, come dinamica immanente del tardo capitalismo. Marcuse descrive in che modo la traduzione tecnologica delle scienze in forza produttiva ormai automatica riduca, totalitariamente, a un unica dimensione gli antagonismi sociali. Allacciandosi a loro, Habermas tenta di determinare in senso analitico quel processo di legittimazione del dominio che rende ideologica la razionalità tecnico-scientifica e che caratterizza il capitalismo regolato dallo stato [*16]. Secondo la sua interpretazione di Marcuse, si assisterebbe a una trasformazione totalitaria della scienza e della tecnica in ideologia, in legittimazione del dominio. Questa è la base teorica della sua polemica contro le analisi della situazione che egli attribuisce all'SDS. Anche Habermas muove da simili tendenze di sviluppo; egli le descrive come «una crescita dell'attività interventista dello stato che deve assicurare la stabilità del sistema, da un lato, e una crescente interdipendenza della ricerca e della tecnica che ha fatto delle scienze la prima forza produttiva, dall'altro. Entrambe le tendenze distruggono quella costellazione di cornice istituzionale e di sotto-sistemi dell'agire teleologico che ha caratterizzato il capitalismo liberale. Scompaiono così rivelanti condizioni di applicazione dell'economia politica che Marx aveva giustamente attribuite al capitalismo liberale» [*17].
Secondo Habermas, la tendenza a una regolamentazione statale dell'economia e a un'incorporazione tecnologica della scienza alla produzione sopprime la dialettica di rapporti di produzione e forze produttive, di «base» e «sovrastruttura». In sua vece, Habermas pone la dialettica, storicamente più ampia e perciò meno concreta, di «lavoro» e «interazione». La spoliticizzazione della massima parte della popolazione è la conseguenza della decomposizione dell'ideologia tipica di una struttura liberale, del «giusto scambio» di equivalenti che nel capitalismo concorrenziale rappresentano la legittimazione economica del dominio. Dominio e base economica non stanno più in una rapporto di fondazione analizzabile attraverso categorie marxiane; tale comprensione si rispecchia nella differenziazione habermasiana fra il lavoro come agire teleologico e l'interazione come agire comunicativo, la cui mediazione e il cui rapporto con il processo di produzione non è ulteriormente determinato [*18].
L'isolamento reciproco degli individui, che viene mantenuto attraverso una politica autoritaria e una manipolazione tecnologica, mentre disgrega le relazioni sociali, ha potenziato la situazione di "classe in sé" dei salariati, la loro "naturale" disciplina. Mai più di oggi, la classe dei salariati è stata una classe in sé. Dato il mutamento strutturale del rapporto fra politica ed economia, rimane ancora da chiarire, nei suoi dettagli, il modo in cui la costituzione della classe in sé si rappresenta nel quadro della riproduzione del nesso sociale complessivo di astrazione dai bisogni e dai valori d'uso qualitativamente particolari. Alla conservazione dell'antagonismo di classe non provvede più la base della sfera della circolazione, dove il lavoro astratto si realizza, né il libero mercato o il giusto scambio, ma vi provvede, «dall'alto», lo stato autoritario e la tecnologia politica. Ma volerne trarre la conclusione che la lotta di classe rivoluzionaria, cacciata nella latenza sociale, non sia più attuabile sarebbe altrettanto prematuro quanto lo è l'ipotesi che la lotta di classe proseguire nelle sue vecchie forme.
Habermas tenta di affrontare il problema dialettico e marxista di una mediazione della prassi, teoricamente riflessa nelle mutate condizioni storiche in cui le singole scienze sono altamente differenziate dalla divisione del lavoro, e in cui le loro cognizioni specialistiche sono traducibili nel linguaggio della tecnica, e possono essere valorizzate nella produzione industriale; e in cui la prassi sociale, e in particolare il processo di automazione della produzione che la tecnologia è in grado di pianificare, diventano sempre più scientifici [*19].
Ma la riduzione della società a una razionalità soltanto tecnica, è soltanto parvenza: Habermas arriva così a revocare il concetto di prassi, specie laddove lo intende all'interno di una sistematica dei segni in senso proprio, come un orientamento dell'agire che può essere dispiegato, per via ermeneutica, nella rete delle comunicazioni quotidiane: ma questo è solo un calcolo "idealistico" della prassi materialistica.
Habermas grava la teoria di troppi compiti: essa non è in grado di riferirsi alla realtà complessiva, tranne che attraverso i suoi momenti; un tale riferimento è un problema della prassi rivoluzionaria che Habermas risparmia. La Teoria Critica si volatilizza nel processo di riflessione dell'autocomprensione da parte dei soggetti della ricerca e dell'insegnamento, ossia degli scienziati, sulla prassi sociale rispetto a loro prioritaria, ossia - ed è caratteristico - sulle premesse e non sulle conseguenze di tipo politico e sociale.
Pare che Habermas, nella sua discussione del rapporto tra fatti e modelli, si ritragga in una problematica della costituzione, propria di una filosofia trascendentale; alla revoca, tutta teorica, della prassi rivoluzionaria corrisponde un trattamento solo teorico della costituzione, che in realtà riguarda piuttosto la prassi.
Il concetto di prassi di Habermas si riduce all'idealismo di una libera comunicazione degli spiriti di un'utopia parlamentare, una società complessiva accademica (unità di teoria della scienza e di rappresentazioni di mete scientifiche). Di una corrispondente accademicità, è il modello che ne deriva: prima il rischiaramento, poi l'azione. La prassi qui si rivela come comunicazione oggettivata, mediata dai simboli concordati fra i soggetti, come agire linguistico di collettivi che si intendono reciprocamente.
La miseria della Teoria Critica sta nella sua incapacità di porre la questione organizzativa. Pare che questa incapacità si sia definitivamente oggettivata in Habermas, sfociando nell'ingenua proclamazione dell'unità di teoria e prassi nella strategia di un'alleanza liberale [*20].
- Hans Jürgen Krahl - 1968 –Fonte: Costituzione e Lotta di Classe, Jaca Book 1973 – (traduzione di Sabina de Waal)
NOTE:
[*1] - Per l''accusa di fascismo di sinistra, si veda l'agitata risposta di Habermas a Rudi Dutschke al congresso di Hannover del 1967 in "Der Kongress in Hannover", Berlin 1967, p.101. Per la posizione riveduta di Haberman, si veda "Die Scheinrevolution un ihre Kinder", in "Die Linke antwortet Jürgen Habermas", Francoforte 1968, a cura di O.Negt.
[*2] - Sul concetto habermasiano di provocazione, quale lo difese nei confronti dei suoi critici francofortesi, si veda "Der Kongress in Hannover", Berlin 1967, p.75.
[*3] - Cfr. Die Linke... op. cit. p.13
[*4] - Ivi, tesi 4, p.9 e segg. tesi 5, p.12 e segg.
[*5] - Ivi, p.10
[*6] . Ivi, p.13
[*7] - Ivi, tesi 2 p.12 e segg.
[*8] - Entrambe le esperienze offrono uno spunto sistematico per rappresentare il movimento di protesta degli studenti secondo categorie politiche oggettive, e per evitare una riduzione social-psicologica qual viene compiuta da Habermas. Tale tentativo di esposizione sistematica è stato compiuto da Oskar Negt in "Politik und Protest", Frankfurt 1968.
[*9] - Sartre descrive le conseguenze teoretiche della burocratizzazione stalinistica in "Marxismus und Existensialismus", Reinbeck, 1965, p.22: «...l'economia pianificata - attuata da una burocrazia che era cieca nei confronti dei propri errori - diventava un arbitrio che violentava la realtà. La futura produzione nazionale veniva stabilita a tavolino, spesso al di fuori di ogni norma di competenza; questa violenza veniva affiancata da un idealismo assoluto: uomini e cose erano sottomessi a priori alle idee, e se l'esperienza contraddiceva le previsioni, era chiaro che essa aveva torto. Rakosi già si immaginava la metropolitana di Budapest; se la natura del terreno non permetteva di costruirla, allora il terreno era controrivoluzionario».
[*10] - Cfr. le analisi di critica dell'economia di un Mandel o di un Altvater.
[*11] - Come Habermas, cos' anche molti membri dell'SDS ignorano l'inevitabile contingenza cui la prassi è soggetta in questo momento. Le inconfessate frustrazioni dell'esperienza ci insegnano che la nostra prassi resta a un livello di astrazione relativamente alto e povero finché non si concretizza in una teoria delle classi. E così si inveisce contro l'«astratta teoria» che non ha la forza di concretizzarsi.
[*12] - Cfr. Max Horkheimer, "Traditionelle und kritische Theorie" in Kritische Theorie, Frankfurt, 1968, e Karl Heinz Haag, "Philosophischer Idealismus", Frankurt 1967; cfr anche l’introduzione di Hegel alla "Fenomenologia dello Spirito" e l'introduzione di Marx ai "Lineamenti fondametali della critica dell'economia politica".
[*13] - Cfr. Habermas, "Erkenntnis und Interesse", Frankfurt, Suhrkamp, 1968.
[*14] - Cfr. Habermas, "Technik und Wissenschaft als « Ideologie »", Frankfurt, Suhrkamp, 1968, p. 48 et segg.
[*15] - «Secondo Marx ed Engels, il movimento del capitale monopolistico verso lo stato autoritario deriva dal fatto che il carattere sociale delle forze produttive si manifesta in tal misura da assumere un potere esplosivo per il sistema. Vengono lacerati i veli del rapporto di sfruttamento che fondano il dominio. La concorrenza sui prezzi fra monopoli e oligopoli non ha niente in comune con la libera concorrenza di individui reciprocamente ostili e con lo scambio di equivalenti di possessori di merci reciprocamente indifferenti ed equivalenti. La forza di legittimazione della società, che è propria della sfera della circolazione, che fonda lo stato di diritto liberale e democratico e le esigenze politiche e morali a esso collegate, si dissolve in misura crescente. La sfera della circolazione, un tempo, era l'espressione del regno dell'eticità borghese, la cui dialettica trasformava la pacifica reciprocità dei singoli egoismi concorrenti nell'interesse sociale generale della classe di proprietari privati. La spersonalizzazione monopolistica del mercato e la distruzione istituzionalizzata di quella maschera di carattere, che è l'eticità dei possessori individuali di merci, svela il rapporto di sfruttamento: il profitto imprenditoriale non può essere reificato e mascherato come salario. La crescente concentrazione distrugge l'ambivalente libertà del libero lavoratore e, con ciò, il diritto contrattuale che nasconde il rapporto di lavoro. Per salvaguardare il rapporto di sfruttamento, è ormai indispensabile un'ideologia politica che lo stato stesso introduce nella sfera della produzione. Gli strumenti principali di tale operazione sono la riforma sociale autoritaria, la politica dei redditi e un diritto del lavoro vincolato alla singola fabbrica» (cfr. Karl Korsch, "Arbeitsrecht für Betriebsräte", Frankfurt, 1968).
Alla dialettica di riforma sociale e rivoluzione corrisponde l'incoscienza e l'apatia delle masse che è un frutto dell'intervento statale. La trasformazione dello stato di diritto liberale nello stato sociale autoritario rende tendenzialmente possibile un passaggio allo stato di emergenza, senza alcuna frattura nella legittimazione giuridica e politica. E se la presa di potere delle istituzioni statali avviene in maniera strisciante, non si può certo contare su una generale "indignazione pubblica che possa trasformarsi in un'azione solidale e politicamente consapevole della masse oppresse.
[*16] - Cfr. Habermas, "Technik und Wissenschaft als « Ideologie »", op. cit., p. 48 et segg. Il quadro di riferimento delle categorie fondamentali proposte da Habermas, a partire dalle quali egli intende comprendere in una totalitò la formazione sociale tardocapitalistica, criticando il concetto di razionalità di Max Weber attraverso una meta-critica della teoria della tecnologia di Marcuse, qui non viene discusso.
[*17] - Ivi - p.74
[*18] - Completato dall'editore secondo indicazioni frammentarie.
[*19] - Cfr. la tesi di Serge Mailet (La nouvelle classe ouvrière, Paris, Éditions du Seuil,1963): nel tardocapitalismo, l'automazione può essere introdotta solo gradualmente, e questo poiché la diminuzione del capitale vivo crea il problema della disoccupazione tecnologica e frena lo smercio dei prodotti che invece aumentano a partire dallo sviluppo dei bisogni. Il meccanismo della concorrenza, d'altra parte, esige una costante razionalizzazione della produzione immediata.
[*20] - Qui il manoscritto si interrompe.