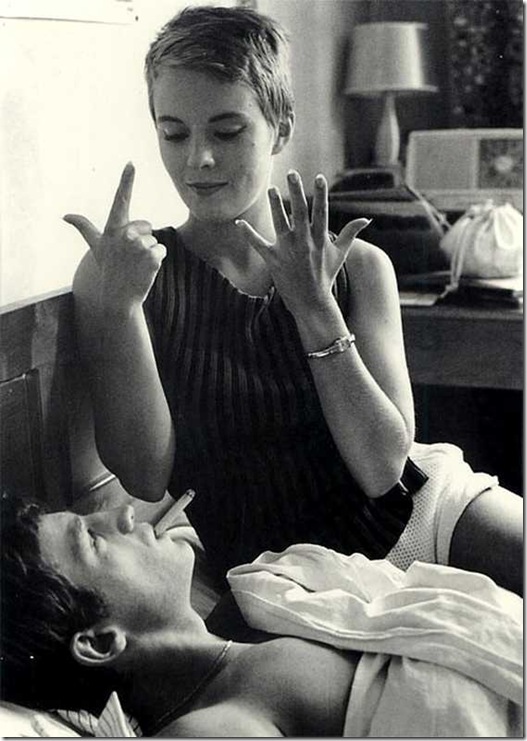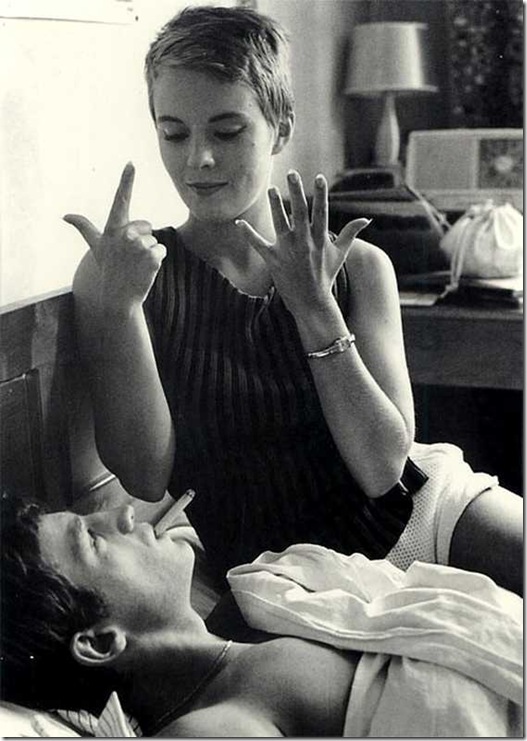
Magari è vero che - come dice e sottolinea (con enfasi) Gilles Dauvé - questa in cui ci troviamo immersi non è la "crisi finale", ed è vero anche che il capitalismo continuerà in eterno. A meno che non ci sia una "rivoluzione comunista" che metta definitivamente in soffitta il valore ed il lavoro, lo Stato ed il denaro, insieme alla merce e al mercato.
Insomma, forse è anche vero che ci muoviamo dentro una storia "determinata", secondo la quale al feudalesimo del Medioevo dovrà NECESSARIAMENTE fare seguito il capitalismo, di modo che - come da manuale (marxista tradizionale) - questo creerà quello sviluppo delle forze produttive necessario a fornire le premesse affinché la lotta di classe degli sfruttati si potrà liberare del capitalismo e, "ovviamente", delle classi.
Oppure no, e invece il gioco è semplicemente finito e, per quanto la cosa ci faccia paura, saremo costretti a fare i conti con la fine di un mondo, quello del capitalismo, senza che ce ne sia, senza che ne sarà, o senza che ne sarà stato, un altro, di mondi, bell'e pronto per sostituirlo.
Comunque sia, con tutto ciò, con il mondo, dobbiamo fare i conti.
Nebbie di guerra
- di G.D. -
« Quanto alla critica rivoluzionaria, essa comincia al di là del bene e del male »
- Internazionale Situazionista, 1967 - [*1]
Nello scenario di quella che una volta veniva chiamata la Mezzaluna Fertile, lo Stato Islamico (SI) cerca di imporsi contro, e non solo, le strutture statali che sono al potere in Iraq o in Siria. Alcune grandi potenze, tanto disunite fra di loro quanto superiori militarmente, ora cercano di fare in modo che questo avvenga, al fine di mantenere il loro controllo sulla regione. Dal caos alla crisi e viceversa.
Terrore
Nel 2002, Isabelle Sommiere ha citato la definizione data trent'anni prima da Friedrich Hacker:
« [...] il terrore è l'utilizzo, da parte di chi è al potere, di quello strumento di dominio che è l'intimidazione; il terrorismo è l'imitazione e l'utilizzo dei metodi del terrore da parte di coloro che non sono - almeno non ancora - al potere ».
A suo avviso, si può stimare « in 169 milioni il numero di vittime del loro stesso governo, contro i 34 milioni di vittime delle guerre fra Stati avvenute nel periodo fra il 1945 ed il 1995 [...] Così le forme convenzionali e non convenzionali della guerra tendono ad avvicinarsi di modo che ormai è falso caratterizzare il terrorismo opponendolo alla guerra statale ed affermando che esso ignora le leggi e le convenzioni di guerra, che attacca i civili e che è sempre indiscriminato ed arbitrario. In quanto tali caratteristiche, tutto sommato, oggi possono benissimo riguardare anche le violenze dello Stato » [*2].
Pierre Miquel, nel suo "La Grande guerre" (Fayard, 1983), intitola il suo capitolo consacrato all'uso dei gas, ai bombardamenti delle città ed al siluramento delle navi civili, "La Guerre terroriste". Il terrorismo fa parte della guerra... e della pace: ci hanno ripetuto per decenni che l'umanità deve la sua sopravvivenza all'equilibrio del terrore nucleare, di fatto un terrore potenziale, nel peggiore dei casi sentito dalle popolazioni come un'angoscia latente, che veniva dimenticata o che saliva alla superficie in funzione degli avvenimenti. Ma l'opinione pubblica soffre di amnesia, e preferisce la psicologia: il terrorista sarebbe l'innamorato della morte, sia di quella degli altri che della propria. Non è passato poi troppo tempo, però, da quando donare la propria vita veniva considerato quanto ci potesse essere di più desiderabile: « Morire per la patria, È il destino più bello [...] Fratelli per una santa causa [...] ognuno di noi è martire » (Chant des Girondins, inno nazionale francese dal 1848 al 1852). Negli eserciti occidentali contemporanei, regna la regola di zero morti, il soldato ucciso deve rimanere un'eccezione, e dev'essere rifiutata l'idea di sacrificio.
Trattare da pazzi fanatici i militanti ed i soldati del Califfato, che impongono la guerra all'Occidente, permette di creare un mostro contro il quale tutto è permesso. Tornando alla realtà, l'embargo imposto all'Iraq fra il 1991 ed il 2002 - secondo le statistiche al ribasso - è stato responsabile della morte di 500 mila persone. A partire dal 2001, la Guerra al Terrore ha fatto fra 1,3 e 2 milioni di morti, la maggior parte dei quali vittime dell'esercito americano [*3].
130 morti a Parigi il 13 novembre 2015, e quanti civili uccisi nei bombardamenti di Raqqa da parte dell'aviazione francese nelle settimane successive?
Religione
« [...] il millenarismo, lotta di classe rivoluzionaria che parla per l’ultima volta il linguaggio della religione [...] è già una tendenza rivoluzionaria moderna »: così Debord commenta « l'utopia millenarista della realizzazione terrestre del paradiso » nel 16° secolo ("La società dello spettacolo", tesi 138).
A causa di un'inversione difficilmente pensabile nel 1967, il millenarismo islamista del 21° secolo parla ancora una volta la "lingua della religione".
Ma cosa vuol dire "religione"? E perché lo si è imposto nei due paesi che una volta erano i due paesi più laici della regione?
Un minimo di riflessione storica è sufficiente a comprendere che la forte secolarizzazione di società come quella francese non indica affatto il percorso logico ed inevitabile che verrà seguito, o che dovrebbe essere seguito, dal resto del mondo.
Sunnita, sciita, sono queste le parole che vengono pronunciate ogni giorno come se si parlasse di cattolici e protestanti nella Francia contemporanea. Pensiamo invece piuttosto all'Europa del 16° e del 17° secolo. Qui non si tratta affatto di fede o di dottrina, bensì di appartenenza concreta: del quartiere o del villaggio dove si vive, della scuola cui si va, del lavoro che si trova, di chi sono i nostri amici, il bar che si frequente, con chi ci si sposa, chi ci aiuta in caso di bisogno. Qui, la religione non è un affare privato, ma segna l'identità che serve a definire, a racchiudere e proteggere tutti quanti insieme. Per un "sunnita", essere emarginato da decenni nella Siria di Assad, come nell'Iraq guidato dal governo "Sciita" installato dagli americani dopo il 2003, significa essere (mal)trattato da uno Stato in cui questo "sunnita" non ha ancora la cittadinanza; un concetto giuridico che nella regione è generalmente privo di qualsiasi contenuto.
Se si parla delle guerre di religione avvenute in Europa nel 15° e nel 16° secolo, questo è perché lo scisma portato dalla Riforma coincide con una serie di guerre, che fanno della religione "la lingua" politica dominante in dei paesi in crisi dove il cattolicesimo ed il protestantesimo diventano i veicoli delle contraddizioni sociali e dei conflitti politici.
Nel Medio Oriente attuale, coloro che chiamiamo "i religiosi" provengono da piccole classi medie che sono state messe da parte dal dominio imperialista e dai regimi dittatoriali, strati sociali esclusi dal potere politico e dalla promozione economica, di cui una parte fornisce dei quadri all'opposizione anti-regime. A seconda del paese, un gruppo (sunnita) ne domina un altro (sciita), altre volte avviene l'inverso. Li si potrebbe paragonare a quella parte istruita delle classi medie che ha animato la resistenza anti-coloniale e la lotta di liberazione nazionale in Asia e in Africa: i letterati in Cina, i laureati senza avvenire sotto il regime coloniale in Vietnam, gli ulema nei parsi arabi. Ovviamente, laddove il potere lascia prosperare i religiosi, senza che si immischino nella politica, ciò serve ad assicurarne gli interessi. Oggi, in un Medio Oriente in cui la confessione religiosa rimane un forte marchio identitario, ci sono dei professionisti che conferiscono ai movimenti sociali una visione del mondo ed un programma intrisi di religione, ma la loro principale motivazione non è quella della dottrina: è un interesse personale e collettivo.
Esperti e giornalisti continuano a ripeterci che uno Stato religioso è una curiosità o una mostruosità Medio orientale dovuta alla specificità dell'Islam, che si rifiuterebbe per principio di separare il religioso dal sociale e dal politico. Ricordiamoci che in Europa dei capi religiosi (e attraverso di loro, un'amministrazione e delle istituzioni) sono stati per molto tempo e con pieno diritto dei dirigenti politici. Stato monastico per trecento anni, la Prussia si è secolarizzata solamente nel 16° secolo, e fino all'inizio del 19° secolo ci sono stati dei prìncipi-vescovi a capo di piccoli territori europei.
Ci viene spiegata l'opposizione fra Arabia Saudita ed Iran come la lotta (millenaria e fratricida, questo va da sé) fra "sunnismo" e "sciitismo", laddove due paesi si affrontano per il dominio della regione. Anche la rivalità franco-inglese nel corso del 18° secolo potrebbe benissimo essere descritta allo stesso modo, la lotta fra grandi potenze per il controllo di una parte del mondo vista come una guerra fra cattolicesimo e protestantesimo.
E quale sarebbe la realtà di un «arco sciita» contro i sunniti? L'Iran sciita ha finanziato il sunnita Hamas. Gli houtisti dello Yemen sono quanto meno degli sciiti eterodossi. Quanto agli alawiti della Siria, sebbene la loro dottrina sia lontana dai precetti dell'Islam... sia sunnita che sciita, Assad aveva ottenuto dai teologi musulmani che fossero riconosciuti come buoni credenti: calcoli e manovre da entrambe le parti. Non si tratta di dogma, ma di appartenenza sociale e di interesse politico.
Stato
Lo Stato islamico è il prodotto di un processo politico che ha fatto seguito alla marginalizzazione dei sunniti, in Iraq come in Siria.
È stata creata un'identità sunnita, dapprima solo politica, poi territoriale, sulla base di una comunità etnico-religiosa che fino ad allora si era adattata, per amore o per forza, ai poteri esistenti, sia che li dominasse (l'Egitto o l'Iraq di Saddam Hussein), sia che si trovasse in minoranza (la Siria). Questa "comunità" si è data un obiettivo politico a partire dal rifiuto del sistema di governo iracheno (favorendo oltre misura gli sciiti) installato dagli americani dopo la loro conquista del paese avvenuta nel 2003. [*4]
Uno Stato che tratta come mezzi-cittadini la metà della popolazione, di solido ha soltanto la sua polizia ed il suo esercito. Nel momento in cui viene colpito da una crisi economica o da uno shock esterno, tutto l'edificio politico ne viene scosso, liberando delle forze centrifughe che fino a prima erano state contenute dalla repressione.
Accanto al Califfato e contro di esso, l'esperienza di Rojava è anch'essa il prodotto della resistenza di un popolo, i Kurdi, ai quali il collasso dello Stato siriano ha consentito di rendersi autonomi. Ma mentre il gruppo "sunnita" si trova ad essere strutturato su un modello religioso ed autoritario, il gruppo curdo trae vantaggio da una lunga esperienza di politicizzazione laica, di auto-amministrazione, di autonomia locale e di coinvolgimento delle donne nella vita sociale e nella lotta armata, senza che, tuttavia, il partito dirigente abbia smesso di dirigere. Di conseguenza, benché i curdi siano essi stessi in maggioranza sunniti come religione, ciò non costituisce una demarcazione, e non è servito per loro da cornice ideologica e politica. Quando il terzomondismo marxista-leninista del PKK si è rivelato inadatto al 21° secolo, i dirigenti curdi non si sono rivolti al Profeta, ma a Murray Bookchin e al suo eco-federalismo, e Rojaca tenta a modo suo di attuare una transizione democratica. Nato come lo Stato Islamico, per auto-difesa, ne costituisce il contro-modello.
Senza dubbio, preferiremmo abitare a Qamishli o ad Afrin, piuttosto cha a Raqqa (o a Bergen più che a Gedda), ma questa preferenza così come il progetto politico particolarmente democratico di Rojava non impedisce il fatto che si tratti di un proto-Stato, capitalista, e che mantenga una società di classe.
Al contrario, i sunniti iracheni, sottoposti a due tendenze - nazionalista ed islamista -, si sono ritrovati in un'alleanza di circostanza fra baathisti ed islamisti: senza questa convergenza fra capi militari e capi religiosi, non c'è nessun Stato Islamico. Il fatto religioso appare determinante, in quanto viene evidenziato sia dallo SI che dai suoi nemici, ma l'Islam serve a mascherare quello senza il quale il Califfato non esisterebbe: un fondamento politico non direttamente religioso. Nello Stato Islamico va vista l'organizzazione di una rivolta in seguito ad una secessione territoriale paragonabile all'inizio di un movimento di liberazione "nazionale", che ha un progetto ed ambizioni globali, in grado di attrarre sostenitori e partigiani in Europa ed altrove.
Se lo Stato Islamico regge, cosa che appare verosimile (a meno che gli Occidentali non decidano diversamente), la regione avrà tre regimi teocratici: in ordine di apparizione, l'Arabia Saudita, l'Iran, lo Stato Islamico. Oggettivamente, per quel che riguarda l'applicazione della sharia, ci sono poche differenze, in quanto il Califfato va solo un po' più lontano nell'esibizione della sua ferocia. Se lo SI evolve, vivrà più o meno in pace con i suoi vicini e si accontenterà di opprimere la propria popolazione senza mandare dei killer per le strade di Parigi o di Bruxelles, e verrà riconosciuto dalla comunità internazionale, come lo sono l'Arabia Saudita ed un Iran che fino a pochissimo tempo fa passava per essere uno degli Stati dell'Asse del Male.
Intanto, come ogni Stato giovane o minacciato, il Califfato proietta l'immagine di un popolo unito. Un "Manuale per le donne proclama": « Al diavolo il nazionalismo! [...] nel mio Stato, il ceceno è amico del siriano e l'egiziano è il vicino di un kazako. Le appartenenze si mescolano, le tribù si fondono e le razze si uniscono sotto il vessillo del monoteismo, e creano una nuova generazione in cui le culture di numerosi popoli differenti si integrano in una bella ed armoniosa alleanza. » [*5]
La questione è se tale generazione avrà il tempo di durare.
Fallimento
Malgrado la sua immensa capacità di mobilitazione, la religione non è mai sufficiente a fondare uno Stato, né a creare un nuovo tipo di società. Il protestantesimo non ha realizzato il capitalismo inglese. La sharia, compatibile con il modo di vita dei paesi arabi e turchi del 7° secolo e dei secoli successivi, non fornisce alcuna soluzione ai problemi economici e politici contemporanei, né del Medio Oriente né altrove. Dopo 35 anni, la "rivoluzione islamica" iraniana detta i costumi ed ha instaurato un modello originale di governo, ma senza creare dei rapporti sociali profondamente differenti. « L'Islam politico » non ha inaugurato una nuova variante del capitalismo comparabile a ciò che è stato il capitalismo di Stato, con una classe dirigente burocratica distinta e perfino rivale della borghesia classica. Nato in Russia, questo modello era dotato di un sufficiente dinamismo storico da estendersi su una parte del pianeta, anche se spesso in forma caricaturale, ma quanto meno è stato in grado di reggere per qualche dozzina d'anni. Non c'è niente del genere in quello che viene chiamato il mondo "arabo-musulmano". In Iran, l'enorme potere di cui dispongono i mullah e gli ayatollah non ha eliminato la forza e l'esistenza della borghesia, e i due gruppi si mescolano e si compenetrano. L'economia e le esportazioni vengono gestite da Teheran secondo il modello delle grandi imprese di Torino o di Sidney, e lo Stato Islamico non farà di meglio sulla sua modesta scala. Non esiste un capitalismo musulmano. L'Islam politico continuerà a muovere le folle, ma il suo fallimento nel promuovere una prospettiva storica c'è già stato.
Guerra
Politologhi e geo-strateghi hanno sottolineato a sufficienza la mancanza di coerenza della coalizione anti-SI, e non insisteremo oltre. Prendiamo da loro solamente una parola di moda: "asimmetria". Chi è che fa la guerra asimmetrica, e chi la vincerà? All'evidente superiorità tecnologica dei suoi avversari, il Califfato oppone il ritorno della classica "fanteria leggera" ed il terrorismo, l'arma dei deboli, di quelli che hanno delle bombe na non hanno gli aerei per lanciarle [*6]. Contro il Califfato, i partner della coalizione - seppur ridotta al coordinamento - hanno degli obiettivi divergenti, perfino opposti. Ed una vera e propria alleanza anti-SI dovrebbe implicare in primo luogo i grandi paesi vicini, Egitto e Turchia in particolare: non è questo il caso, con un'Arabia Saudita che si trova nel frattempo coinvolta in un'operazione militare nello Yemen. Anche il cemento ideologico - l'antiterrorismo - non funziona: gli occidentali appoggiano il PYD, il ramo siriano del PKK che viene considerata un'organizzazione terroristica.
C'è una contraddizione nella "guerra contro il terrorismo". La guerra ha un senso se fatta contro un nemico identificabile, uno Stato o un partito armato, ed "il terrorismo" non è né l'uno né l'altro, è solamente un metodo, una tattica utilizzata da dei gruppi che si riformano non appena vengono dispersi.
La Guerra al Terrore non risolve nulla. Se alcuni capitalisti possono essere a volte interessati ad una dose di caos, l'eccesso di caos non di meno minaccia non tanto il sistema stesso (fino a quando non ci sarà una rivoluzione comunista, il modo di produzione capitalista continuerà bene o male attraverso le crisi e le catastrofi), quanto gli interessi delle classi dirigenti, la cui perpetuazione richiede una minima stabilità geopolitica.
Senza dover spiegare tutto per mezzo del petrolio, non è irrilevante il fatto che l'Iraq ne detenga la terza riserva del Medio Oriente. Malgrado le speranze riposte nel petrolio di scisto statunitense, la posta in gioco è evidente: l'Iraq e quello che lo circonda conta più dell'Afghanistan.
La soluzione più che militare, sarà politica.
Imperialismi
Se lo Stato Islamico, nuovo avatar di Hitler, è diventato il nemico n°1 della "comunità internazionale", ciò non è dovuto ai suoi errori, ma assai più semplicemente al fatto di accentuare gravemente il disordine in Medio Oriente, regione petrolifera di primaria importanza dominata da più di un secolo dagli occidentali [*7].
Ora, se il Califfato fosse realmente un islamo-fascismo paragonabile al nazismo, e quindi qualcosa contro cui dovrebbe essere attuato tutto, Putin sarebbe un antifascista più conseguente di Obama, in quanto il capo della Russia non esita ad andare in aiuto del dittatore Assad, necessario baluardo contro lo Stato Islamico.
L'antifascismo non ha forse come principio quello di scegliere il male minore contro il male peggiore in assoluto?
Il fatto è che il paragone Hitler-Assad è antistorico. Questo non in ragione del numero di morti: il nazismo ne ha uccisi molti di più, ed ha praticato il genocidio. Ma soprattutto, Hitler minacciava l'esistenza di tre grandi potenze mondiali di quel tempo, la Gran Bretagna, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, mentre lo Stato Islamico mette in discussione solamente la suddivisione di una regione chiave. Nella seconda guerra mondiale, ciascuno dei tre imperialismi seguiva i propri interessi, fino a mettersi temporaneamente d'accordo col diavolo al momento giusto, Stalin sostenendo Hitler nel 1939-41, Roosvelt e Churchill facendo provvisoriamente causa comune con Stalin, poi. Il Califfato non rappresenta nessuna minaccia vitale per i paesi che dominano il mondo.
Così ciascuno si limita a rafforzare o a soccorrere chi viene considerato un alleato, attuale o potenziale. I bombardamenti statunitensi e francesi aiutano l'YPG contro lo Stato Islamico, ma non aiutano Assad contro lo stesso Stato Islamico: quando nel 2015 lo SI aveva sottratto Palmyra alle truppe del regime siriano, gli occidentali non sono intervenuti. Al contrario, come ha dichiarato Putin nell'ottobre 2015, aerei e missili russi hanno cercato di ristabilizzare la Siria, ed il loro sostegno ha contribuito a che l'esercito di Assad riconquistasse la città.
In questo conflitto, nessun imperialismo ha un obiettivo prioritario che prevalga su qualsiasi altra considerazione. Ciascuna forza presente si determina, non secondo il criterio "per o contro il Califfato", ma solo seguendo i propri interessi limitati , e quindi contraddittori sia fra di essi come con quelli degli altri belligeranti. Per la Turchia, Rojava è un nemico quanto lo è lo Stato Islamico. Per gli Stati Uniti, la nascita di uno Stato curdo in Siria indebolirebbe questo paese, ma anche la Turchia, che è comunque un suo alleato. La cosa peggiore per Washington, è l'esistenza di un potente perturbatore islamico nel cuore del Medio Oriente, oppure una grave crisi in Turchia? Entrambe le cose.
Crisi
Le contraddizioni delle coalizioni anti-Califfato hanno un'altra causa, più profonda.
Dopo la fine della guerra fredda si sono formate quattro coalizioni internazionali: Iraq (1991), Kosovo (1999), di nuovo Iraq (2003), e Libia (2011). Il Kosovo dimostra che non c'è necessariamente bisogno di truppe di terra, l'Iraq che le truppe di terra non necessariamente vincono, non più. Se si vuole vincere, serve legittimità, coerenza degli obiettivi (vale a dire una strategia comune), ed un piano d'uscita (per il dopoguerra). Oggi, nei confronti del Califfato, mancano le due ultime condizioni, ed anche in caso di scomparsa dello Stato Islamico continueranno a mancare di fronte al disordine in Iraq ed in Siria.
Se dal 2001 il pantano geopolitico si muove e si estende da un paese all'altro, non è per mancanza di mezzi militari. In questo dominio, gli Stati Uniti ed i loro alleati (a volte riluttanti, come la Francia nel 2003) hanno una superiorità che la Russia non contesta più, e la Cina non ancora. La causa ultima delle contraddizioni strategiche attiene allo stato del capitalismo contemporaneo, e che, a rischio di semplificare, bisogna tentare di individuare.
L'espansione e l'approfondimento del sistema capitalista dopo il 1945, soprattutto in Europa ed in Giappone, è durato per circa trent'anni, fino alla rottura degli anni 1970, dovuta in particolare alla ribellione del lavoro (laddove la storia non vede altro che una crisi petrolifera). Da questo shock proletario quasi mondiale, il capitalismo è uscito vincitore, ed in seguito ha perfino re-inglobato il capitalismo di Stato (i paesi dell'Est europeo) nella sfera capitalista cosiddetta di mercato. Nel 1975, le truppe statunitensi erano state cacciate dal Vietnam: vent'anni dopo, questo paese faceva la migliore accoglienza possibile agli investitori statunitensi ed asiatici.
Tuttavia la fase avviata dopo il 1980 non è stata quella dei Trenta Gloriosi, ancora più forte ed estesa all'intero pianeta. La differenza essenziale non risiede nella spinta dell'Asia e nell'ascesa di un rivale che minaccia gli Stati Uniti e l'Europa. L'ascesa della Cina (o dell'India) non pone la questione dello sviluppo del capitalismo cinese, ma quella dello sviluppo del capitalismo mondiale in Cina [*8].
Nel 19° secolo, Marx analizzava l'Inghilterra come il centro di un sistema mondiale che, senza toccare tutti i paesi, si irradiava dalla Cina all'America Latina. Analogamente, su scala più grande, gli Stati Uniti nel 20° secolo.
Perché è così difficile imporsi nell'ex Terzo Mondo quando dispongono di un'egemonia strategica planetaria, mentre erano arrivati a farlo quando il loro margine di manovra era limitato dalla potenza dell'Unione Sovietica?
La chiave va cercata nel rapporto capitale/lavoro, la redditività del capitale, l'insufficienza della produzione di valore, causa primaria della fuga in avanti della finanziarizzazione, e l'incapacità del capitalismo a rendere salariate le masse di esseri umani che esso strappa dai loro modi tradizionali di vita [*9]. L'apertura dell'Asia al mercato globale riporta su una scala più ampia la tendenza del sistema alla sovraccumulazione, ai rendimenti decrescenti, alla sovrapproduzione e alle bolle finanziarie. Lungi dal pacificare il mondo, la crescita drogata ne aggrava i conflitti ed il caos.
Questa crisi globale (non diciamo finale), differente da quella degli anni 1930, colpisce l'insieme del modo di produzione capitalista, di cui l'Occidente - con alla sua testa gli Stati Uniti, relativamente indeboliti ma sempre dominanti - rimane finora il principale vettore e l'emblema [*10].
Il sistema capitalista globale non è in grado di raccogliere i pezzi di ciò che prima aveva rimesso insieme nelle regioni colonizzate divenute formalmente indipendenti nel 20° secolo, ma sempre sottomesse ai paesi dominanti. Questi nuovi Stati vivono solo in quanto appesi al flusso mondiale del capitale, dipendenti dalle loro esportazioni, soprattutto di materie prime, ed in maniera accessoria di prodotti manufatti. Non vi è alcun Stato nazionale, né borghesia sostenuta da un interesse comune e capace di dinamismo politico. In mancanza di uno sviluppo endogeno, il paese si regge grazie al suo legame con il capitalismo straniero, e mantiene la sua unità grazie alla dittatura. In Egitto nonostante si è disposto di una base economica e sociale che nel 1922 gli ha permesso di accedere ad una semi-indipendenza, la borghesia locale non ha mai avuto la forza di dirigere un paese di cui i militari continuano a tenere le redini.
In dei paesi ancora più fragili, con frontiere artificiali e con popolazioni disunite come la Siria e l'Iraq, quando la crisi del "centro" capitalista si ripercuote su di essi, avviene che li scuota e, per i più deboli, che li smembri.
Malgrado la spinta democratica della "Primavera araba", le classi medie si sono rivelate incapaci di rilevare i regimi dittatoriali. Gli è che quando si dice "società civile", bisogna tradurre con democrazia borghese, ossia parlamentarismo, pluralismo ed alternanza dei partiti, concorrenza politica ed economica, spazio pubblico di discussione e circolazione di idee... tutte cose impossibili senza un minimo di sviluppo economico autonomo. L'esercito libero siriano non è l'emanazione di nessuna "società civile" di un paese di cui esso manifesta soltanto la frammentazione.
In Libia, caso estremo, il paese si è decomposto. L'Iraq non ha uno Stato, ne ha tre. In Siria, accanto ad un governo assai ridotto nascono e muoiono dei poteri locali che si impadroniscono di risorse (petrolio, altrove si tratterà di diamanti o di droga) e delle vie di circolazione (per le merci ed il denaro).
In questa situazione, la mancanza di coesione occidentale non è dovuta alla debolezza militare. Una grande differenza rispetto alla guerra fredda, attiene a che oggi, anche quando si hanno i mezzi per rovesciare i regimi che li infastidiscono, le grandi potenze capitaliste sono incapaci di rimpiazzarli con dei governi abbastanza stabili da garantire il "business as usual".Presenti a partire dal 1945 in una regione dove hanno preso il posto della Gran Bretagna e della Francia, gli Stati Uniti una volta non avevano bisogno di intervenire militarmente. In Libano, nel 1958, le loro truppe sono rimaste solo qualche mese, il tempo di restaurare l'autorità delle élite dirigenti, quasi senza combattere.
Oggi, gli imperialismi che dominano il Medio Oriente non possono né accettare il caos, né ristabilire l'ordine: si accontentano di padroneggiare il disordine. Le grandi potenze non fomentano le guerre locali - civili o fra Stati- ma vi presenziano, dal Libano degli anni 1970 al conflitto attuale passando per la guerra Iraq-Iran, ed i loro interventi servono a placare una fonte di tensione (al prezzo di migliaia di cadaveri) solo per esacerbarne un'altra altrove.
Il neocolonialismo degli anni 1950 e 1960 poteva promuovere nel Terzo Mondo dei regimi che avessero un minimo di stabilità, in quanto permettevano alle vecchie e/o alle nuove classe dirigenti di questi paesi di vivere di rendita (sovente petrolifera), e di attingere alla loro parte di profitti provenienti dal commercio con le metropoli industriali. Questa fase si è chiusa verso la fine del 20° secolo. Apparentemente, la "globalizzazione" ha portato su tutti i continenti ad una nuova crescita di un capitalismo che beneficia di lavoro a basso costo dal Marocco alle Filippine e di un trasporto delle merci a buon mercato. Ma la crisi di redditività colpisce anche l'ex Terzo Mondo, e gli impianti vengono dislocati laddove i salariati vengono pagati meno e sono più docili, se necessario dalla Cambogia all'Etiopia. Parallelamente, la globalizzazione accelera la distruzione delle colture alimentari e costringe ad una migrazione verso le città dove gli sradicati non trovano alcun lavoro. Lo sviluppo autonomo dei paesi ex coloniali rimane debole e fragile. Anche il Brasile, da poco tempo "sesta potenza economica del pianeta", rimane impotente di fronte alle fluttuazioni del mercato mondiale.
Serve un minimo di basi socio-economiche perché le strutture politiche tengano. Le multinazionali vogliono che ci siano poteri politici abbastanza deboli perché non disturbino i loro affari, ma abbastanza forti da mantenere l'ordine di cui hanno bisogno. Quando dopo il 2003 l'Iraq si è ritrovato diviso in tre pezzi, non c'erano più le basi per una Stato, lacerato com'era fra "sunnita" e "sciita". Solo la zona curda del nord del paese è riuscita a costituire un proto-Stato economicamente e politicamente attuabile.
Mutazioni
Il Califfato è l'ennesima reazione all'ingerenza occidentale nel mondo arabo da quando c'è stata la fine dell'impero ottomano, e si presenta come difensore dei musulmani nel mondo. La sua probabile fine non farà scomparire le cause che spiegano la sua creazione, e che rimarranno fonte di mobilitazione, violenta per una minoranza. L'Afghanistan nel 2001 è stato l'unico importante obiettivo del "terrorismo": da allora si è diffuso in una mezza dozzina di paesi, anche in Africa. Il fallimento del Califfato sarà una sorta di ritorno di Al Qaeda: non più controllore di un territorio, favorirà dei combattenti nomadi, senza alcuna base territoriale, senza terra, gli "emigrati" del terrorismo. Eccoci in guerra per trent'anni, ha detto un ex capo della CIA.
La morte di Baghdadi non risolverà più di quanto abbia risolto la morte di Bin Laden o quella del Mullah Omar. L'Islam radicale, per usare questa parola, ha assunto forma territoriale solo con la rinascita del Califfato. Ne ha conosciuto altre (la forma di rete, con Al Qaeda) e ne inventerà di nuove. Per i jihadisti, disporre di uno Stato non è indispensabile, la miseria e la confusione locale sono sufficienti. Quando nel Caucaso, nello Xinjiang, in Nord Africa o in Indonesia si accenderanno i prossimi fuochi jihadisti, a seconda se verranno ritenuti minacciosi o se verranno visti di buon occhio, ciascuno Stato reagirà in maniera differente, partecipando o meno alla "lotta contro il terrorismo".
Il Califfato, ufficialmente creato il 29 giugno 2014, ha la sua realtà sul territorio. In Occidente, ne ha un'altra, quella di spauracchio a vantaggio di ogni potere. Le atrocità che lo aiutano a vincere a Raqqa servono ai governanti di Parigi e di Londra per mobilitare l'opinione pubblica contro di esso.
Resistenza
Non cedere al consenso, significa anche mantenere o ridare il loro senso alle parole.
Quarant'anni fa, era frequente teorizzare i palestinesi come dei "senza-riserve" portati inevitabilmente a rimettere ben presto in discussione l'ordine capitalista in Medio Oriente. Questa regione produce oggi dei senza-riserve in misura almeno dieci volte tanto di quanto ne producesse allora la Palestina [*11]. Milioni di persone in Iraq ed in Siria hanno perduto tutto o quasi, l'immensa maggioranza sopravvive come può, ed una minoranza si arruola o viene arruolata al servizio di un campo anti-proletario contro altri campi anti-proletari.
Lo spossessamento non crea affatto ipso facto una riserva di forza rivoluzionaria. Quando la società si disloca e quando lo Stato perde terreno, se il movimento rivoluzionario è debole, quel che "nasce spontaneamente dal suolo della società moderna" [*12] non è un partito rivoluzionario "nella sua più ampia accezione storica", ma delle bande armate che lottano per dividersi il potere e le ricchezze, o per la semplice sopravvivenza.
Si andrebbe altrettanto fuori strada trattando la religione come una vecchia moribonda: arcaismo liturgico e modernità tecnologica non sono incompatibili. Oggi va di moda deridere l'incongruenza storica del programma islamista radicale. Eppure, lo Stato Islamico è poi così "primitivo" quando rispedisce le donne nelle case nel momento in cui il capitale crea delle masse che non è in grado di trasformare in salariati? A partire dalla rivoluzione industriale, secondo le epoche e le loro crisi, il capitalismo ha fatto entrare, uscire e poi di nuovo rientrare delle masse di donne nel mondo del lavoro, combinando pressioni economiche e giustificazioni morali. La "complementarità uomini donne" rivendicata dallo Stato Islamico rinnova la scelta del sessismo a modo suo [*13].
Non seppelliamo troppo presto tutto il nazionalismo. Se quel che è accaduto nella ex Jugoslavia dopo il 1980 non è stato sufficiente, volgiamo lo sguardo verso l'Ucraina di oggi. Oppure, per rimanere in Medio Oriente, guardiamo verso il quasi-Stato curdo che esiste a partire dal 2003 nel nord dell'Iraq.
Gli internazionalisti non possono accontentarsi delle formule risalenti ai tempi in cui l'esercito di leva era la regola. Nei paesi occidentali contemporanei, la mobilitazione riguarda innanzitutto lo spirito, e non si chiede più di uccidere, ma di lasciare che i professionisti uccidano. Il consenso guerriero del 21° secolo non rassomiglia alla Sacra Unione del 1914 [*14]. Lo Stato moderno più che fare appello al militarismo patriottico mantiene stordimento e passività. Ammutinamenti e rivolte prendono strade diverse rispetto a quelle del 1917.
Ciò che non è cambiato, è che anche il regime più democratico non esita a prendere delle misure dittatoriali se ritiene minacciata la sicurezza dello Stato [*15]. Nel 1905, la Russia inviò 300 mila soldati per ristabilire l'ordine in Polonia, ossia più di quanti ne inviasse contro i giapponesi in Oriente: il pericolo interno avrà sempre priorità sul nemico esterno.
- G.D. - giugno 2016 - pubblicato su DDT21 Douter de tout… -
NOTE:
[*1] - Due guerre locali - Internazionale Situazionista n°11, ottobre 1967.
[*2] - Isabelle Sommier, « Du « terrorisme » comme violence totale ? », Revue internationale des sciences sociales, n° 174, 2002
[*3] - « Global War On Terror Has Killed 4 Million Muslims Or More », Mint Press News, 3 août 2015 Sur les drones : « Drone Warfare », The Bureau Of Investigative Journalism.
[*4] - Il Lato Cattivo, Question kurde, État Islamique, USA & autres considérations.
[*5] - New York Review of Books, 2 juin 2015.
[*6] - Secondo la formula di William Blum, L’État voyou, Parangon, 2002.
[*7] - In questa suddivisione della regione, il Trattato di Versailles ha contato almeno quanto gli accordi Sykes-Picot del 1916 : Margaret McMillan, Paris 1919 : Six Months That Changed the World, Random House, 2003.
[*8] - Bruno Astarian, Luttes de classes dans la Chine des réformes (1978-2009), Acratie, 2009.
[*9] - Daniel Cohen lo riconosce a modo suo e con i suoi rimedi : Le Monde est clos et le désir infini, Albin Michel, 2015.
[*10] - Impossibile dire in dettaglio quanto esposto in L’Appel du vide, 2003 ; Irak : Fausses routes, 2004 ; Demain, orage. Essai sur une crise qui vient, 2007 ; Zone de tempête (sur la crise advenue), 2009, tutti consultabili sul sito troploin. Un'analisi più sintetica in De la Crise à la communisation, chap. 4, in pubblicazione per Entremonde nel 2016.
[*11] - Il Lato Cattivo, Lettre sur l’antisionisme, 2014.
[*12] - Karl Marx, « Lettre à Freiligrath », 29 février 1860.
[*13] - Le Présent d’une illusion, 2006, et Tristan Leoni, Du spirituel dans l’homme et le prolétaire en particulier, 2015.
[*14] - Su un punto comunque niente di nuovo: allo Stato non mancheranno dei brillanti spiriti per rafforzare la sua causa, come Freud che nel luglio 1914 dichiara, quando viene a sapere della dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia: "Tutta la mia libido la offro all'Austria-Ungheria" (Charles Clark, Les Somnambules, Flammarion, 2013, p. 465).
[*15] - « Ennemi Intérieur : Le Monstre sur le seuil », 2016.