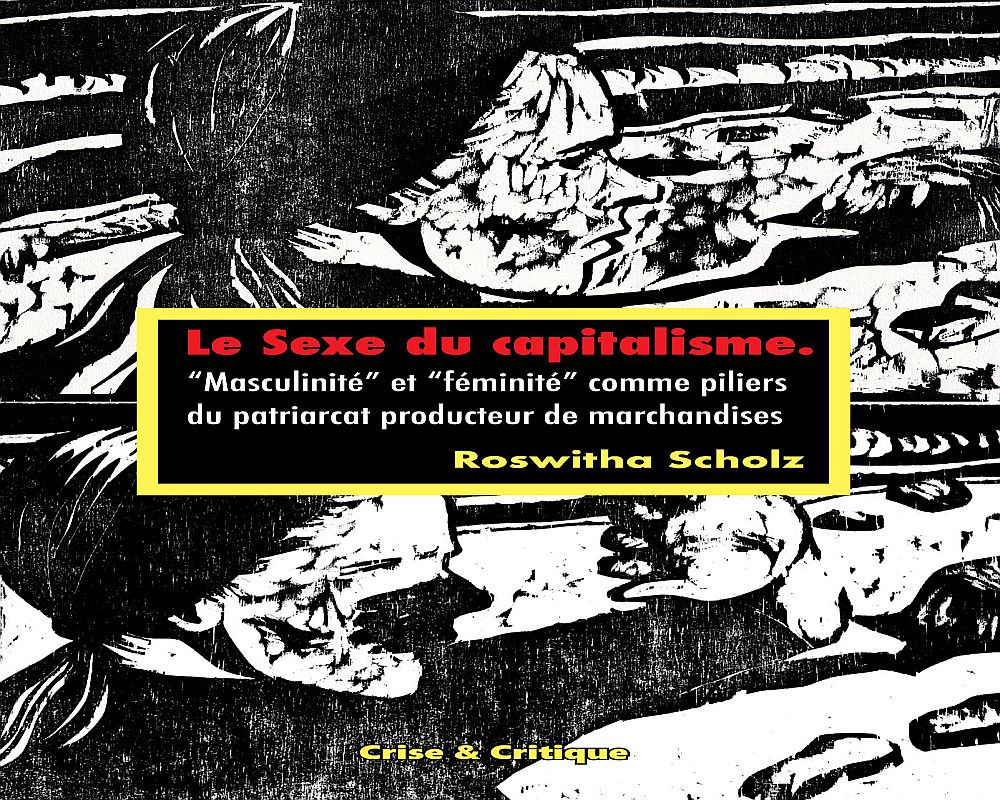Marx e Freud in Lacan: dall'inestricabile intreccio alla perfetta compatibilità
- di David Pavón -
Sembra che, politicamente, Jacques Lacan sembra sia stato un conservatore. Di certo non era un comunista, e nemmeno un socialista. Ha deriso a più riprese sia gli intellettuali marxisti che gli attivisti di sinistra. Quando era giovane, dichiarò di essere un sostenitore della monarchia, e partecipò alle riunioni di un'organizzazione di estrema destra, l'Action Française. Anni dopo, in piena maturità, ha ammesso di aver votato a destra, per Charles de Gaulle.
Sebbene di destra e ostile al marxismo, Lacan ha sempre mostrato grande interesse, e un'ammirazione quasi fervente per Marx. Non ha mai smesso di leggerlo, e di riferirsi a lui con passione. È vero che a volte lo ha criticato, ma più spesso ha riconosciuto i suoi grandi meriti, i suoi successi e le sue scoperte. Inoltre, ha ampliato molte delle sue idee usandolo ripetutamente in quella che è stata la sua interpretazione del pensiero freudiano.
Negli scritti di Lacan, e nel suo insegnamento orale, Marx non smette di continuare a incontrare Freud. Gli incontri, tanto frequenti quanto consistenti, profondi e significativi, a volte danno luogo a relazioni strette che organizzano internamente la teoria lacaniana. Tuttavia, quale che sia il grado di citazione di Marx messo in atto da Lacan, appare chiaro che a lui non viene conferito lo stesso posto di Freud. Lacan non adotta il punto di vista di Marx. Non si considera un suo seguace.
Lacan si attiene a Freud. È a lui che aderisce. Si considera un freudiano, non un marxista, e di certo non un freudo-marxista. La sua visione del freudo-marxismo non è per niente positiva. Lo descrive, nelle sue stesse parole, come se si trattasse di un groviglio inestricabile, come se fosse il «vicolo cieco», o «senza soluzione».
Ciò che nel freudo-marxismo appare ingarbugliato, è soprattutto freudiano e marxista. I riferimenti a Marx e a Freud cominciano a intrecciarsi l'uno con l'altro, e così facendo, allora, ecco che questi intrecci freudo-marxisti si intrecciano anche inestricabilmente tra loro nelle diverse polemiche o nei tentativi di sintesi che il freudo-marxismo cerca di attuare.
Ricordiamoci del groviglio inestricabile al quale tra il 1926 e il 1935 parteciparono i freudo-marxisti Siegfried Bernfeld, Wilhelm Reich e Otto Fenichel. Bernfeld utilizza le pulsioni descritte dalla psicoanalisi al fine di spiegare il funzionamento dell'economia così come viene studiata nel marxismo; cosa che gli vale la sfida da parte di Wilhelm Reich, il quale preferisce spiegare lo psichico di Freud per mezzo dell'economico di Marx, cioè, nelle parole dello stesso Reich, questo significa spiegare la psiche e la sua repressione a partire dal radicamento ideologico del capitalismo e della sua logica di sfruttamento. Come si può constatare, in una simile polemica - già abbastanza confusa - Reich sostiene ciò che è esattamente il contrario di quanto sostiene Bernfeld. Tuttavia, come se intuisse che Bernfeld abbia in parte ragione, ecco che allora Reich riprende anche lo schema di Bernfeld, e cerca quindi di fare una sintesi dialettica con il proprio schema, affermando, in maniera ancora più contorta, che la psiche avrebbe un «substrato economico», allo stesso modo in cui l'economia ha una «struttura psichica» fatta di pulsioni. Secondo Reich, in altre parole, Freud si occupa della struttura di ciò che studia Marx, mentre Marx studia il substrato di ciò che Freud analizza.
L'intreccio si aggrava ulteriormente, fino a diventare completamente inestricabile nel momento in cui entra in scena Fenichel, spinto dal suo desiderio di riconciliare Bernfeld con Reich grazie a una sintesi dialettica che assomiglia alla sintesi reichiana substrato/struttura. Il punto è che Fenichel ritiene che Reich abbia ragione per quel che concerne il mondo interiore, mentre Bernfeld avrebbe ragione sul mondo esteriore. Pertanto, nella società, ciò che Marx studia sarebbe la base determinante di quello che studia Freud, mentre nella psiche avverrebbe il contrario: i fattori psichici dei quali si occupa Freud sarebbero perciò la base determinante i fattori economici di cui parla Marx. In termini marxisti, la base interiore, psichica, sarebbe la sovrastruttura esterna, mentre invece la base esteriore, economica, sarebbe la sovrastruttura interna.
Anche se è vero che gli sforzi di sintesi dialettica di Reich e di Fenichel, sembrano meritare quell'etichetta di «pasticcio inestricabile» che viene sostenuta anche da Lacan, tuttavia, sebbene lo ammettiamo, bisogna riconoscere che il groviglio è confuso a partire dal fatto che ha sfidato la tradizionale separazione dualistica interiore/esteriore, esprimendo una sorta di monismo, una continuità invertita tra l'esteriore e l'interiore, tra il campo di Marx e quello di Freud, che poi anche lo stesso Lacan cercherà di cogliere una trentina o quarant'anni dopo attraverso il nastro di Moebius, la bottiglia di Klein e altre figure topologiche. In tutte queste figure, così come negli intrecci freudo-marxisti di Fenichel e Reich, l'esteriore continua e si inverte diventando l'interiore. La dialettica assume una forma topologica.
La topologia lacaniana ci permetterebbe perciò di rappresentare, in modo chiaro e distinto, ciò che invece non può che apparire inestricabilmente aggrovigliato nel discorso dialettico di Reich e Fenichel; ma anche in quello dello stesso Lacan, perlomeno quando cerca di descrivere a parole le figure topologiche. È come se i nostri discorsi fossero intrinsecamente dualistici e resistenti alla manifestazione di una realtà come quella che viene presupposta dal monismo. Se è davvero così, ecco che allora l'inestricabile pasticcio del freudo-marxismo dovrebbe essere preso sul serio, dal momento che non sarebbe falso in sé, ma rivelerebbe piuttosto la verità in una forma inadeguata, o, forse, nemmeno inadeguata, ma solamente complessa, enigmatica, non ovvia, un po' difficile da percepire. Ecco che allora la verità, nel freudo-marxismo, verrebbe scoperta nell'unico modo in cui può essere scoperta secondo Lacan: coprendosi nella sua scoperta e senza scoprirsi completamente.
Di quale verità stiamo parlando? L'ho già detto: quella del monismo. La verità in questione è quella che nega la differenziazione dualistica tra interiore ed esteriore, tra psichico ed economico, tra oggetto di Freud e oggetto di Marx. Sia l'uno che l'altro oggetto sarebbero esattamente gli stessi. Ci sarebbe un'identità tra l'uno e l'altro. È a questo che Lacan si riferisce quando parla di «omologia» tra il suo plus-godere, che è lo stesso di Freud, e il plus-valore di Marx. Dire che questi oggetti sono omologhi, per Lacan, vuol dire ammettere che essi non sono degli «analoghi», simili o comparabili, ma che sono identici, non essendoci tra loro solo una pura e semplice «identità».
Ammettendo che gli oggetti di Marx e di Freud siano esattamente gli stessi, si capisce come un freudo-marxista si confonda nel momento in cui cerca di metterli in relazione. Come si fa a non confondersi cercando di mettere in relazione la stessa cosa con la stessa cosa? La psicoanalisi e il marxismo non sono tali da poter essere messi in relazione tra loro perché sono identici. O come dice Lacan, riferendosi esplicitamente ai discorsi di Marx e Freud: «Non stanno bene insieme, sono perfettamente compatibili. Combaciano, si incastrano insieme (...)». Si attraversano già l'uno con l'altro. Non c'è quindi alcun bisogno di abbinarli. Meglio non farlo: è meglio non riferire la stessa cosa alla stessa cosa, e che serve solo a ingarbugliare. Eppure, il groviglio non è del tutto sterile. A volte ci permette di scoprire la causa del groviglio, vale a dire, l'identità profonda tra il marxismo e la psicoanalisi. Questa scoperta è stata fatta in modi diversi da tutti coloro che hanno preceduto Lacan nell'identificare la coincidenza tra marxismo e psicoanalisi, come hanno fatto Luria e Trotsky in Unione Sovietica, o gli stessi Reich e Fenichel in Austria e in Germania. Tutti loro, ognuno a suo modo, intravvidero come le prospettive di Marx e Freud fossero più che semplicemente simili o convergenti, al momento che coincidevano assolutamente nei loro aspetti materialisti, dialettici e storici.
Luria ha trovato il medesimo orientamento monistico sia nel patrimonio marxista che in quello freudiano. Tutti e due, seguendo la singola superficie del nastro di Moebius, finirebbero per scoprire il dentro nel fuori e il fuori nel dentro. Ed è proprio questo che permetterebbe loro, secondo Luria, di scoprirsi a vicenda. Questo è esattamente ciò che i surrealisti Breton, Crevel e Tzara hanno descritto in altri termini, riferendosi alla continuità e ai vasi comunicanti in maniera capillare tra interno ed esterno, tra sogno e realtà, tra campo freudiano e campo marxista.
Sappiamo che l'insegnamento monistico del surrealismo è stato decisivo per Lacan che, seguendo quella tradizione che era stata inaugurata da coloro che lo avevano preceduto nel freudo-marxismo e in altri marxismi freudiani, ha anche tentato di enumerare tutti qui punti in cui le eredità di Marx e Freud coincidono fino a essere identiche, omologhe, indistinguibili. Il primo punto è la «passione di rivelare», insieme al suo oggetto, la «verità», per la quale sia Marx che Freud sarebbero ugualmente indistinguibili, dal momento che il vero è «sempre nuovo». Il secondo punto di coincidenza tra il marxismo e la psicoanalisi ha a che fare con la verità anch'esso: sta nel considerare la verità come qualcosa di sintomatico, di irregolare, di sorprendente, di inquietante. Il terzo punto coincide con la concezione materialista di «soggetto cosmico», materiale, incomprensibile, opaco. Il quarto è il riconoscimento dell'esistenza della struttura latente, psichica o economica, organizzatrice e costitutiva di ciò che è palese. Il quinto e ultimo punto è dato dal modo in cui le eredità marxiste e freudiane vengono trasmesse poeticamente - tanto reali quanto simboliche, tanto sessuali quanto sociali - attraverso il testo e la sua lettera, mediante la militanza e il transfert, per mezzo dei partiti comunisti e delle associazioni psicoanalitiche.
Se Marx e Freud possono convergere - così come fanno - ciò forse avviene perché trattano esattamente la medesima cosa. Sarebbe perciò l'identità stessa dell'oggetto a farli coincidere nei punti individuati da Lacan. Tali punti di coincidenza potrebbero confermare, in quelle che sono le varie sfere concrete, gli effetti del monismo che Luria postula in una maniera forse un po' astratto.
Sarebbe come se ciò che Luria postula, malgrado la sua astrazione, fosse la formulazione più esplicita di ciò che si trova alla base dell'identità, o dell'omologia tra Marx e Freud. Del resto si tratta di una formulazione che non indica il suo oggetto senza spiegarsi: non si tratta solo di ciò in cui Marx e Freud coincidono, nel loro monismo, ma gli è che questo monismo spiega anche il coincidere stesso che l'uno ha con l'altro. Diciamo che entrambi hanno scoperto qual era la causa stessa della loro rispettiva coincidenza. Questo punto è cruciale, ma complica certamente ciò che sta sostenendo Luria. D'altronde, sappiamo che nella sua epoca il suo brillante approccio non è stato realmente compreso.
Le critiche che Luria ricevette da Voloshinov, e persino dal suo amico Vygotsky, sono note. Consistono nella stessa domanda che altri rivolgeranno ai freudo-marxisti. Il principale rimprovero, infatti, coincide con quello espresso da Lacan. Il problema di Luria è che egli vorrebbe mescolare il marxismo con la psicoanalisi. Così facendo, procederebbe perciò come un tipico rappresentante del freudo-marxismo.
Ci si può chiedere se Lacan si sia mai reso conto di quanto, in questo, a essere in gioco fosse l'intreccio freudo-marxista e marxista-freudiano del periodo tra le due guerre. Penso che la risposta debba essere sì. Forse nessuno è arrivato a misurare la posta in gioco, così bene come Lacan.
Il monismo dei surrealisti, che poi è lo stesso monismo che spiega l'imbroglio freudo-marxista, verrà sviluppato da Lacan in maniera profonda e ampia. Attraverserà tutta la sua teoria. Sarà compatibile prima con il suo spinozismo, poi con il suo hegelismo, poi con il suo strutturalismo, e infine con il suo topologismo; se si può applicare l'-ismo alla sua topologia.
Paradossalmente, il monismo dei surrealisti e dei freudo-marxisti sarà una delle ragioni per cui Lacan sembrerà così invischiato, così inestricabilmente aggrovigliato, allo stesso modo in cui lo sembrano coloro ai quali egli deve tanto. Sarà proprio quella stessa prospettiva monistica che darà luogo a delle penetranti concettualizzazioni lacaniane; tra le quali l'esteriorità dell'inconscio, l'assenza di metalinguaggio e l'extimità, con cui si designa l'intimità radicalmente esterna. Questi concetti descrivono in modo preciso e penetrante ciò che Luria, i freudiano-marxisti e i surrealisti prevedevano a partire dalla loro prospettiva.
È noto come Jean Audard, poeta e critico vicino al surrealismo, avesse attratto l'attenzione del giovane Lacan pubblicando un testo sorprendente nel quale proponeva una fondazione freudiana del marxismo simile a quella che Bernfeld aveva elaborato poco prima sull'altra sponda del Reno. Per Audard, il marxismo poteva essere autenticamente materialista solo se riconosceva che alla base dello sviluppo delle forze produttive, alla base del fondamento delle spiegazioni marxiste, si trovavano non solo le idee scientifiche e le loro applicazioni tecnologiche, ma anche le pulsioni e la loro materialità corporea. Questo materialismo perfettamente monistico venne duramente criticato da Georges Politzer, che trovò negli scritti di Audard il miglior esempio del groviglio freudo-marxista. Tuttavia, molti anni prima di giudicare il garbuglio freudo-marxista, il giovane Lacan rimase abbagliato dal testo di Audard, e volle conoscere di persona l'autore.
È impossibile avere un'idea chiara di cosa esattamente Lacan abbia imparato da Audard. Né sappiamo esattamente cosa in generale egli debba ai surrealisti. Il monismo proviene da loro e dal legame particolare che loro hanno con Marx e con Freud, ma proviene anche da Marx e Freud stessi, da Spinoza e poi da Hegel ripreso da Kojève a partire da una lettura marxista e heideggeriana.
Quello che è certo è che qui esistono delle coincidenze tra Lacan e i vari freudo-marxismi. Ciò spiega anche la passione che Lacan ha per Marx, così come l'orientamento monistico della sua teoria insieme allo stile contorto che la caratterizza. Nel suo aspetto stilistico, il groviglio lacaniano rimanda irresistibilmente a Crevel e ad altri freudo-marxisti. È un modo questo, per non cedere alla tentazione del dualismo, che è anche, d'altronde, la tentazione della facilità.
- David Pavòn - 30/9/2018 - Pubblicato su GRUNDRISSE il 2 gennaio 2022 -
fonte: GRUNDRISSE Psychanalyse et capitalisme