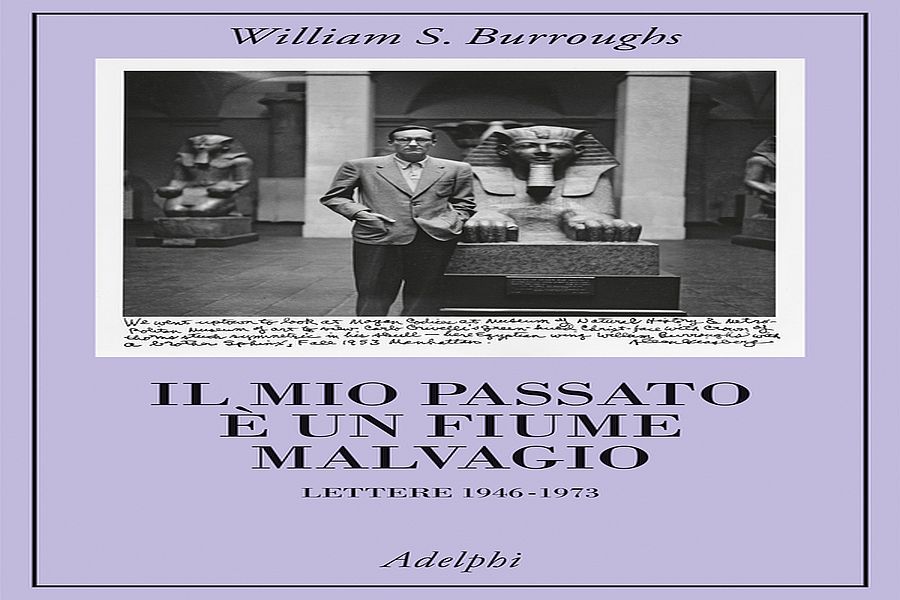Regno del valore e distruzione del mondo
- Sandrine Aumercier, Benoît Bohy-Bunel e Clément Homs a nome del Comitato di Redazione del Collectif Jaggernaut -
«La teoria non conosce altra "forza costruttiva" se non quella che consiste nell'illuminare, servendosi del riflesso della catastrofe più recente, i contorni della preistoria devastata dal fuoco, al fine di intravvedere ciò che, in essa, corrisponde a questo disastro.» ( da Theodor W. Adorno, Société : Intégration, Désintégration, p. 60 )
Lo spettro che ossessiona il mondo moderno ci porta sempre meno a credere che possa esserci un futuro radicalmente diverso da una devastazione irreversibile. In tal senso, l'estate 2021 non è stata meno emozionante degli anni precedenti: devastanti inondazioni in Germania, Belgio, a Londra e in Giappone; in Canada (un luogo simile alla Bretagna in tempi normali) le temperature sono arrivate a 49,6°C, a 48°C in Siberia, a 50°C in Iraq; Nuova Delhi ha dovuto affrontare quella che è stata la peggiore ondata di calore negli ultimi dieci anni; il Madagascar sta ancora soffrendo una grave carestia a causa della siccità; La California, la Siberia, la Turchia e Cipro sono in fiamme; il Golfo del Messico è coperto da una gigantesca fuga di gas; la città di Jacobabad in Pakistan, insieme a Ras Al Khaimah nel Golfo Persico vengono ora considerate inabitabili a causa del riscaldamento globale; e più vicino a noi, gli incendi hanno inghiottito la regione del Var. Il riscaldamento globale, addirittura si intensifica e si consolida grazie al rilascio di una maggior quantità di gas serra, a causa dello scioglimento del permafrost. Attraverso le fonti di ricchezza sociale astratta aperte dal capitale, ora scaturisce e scorre non solo un'enorme quantità di merci, ma anche la sua contropartita: una quantità inesauribile di inquinamento e di nocività. Il regno del valore - il quale non è altro che la distruzione della socialità - rimette in discussione le basi stesse dell'esistenza sulla terra in generale, e dell'umanità in particolare, la quale ora si trova così di fronte alla necessità assoluta di abolire la forma sociale capitalista, pena la propria scomparsa. È fin troppo evidente la contraddizione tra gli imperativi sempre più aggressivi della crescita economica, da un lato, e la limitatezza delle risorse materiali e l'incapacità dell'ambiente naturale di assorbire i rifiuti, insieme all'inquinamento prodotto dalla civiltà guidata dal movimento del capitale, dall'altro lato.
Certo, è vero che la negazione della crisi ecologica è fortunatamente quasi scomparsa in tutto il mondo, e che da tempo non mancano più gli ammonimenti e gli allarmi. Nessuno che abbia un minimo di credibilità scientifica o intellettuale, mette in dubbio il fatto che il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità e l'esaurimento delle risorse naturali ci stiano portando verso una situazione catastrofica. E nessuno mette in dubbio il fatto che il margine di manovra per un cambiamento strutturale che mitighi il corso della catastrofe sia estremamente ridotto. Ma mentre fallisce una conferenza sul clima dopo l'altra, le emissioni globali di gas a effetto serra continuano a crescere senza sosta, con sullo sfondo un imperativo di crescita che non è mutato.
È noto, ad esempio, che - a eccezione del calo che c'è stato durante l'anno di recessione del 2009, e più recentemente durante i mesi di lockdown - le emissioni globali di CO2 continuano ad aumentare in maniera inesorabile, e si prevede che già nel 2023 verrà raggiunto un nuovo record mondiale. I risultati ottenuti, sui mercati del carbonio, nella lotta contro il cambiamento climatico non potrebbero essere peggiori. Tra il 1995 e il 2020, dalla COP3 alla COP24 (Conferenze di Parti delle Nazioni Unite), le emissioni globali di CO2 sono aumentate di oltre il 60%. L'aporia sistemica, implicita in una protezione del clima che non mette in discussione il capitalismo, è stata involontariamente dichiarata dal ministro verde-presidente del Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, nel marzo 2021, allorché ha confessato alla stampa, con sgomento, che «la critica secondo cui, noi siamo troppo lenti è vera. E che dovremmo cambiare è altrettanto vero. Vorrei solo sapere come fare.»
Quindi, sebbene vi sia un accordo sempre maggiore sulla diagnosi degli scienziati, e una consapevolezza sempre maggiore della gravità della minaccia, vi è anche un diffuso sgomento e disaccordo circa quale sia il significato storico della crisi socio-ecologica. Le accese battaglie politiche su come rispondere ad essa, riflettono in realtà una falsa unanimità e un persistente fallimento nell'identificare il principio operativo di questa traiettoria.
In questi ultimi anni, per spiegare tale situazione, il termine Antropocene è diventato il principale concetto ambientale, particolarmente popolare nelle scienze naturali e sociali. Lanciato nel 2002 dal chimico premio Nobel Paul Crutzen, il concetto sostiene di cogliere l'alterazione globale dei cicli naturali del mondo, iniziata con l'invenzione della macchina a vapore durante la prima rivoluzione industriale, e designa una nuova «epoca geologica dominata dall'uomo», la quale segue l'Olocene, che a sua volta è seguito all'ultima grande era glaciale (il Pleistocene), circa 11.500 anni fa. In questo Antropocene, è l'«essere umano» - anthropos - ad aver preso il controllo dei cicli biogeochimici del pianeta, diventando pertanto una forza geofisica. Avrebbe iniziato a trasformare la biosfera fino al punto di arrivare a minacciare la capacità del pianeta di dare continuità alla storia della vita. L'alterazione del ciclo del carbonio, del ciclo dell'azoto e la massiccia erosione della biodiversità stanno portando a quelli che sono oramai dei veri e propri punti di svolta planetari irreversibili, che vengono quantificati da degli eserciti di scienziati, e vengono regolarmente annunciati con grande clamore da tutti i principali media, ipnotizzando alcuni e rendendo castrofisti gli altri, mentre nel frattempo prosegue invariata la medesima traiettoria. Nutriti dalla Collassologia, alcuni strati urbani e privilegiati della popolazione, oggi soffrono di un'«eco-ansia» - o «solastalgia» - che viene indecentemente confusa con l'angoscia delle popolazioni indigene i cui spazi vitali vengono devastati. La diffusione di questi concetti va a completare quello che è un quadro di impotenza e di depoliticizzazione, dove le nuove ansie devono essere trattate alla stregua dei disturbi comportamentali. In breve, basterebbe solamente «imparare a convivere» e praticare la «resilienza».
Ma se l'«epoca geologica dominata dall'uomo» ci porta a una situazione in cui l'esistenza umana potrebbe essere compromessa, allora ciò vuol dire che nella visione di questo dominio della natura ridotta a un «substrato dominato» c'è qualcosa di assai problematico. Dopo tutto, bisogna che ci sia qualcosa di inumano, o di «oggettivante», in questo tipo di dominio da parte dell'«essere umano», il cui risultato potrebbe essere proprio l'estinzione degli esseri umani. In ultima analisi, l'Antropocene si rivela come una rottura non pianificata, non voluta, non controllata, vale a dire, come l'effetto collaterale di un «metabolismo sociale con la natura» (Marx) che è stato messo in moto dal capitalismo industriale e che è sfuggito di mano, andando fuori controllo. Questo può essere facilmente illustrato a partire da degli esempi. La combustione di carburanti fossili, per i sistemi industriali e di trasporto, non avrebbe potuto fare altro che provocare immancabilmente la perturbazione del ciclo del carbonio. L'estrazione massiccia di carbone ha avuto inizio in Inghilterra, durante la rivoluzione industriale, in modo tale che, grazie a questa nuova fonte di energia disponibile, le industrie potessero venire spostate, rispetto alle dighe, in modo da essere dislocate nelle città, dove si poteva trovare manodopera a buon mercato.
Non c'era alcuna intenzione di manipolare il ciclo del carbonio, o provocare consapevolmente il riscaldamento climatico. E tuttavia, il risultato è stato che nel XXI secolo la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera ha già superato il limite di sicurezza di 350 ppm, il cui rispetto è indispensabile per la sostenibilità a lungo termine della vita umana. Perfino lo stesso ciclo dell'azoto è stato interrotto dall'industrializzazione dell'agricoltura e dalla produzione di fertilizzanti; industrializzazione che comporta la fissazione dell'azoto atmosferico per mezzo del processo Haber-Bosch. Tuttavia, il limite annuale, di 62 milioni di tonnellate di azoto che può essere rimosso dall'atmosfera, è già stato ampiamente superato, arrivando nel 2014 a 150 milioni di tonnellate. Nessuno ha pianificato tutto questo in maniera cosciente, non più di quanto sia stata pianificata l'eutrofizzazione dei laghi o il collasso degli ecosistemi. La stessa cosa sta avvenendo per ciò che riguarda la perdita di biodiversità, l'interruzione del ciclo del fosforo o l'acidificazione degli oceani. Da questo punto di vista, l'«epoca geologica dominata dall'uomo» assomiglia molto di più a un prodotto del caso e dell'incoscienza, piuttosto che allo sviluppo di una capacità di padroneggiare i cicli bio-geofisici planetari, malgrado i riferimenti che Crutzen fa a Vernadsky e a Teilhard de Chardin, i quali invece miravano piuttosto ad «aumentare la coscienza e il pensiero» e «il mondo del pensiero» (la noosfera). «Non sanno cosa stanno facendo, ma lo stanno facendo»: è questo ciò che Marx dice riguardo l'attività sociale feticizzata mediata dalla merce, in cui va vista la chiave per una comprensione critica dell'Antropocene.
Nondimeno, parlare di casualità e di incoscienza non vuol certo dire che la questione della responsabilità sia stata superata ed eliminata. Chi è questo anthropos, questo essere umano che fa capolino nel discorso sull'Antropocene? Si tratta della specie umana in generale, in maniera indifferenziata, di quell'umanità che non viene solo presa nel suo insieme (che non esiste), ma che è anche astratta da tutte le determinazioni storiche concrete? Questa immensa vaghezza concettuale, consente di giustificare la geoingegneria climatica - sostenuta da Paul Crutzen - o anche le ideologie dello sviluppo sostenibile, dell'economia circolare che dà la caccia ai rifiuti particolari, oppure il neo-malthusianesimo, il quale vede la causa del problema nella demografia dei Paesi periferici. Così facendo, ecco che l'anthropos finisce per essere colui che distrugge, ma anche allo stesso tempo colui che ripara; in modo da conservare così la doppia figura del progresso, prometeica e demoniaca, ereditata dalla prima era industriale e dall'Illuminismo. Affogando la responsabilità in un'umanità che in realtà è di fatto responsabile in maniera disuguale, così come ne rimane colpita in maniera altrettanto disuguale, la nozione di Antropocene appare chiaramente scorretta, e dà luogo a numerose discussioni circa le «soglie» storiche, oltre che a dei negoziati terminologici, nelle quali ciascuna parte tenta di dare un nome tanto all'agente quanto al paziente del disastro. Donna Haraway, per esempio, alla colonizzazione delle Americhe sostituisce il termine «Plantacionocene», come marcatore di questa nuova epoca e, più recentemente, «Chtulucene» - per invitarci ad «abitare il disordine», cioè a vivere e invecchiare nelle rovine: «siamo tutti compostaggio», sostiene Haraway. Per estetizzare la catastrofe, non c'è modo migliore di quello di diluire la responsabilità di questa situazione recente nella grande storia batterica del pianeta Terra. Tutti questi tentativi concettuali non colgono l'occasione di problematizzare l'origine logica della trasformazione e del soggetto che ne è portatore.
Va in un altro modo con il termine «Capitalocene», proposto da Andréas Malm o da Jason Moore, che cerca di spiegare i limiti del concetto di antropocene?
La nozione di «capitale fossile», sviluppata da Malm a partire dai materiali storici che evidenziano la coincidenza storica tra l'ascesa del capitalismo industriale e quella dei combustibili fossili, porta alla curiosa immagine di un Antropocene il cui agente sarebbero i combustibili fossili, e i cui responsabili sarebbero coloro che, tutt'oggi, continuano a difendere e a impiegare questi combustibili. Bisognerebbe, pertanto - è ovvio - metterli fuori legge. In linea generale, c'è una parte del marxismo dissanguato che negli ultimi vent'anni si è riciclata in un eco-socialismo che non ha mai abbandonato il dogma dello «sviluppo delle forze produttive»: ma ora è necessario buttarsi a capofitto nella produzione di pannelli solari e mulini a vento, e strapparne così la proprietà dalle grinfie dei capitalisti aggrappati alle loro ciminiere di carbone e ai loro pozzi e oleodotti. Ne deriva una concezione, non solo «leninista» ma anche ... lenitiva delle «energie rinnovabili». Ed è proprio da loro che Malm e gli eco-socialisti si aspettano la salvezza ecologica; in perfetta coerenza con la retorica ufficiale che ci promette un futuro verde e sostenibile, senza dire nulla a proposito dell'intensificazione estrattiva e della crescente devastazione mineraria che essa comporta. Nel frattempo, Total Energies sta giocando su entrambi i lati della barricata - verde e fossile - mentre Joe Biden, celebrato per la sua promessa di ripristinare gli accordi di Parigi, firma più permessi di trivellazione petrolifera in un anno di quanto ne abbia fatto Donald Trump in quattro anni. È quindi sempre più documentato, fino a che punto le energie rinnovabili non solo sono fonte di vera e propria devastazione, ma anche il modo in cui esse si aggiungono, semplicemente, alla traiettoria globale, senza modificarla minimamente.
Se non si vuole sdoganare il fatto che le «élite» siano coinvolte in questo doppio livello, ci si può solo interrogare sulla natura di questa cieca compulsione, la quale non conosce interruzioni e che sembra essere inesorabilmente destinata a spedirci tutti all'inferno, nel mentre che i giovani, simultaneamente, disgustati dall'inerzia del sistema, cercano di fare pressione sul dibattito parlamentare, con il rischio di rafforzare ulteriormente la gestione tecnica e l'adattamento al disastro. Ragion per cui sono molti - e non solo gli esperti - quelli convinti che un felice mix di tecnocrazia, de-carbonizzazione dell'economia, geoingegneria, transizione energetica, piccoli gesti ecologici, buona volontà e innovazione commerciale possa essere sufficiente a realizzare la «transizione» verso un nuovo capitalismo verde. In realtà, tutto ciò si sta mettendo sulla strada che va verso uno stato di eccezione permanente in cui tutti saranno chiamati a dare il loro contributo al prolungamento dell'agonia. E in tutto questo, le sofferenze e i compromessi del soggetto ordinario non sono meno determinanti di quelli dei decisori, i quali saranno incaricati dalla forma politica moderna di rappresentare il loro mandato fondamentale: la crescita. Tutti i portatori di funzione sono strettamente accomunati dalla medesima relazione sociale, rispetto alla quale sono impegnati a non sapere nulla, e della quale si incolpano l'un l'altro. In questo modo, con l'avanzare della crisi ecologica, l'angoscia si sta impossessando anche di coloro che, fino a poco tempo fa, negavano la realtà del cambiamento climatico: ormai, a fronte di un elettorato disperato, tutto l'intero spettro politico è ora ossessionato e innamorato dell'«urgenza climatica». Perfino l'estrema destra ha cominciato ad assimilare l'ecologia tra i suoi temi preferiti. Neo-malthusianesimo, darwinismo sociale, difesa armata del territorio e dell'identità nazionale, survivalismo, atti di terrorismo a sfondo ecologico: tutte queste tendenze in ascesa, segnalano la neo-fascistizzazione di una frangia della società che costituisce solo la punta di diamante di quelle che ora sono tendenze politiche trasversali. L'erezione di muri e l'abbandono al loro destino delle popolazioni superflue, a livello globale non meritano più alcuna giustificazione, e nell'indifferenza stanno diventando un luogo comune.
Nel frattempo, vediamo che alcuni sono impegnati a predicare valori umanistici e a fare campagne per il riconoscimento del crimine di ecocidio, o a favore dei «diritti» che la forma giuridica borghese dovrebbe concedere alle entità naturali. Il biocentrismo che fino a poco tempo fa caratterizzava l'ecologia profonda, è diventato in pochi anni il cavallo di battaglia di un'ecologia anti-specista, talvolta associata al veganismo, innamorata della conservazione e del ripristino della natura. Una natura trasformata in spettacolo, dove gli occupanti indigeni vengono evacuati o vessati; una natura spesso assai poco compresa dai suoi promotori, come dimostrano, tra gli altri, Charles Stepanoff e Guillaume Blanc nelle loro opere recenti.
Questo, dal momento che l'ontologia naturalista moderna rimane inseparabile dal capitalismo, e può quindi essere trovata solo nelle sue ideologie affermative di crisi. Il concetto moderno di «natura» si trova a essere interamente plasmato dalla forma-merce e dalla forma-soggetto borghese. Le scienze naturali moderne - seguendo Immanuel Kant - avevano presupposto un soggetto puramente formale, identico a sé stesso, in grado di sintetizzare la diversità dell'intuizione sensibile. Questo soggetto astratto rimaneva indipendente dall'empiria, e poneva la natura come se essa fosse un'esteriorità radicale che doveva essere sottoposta a giudizio. Questa soggettivazione moderna istituisce una dualità soggetto-oggetto, insieme a una natura puramente separata che non sono indipendenti dal processo di valorizzazione del valore. Istituisce inoltre un tempo astratto e uno spazio omogeneo che devono essere quantificati per poter essere controllati. La «natura» moderna è stata sottoposta a una logica di matematizzazione, cosa che ha permesso, tra l'altro, di ridurre tutto il non umano allo status di risorsa sfruttabile, in quanto componente del capitale costante. Allo stesso modo, il tempo di lavoro deve essere misurato, e la sua qualità concreta dev'essere negata, ai fini della sua gestione razionale e dell'estrazione del relativo plusvalore. Ciò che accomuna le scienze naturali e le scienze economiche, è la loro tendenza a quantificare sistematicamente ciò che è eterogeneo rispetto all'ordine del quantitativo: esse sono incapaci di cogliere ciò che rimane non identico alle forme omogenee della razionalità e della produzione moderna, vale a dire, la sofferenza del vivente senziente e consapevole, il contenuto qualitativo della forma astratta.
Analogamente, il capitale variabile e quello costante, anch'essi costituiti da individui vivi e sofferenti, vengono ridotti al rango di risorse valorizzabili e quantificabili, in un processo di produzione che li naturalizza e li reifica. Sono proprio queste stesse tecnologie ecologicamente distruttive a rendere sempre più superfluo il lavoro vivo. Nel momento stesso in cui il capitale fa del tempo di lavoro la fonte e la misura di tutta la ricchezza, esso tende anche a ridurre questo tempo di lavoro produttivo a un minimo sempre più precario. È una tale contraddizione a essere al centro di ogni soggetto del capitale. L'orrore del capitalismo risiede in ultima analisi nel fatto che non c'è nessuno che siede dietro il sipario e che tira le fila. Nessuno controlla il movimento di valorizzazione del capitale su scala globale: esso avviene attraverso il mercato, come processo a partire dal quale il denaro deve diventare altro e più denaro attraverso la produzione di merci e per mezzo del loro consumo. Perfino i capitalisti più potenti sono soggetti a questa coercizione; riassunta da Karl Marx con il termine feticismo sociale. La responsabilità del disastro, pertanto non può essere intesa solo in termini di quella che è l'identità di classe degli individui, ma piuttosto in termini di identificazione più o meno consensuale che ciascuno pone in atto con la forma di vita capitalistica.
Il capitalismo mobilita e utilizza le scienze naturali per poter così stabilire un soggetto solipsistico e narcisistico. il quale deve rendersi «padrone e possessore della natura» (Cartesio). Le moderne scienze naturali confezionano e realizzano tecnicamente i loro esperimenti, a partire dalla configurazione di una natura che possa essere omogenea al calcolo matematico. Quella che viene tematizzata, non è affatto una «natura» disordinata e qualitativa, ma una natura tecnicamente elaborata, sterilizzata, che viene assegnata a un soggetto astratto identico a sé stesso. Allo stesso modo in cui le tecniche implicano, nella produzione, una reale sussunzione del lavoro concreto sotto il lavoro astratto, così avviene anche una sempre più reale sussunzione della natura sotto il valore. È questo il modo in cui, la logica della concorrenza e la logica dell'estrazione del plusvalore relativo, spingono sempre più lontano l'automazione della produzione, fino alla recente rivoluzione microelettronica (1970-80), fino a distruggere sempre più il pianeta, ma anche fino a condannare il capitalismo a un processo irreversibile di de-sostanzializzazione del valore. Il limite esterno (la crisi ecologica) e quello interno (la crisi economica) del capitalismo sono sottilmente intrecciati, come mostra il «frammento sulle macchine» dei Grundrisse. Di conseguenza, il superamento del capitalismo non potrà essere realizzato a partire da una scienza «positiva», e neppure dall'economia. Un pensiero critico che rimetta in discussione l'egemonia del calcolo e della quantità, e che tematizzi le sofferenze e i desideri dei soggetti, visti nella loro dimensione irriducibile, può essere anche in grado di criticare il rovesciamento feticista-mercantile tra astratto e concreto, tra mezzi e fini.
Il soggetto solipsistico che porta strutturalmente avanti il progetto naturalista-capitalista, è il soggetto maschile, occidentale, bianco. È la scienza naturale, che costruisce tecnicamente una natura quantificabile modellata dalla forma-merce, che consolida, come prima cosa, la dissociazione sessuale. La natura «informe» e «caotica», che deve essere inquadrata e disciplinata, è stata associata (fin da Bacone) al femminile. Come viene spiegato da Roswitha Scholz (1992), la dissociazione forma-contenuto è una dissociazione specifica relativa al genere. In seno alla moderna dissociazione sessuale, la forma-valore rimanda al soggetto della concorrenza competitiva, razionale e illuminista, il quale è tipicamente un soggetto maschile, laddove invece il contenuto irrazionale, che può essere riferito alla sensibilità, alla cura, alla sfera riproduttiva e all'erotismo, viene assegnato al (non) soggetto femminile.
Questa struttura dissociativa appare essere inseparabile dalla moderna economia disincarnata, la quale separa funzionalmente le sfere della produzione di valore (maschile) e della riproduzione privata (femminile). Il dominio della natura esterna è inseparabile dal dominio di una natura interna, femminilizzata, dichiarata senziente, informe e irrazionale. Analogamente, non si suppone che gli indigeni abbiano quella razionalità critica che ha trionfato con Kant e l'Illuminismo. Il naturalismo viene quindi proposto come una vera e propria unità escludente, e come una totalità spezzata. Pertanto oggi è impossibile distinguere in maniera rigorosa tra la storia del sovra-sfruttamento coloniale e le questioni legate al dominio della natura «esterna», dal momento che si tratta del medesimo soggetto astratto che, nella modernità, ha sviluppato questo naturalismo capitalista multidimensionale.
Quindi, oggi, la critica alla distruzione di ciò che è vivente presuppone anche la critica radicale delle scienze positive oltre che delle tecniche moderne, ma anche la comprensione di quella che appare come un'intima connessione tra crisi ecologica, sociale ed economica. E presuppone anche una critica del patriarcato produttore di merci, insieme a quella di un razzismo strutturale e naturalizzante. Al giorno d'oggi, le specializzazioni e le compartimentazioni impediscono di vedere questi fenomeni multidimensionali. Tali specializzazioni teoriche sono a immagine della divisione capitalistica del lavoro, e sono esse stesse alienate di per sé. Come scrive Kurz nel 1° capitolo de La sostanza del capitale, a essere totalitaria non è la critica della totalità. E ciò perché il valore distruttivo è rappresentato proprio da questa totalità (spezzata), ed è questa totalità che deve essere assolutamente criticata. La critica della totalità capitalista non mira a postulare questa totalità a scapito del non-identico - come le rimprovera il pensiero postmoderno - ma pretende di elevare la critica all'altezza del totalitarismo della forma. Una «critica» sparpagliata o frammentaria riproduce quelle separazioni e quelle compartimentazioni delle scienze positive, le quali si mantengono entro i limiti stabiliti dalla moderna divisione del lavoro.
La critica del capitalismo non può adottare la prospettiva naturalista e vitalista che è alla base della modernità. Non mira a salvare una «natura» idealizzata, e neppure un'«umanità» idealizzata come specie, e ancor meno un capitalismo che concepisce sé stesso come se fosse una forza della natura. Non può allearsi con le diverse varianti politiche di questo naturalismo, le cui contraddizioni attualmente tendono a essere superate per mezzo di una gestione sempre più totalitaria della vita, della salute e della popolazione. Questa critica si basa invece su un'epistemologia della natura che tiene conto del fatto che possiamo parlarne solo in seconda battuta, e che quindi possiamo difendere la natura solo difendendo la possibilità di una società veramente umana. Stabilire in maniera critica le condizioni per l'emancipazione della società, è l'unica via per un'ecologia radicale, anche se di fronte all'urgenza e all'aumento delle catastrofi molti saranno tentati di rifugiarsi nelle ideologie della crisi di cui abbiamo appena mostrato alcuni scorci. La critica epistemologica del concetto di natura, rappresenta una deviazione teorica che non è una vana raffinatezza, e non è neppure «tempo perso a detrimento dell'urgenza dell'azione», ma prende piuttosto in considerazione lo statuto della «seconda natura». Inoltre, mira ad articolare la critica marxiana dell'economia politica insieme a una critica delle tecnologie, delle scienze e delle forze produttive moderne.
- Sandrine Aumercier, Benoît Bohy-Bunel e Clément Homs a nome del Comitato di Redazione del Collectif Jaggernaut -
- Editoriale della Revue Jaggernaut n°4, Crise & Critique, 2022, 16 euros. -
Disponible en librairie (France, Suisse, Belgique) ou en livraison sur le site Crise & Critique