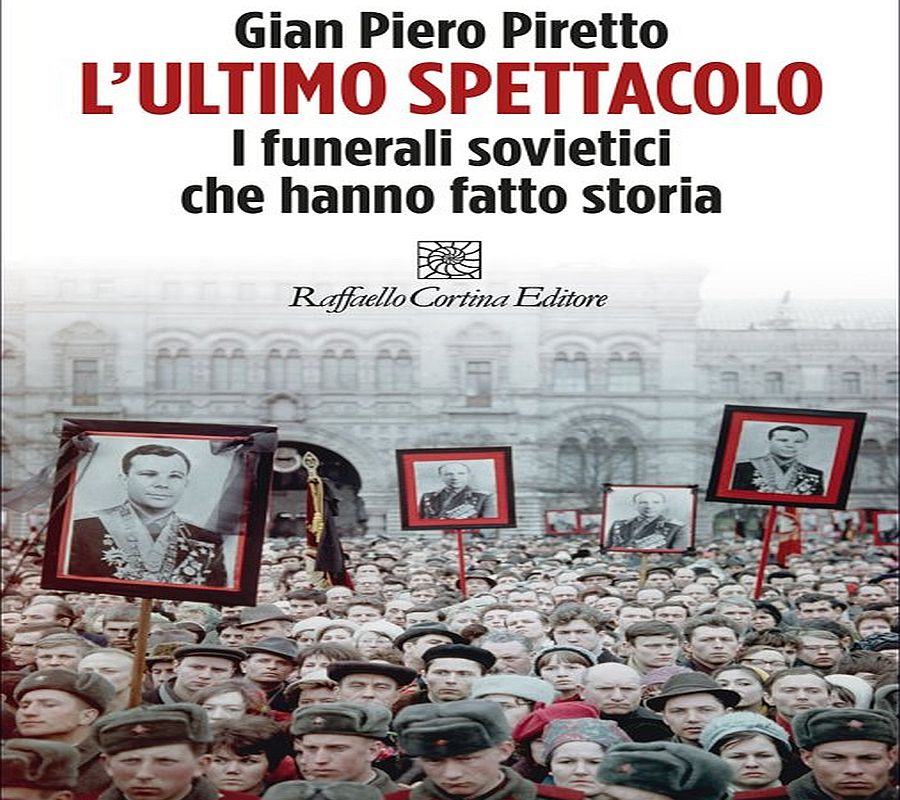I LUPI SONO ENTRATI IN UCRAINA - Quaderno di guerra #16 -
- Un punto di vista anticapitalista. Prima sintesi -
di Jean-Marc Royer
«La resistenza all'oppressione è la conseguenza di tutti gli altri diritti dell'uomo». Dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1793, articolo 33.
Il metodo
L'epoca in cui viviamo esige un rendimento sempre più elevato degli investimenti e una circolazione sempre più veloce di tutte le merci e di tutti gli esseri, cosa che si oppone implacabilmente alla lentezza necessaria a stabilire con un buon grado di certezza la realtà dei fatti, nonché al rigore della loro analisi e, ancor più, alla loro integrazione nella Storia contemporanea. Per di più, dato che la storia ufficiale (in particolare quella della Russia) ha bisogno di una profonda revisione [*1], e lo sviluppo di concetti che ci consentano di ricostruire una teoria critica [*2] appare balbettante, si può solo immaginare la montagna di difficoltà che ci attendono.
I quindici "Diari di guerra" [*3] scritti a partire dal marzo 2022 si sono perciò concentrati sul documentare il più fedelmente possibile le premesse storiche, economiche e ideologiche della guerra in corso. Tale lavoro preparatorio ci è sembrato essere assolutamente indispensabile prima al fine di permetterci qualsiasi punto di vista sulla guerra in Ucraina, se non quello del sostegno incondizionato all'autonomia e all'emancipazione di qualsiasi popolazione, soprattutto quando questa viene invasa da un potere statale armato. Il diritto alla resistenza non è negoziabile. Specialmente quando la vita di milioni di Ucraini [*4] è stata devastata giorno dopo giorno, notte dopo notte. In un'epoca di disumanizzazione algoritmica e generalizzata, non ripeteremo mai abbastanza che qualsiasi tentativo di analisi teorica che astrae rispetto al punto di vista umano (e di quello degli esseri viventi nel loro insieme) si squalificherebbe da sé solo.
I. LE TRE GRANDI DIMENSIONI STORICHE DEL NOSTRO TEMPO
Quella che è in corso, è una ricomposizione globale dei rapporti di forza tra gli imperialismi, vale a dire tra l'Occidente da una parte e la Cina dall'altra [*5], la Russia e i loro alleati. È questo ciò che struttura profondamente la nostra epoca - allo stesso modo in cui avvenne nel primo Novecento - per non parlare del ruolo assunto dalle alleanze nello scoppio delle ostilità generali. Queste competizioni inter-imperialiste sono diventate strutturalmente decisive al punto da aver aperto un nuovo periodo "prebellico". La coesione sociale, la natura dei poteri e le modalità di governo sono profondamente cambiate da quando l'ex capitalismo sovietico-stalinista – incancrenito fino al midollo dalle mafie statali, private o del KGB [*6] – è collassato su sé stesso, e la controrivoluzione neoliberista, sotto l'egida degli anglosassoni [*7], è diventata dominante a livello internazionale. È proprio a partire da questa ideologia, sostenuta trent'anni fa da Hayek, Reagan e Thatcher – «la società non esiste, esistono solo gli individui» – che bisogna comprendere il crollo, se non addirittura la distruzione, di tutti i forti contropoteri nelle vecchie società, siano esse occidentali [*8] o meno. Infine, ci troviamo di fronte alla probabilità di molteplici stati di eccezione (climatici, ecologici, sanitari, economici, di sicurezza, bellici, ecc.) combinati con un "Totalitarismo Democratico" [*9]. Sì, il mondo è sul punto di cambiare, profondamente. E si trova anche nel bel mezzo di uno sconvolgimento che, al di là di ogni semplicistica analogia, ricorda le precedenti guerre mondiali. Detto ciò, però la degenerazione in un conflitto generalizzato si verificherà solo quando i protagonisti si sentiranno abbastanza forti da iniziarlo, o saranno portati a questa decisione, pena la perdita del loro potere o a causa degli effetti che esigono le loro alleanze. Ma qui c'è un pericolo senza precedenti: infatti, la novità rispetto alla "Guerra dei Trent'anni" [*10] sta nel fatto che stavolta ci sarebbe in gioco la sopravvivenza dell'umanità e degli esseri viventi; e più a lungo dura la guerra – le attuali guerre in corso – più c'è il rischio di uno "slittamento", uno qualsiasi. Alcuni sostengono che resistere a questa asservimento sarebbe un'azione bellicista. Significherebbe giocare a fare il "guerrafondaio"! Decisamente, le autorità russe non sono certo le sole a praticare l'" INVERSIONE ACCUSATORIA " [*11].
La perenne ipocrisia del capitale occidentale di fronte a Putin
Che si trattasse di un intervento armato in Cecenia, in Georgia, in Ucraina, in Siria, nel Nagorno-Karabakh, in Kazakistan o in Africa, in ogni occasione, dal 1999 e anche prima, gli interessi del capitale europeo sono sempre stati quelli di limitarsi a mettersi in posa [*12] a fianco di Putin. Mentre lui, da buon capo clan, prendeva la cosa come se si trattasse di un'ammissione di debolezza, e di codardia. In realtà, tutto avveniva su un altro piano, molto più serio: i capitalisti europei facevano di tutto per preservare quelli che erano i loro interessi nella Federazione Russa [*13]. Di conseguenza, è avvenuto che tutti quanti si sono sempre sottratti agli obblighi di intervento che la firma dei trattati internazionali avrebbe imposto loro, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento internazionale dei confini, e le «garanzie di sicurezza» date all'Ucraina nell'arco di mezzo secolo. A parte l'Atto finale di Helsinki, firmato nel 1975, Mosca si era impegnata a rispettare la sovranità dell'Ucraina: nel Trattato del 19 novembre 1990 [*14], nei due accordi di Minsk e Alma-Ata del dicembre 1991, che avevano istituito la CSI [*15], nei Memorandum di Budapest [*16] del dicembre 1994, nel Trattato di amicizia russo-ucraino di fine maggio 1997 e nel Trattato bilaterale di fine gennaio 2003; mentre il 4 dicembre del 2009 gli Stati Uniti e la Russia avevano confermato le garanzie di sicurezza stabilite nei Memorandum di Budapest [*17]. In totale, abbiamo dieci documenti ufficiali con cui il Cremlino riconosceva l'inviolabilità dei confini dell'Ucraina. Attraverso il cosiddetto «pericolo di cobelligeranza», i troll di V. Putin, a fronte dei massacri commessi in Ucraina, hanno offerto all'Occidente una valida giustificazione per l' immobilismo e l' elusione. Ma i commentatori nostrani hanno la memoria corta: durante la decennale guerra del Vietnam, l'URSS e la Cina sono state dichiarate "cobelligeranti" [*18]? E proprio a tal proposito, non dobbiamo dimenticare che il "protettorato bielorusso" è stato liberamente sfruttato dalle colonne militari di V. Putin per attaccare Kiev da nord nel febbraio 2022. Un solo governo occidentale ha osato denunciare questa reale co-belligeranza [*19] mostrandosi meravigliato del fatto che le installazioni nucleari bielorusse non siano state completamente smantellate, come previsto dopo la firma del Memorandum di Budapest del 1994; cosa che nell'ottobre del 2023 ha consentito che nel paese venissero dispiegate nuovamente le armi nucleari [*20].
«L'amarezza degli ucraini è stata grande quando si sono resi conto che se - su pressione dell'Occidente [nel 1994] - non avessero rinunciato all'arsenale nucleare ereditato dall'URSS, tutte le minacce russe avrebbero perso senso. È pertanto alquanto paradossale chiedere a coloro che sono più esposti al rischio di attacco nucleare di smettere di resistere per placare le paure di coloro che sono infinitamente meno esposti.» [*21]. Infine, a partire dal 2014, i governi occidentali hanno sempre ribadito che essi «rispettano l'autonomia decisionale dell'Ucraina», in modo che così possono sottrarsi alle proprie responsabilità; in effetti, le convenzioni da loro siglate (sul diritto di guerra e sul diritto umanitario internazionale, contro i crimini di guerra o il genocidio, i crimini contro l'umanità, ecc.) li obbligavano a intervenire in caso di violazione di questi accordi internazionali. Non si sa se abbiano abbozzato solo l'ombra di una protesta, o di un gesto, in questa direzione; al contrario, l'intensificazione degli scambi con le imprese russe (in campo nucleare, militare e strategico), e più in particolare la costruzione dei gasdotti Nord-Stream, si inserivano in una presunta marginalizzazione economica e politica dell'Ucraina, marginalizzazione di fatto complice del regime di V. Putin [*22]. Dopo decenni di cecità, dopo più di due anni di una guerra che ha gravemente devasto quel Paese europeo, permane l'ipocrisia di fondo del Capitale occidentale: di fatto, i suoi leader non negano ( quantomeno apertamente) che l'Ucraina debba riguadagnare la propria integrità territoriale; ma come potrebbe farlo senza porre fine agli assalti degli eserciti russi [*23] o senza sfidare i loro sistemi logistici? L'apice dell'ipocrisia è stato raggiunto nel marzo 2024. Quando i funzionari statunitensi hanno invitato gli ucraini a cessare i loro attacchi alle infrastrutture di raffinazione del petrolio nemiche, che secondo loro rappresenterebbero degli obiettivi civili e pertanto causerebbero un aumento dei prezzi sul mercato mondiale. Tuttavia, va notato che tutte queste raffinerie producono prodotti destinati all'esercito russo: carburanti per aerei supersonici e missili da crociera, nonché lubrificanti e additivi speciali per varie attrezzature militari. Quello che gli ucraini stanno cercando di fare è privare l'esercito nemico di energia, come avviene in tutte le guerre. Ma bisogna dire che in realtà, Chevron ed Exxon Mobil, i quali operano in Kazakistan, dipendono da quelle rotte di trasporto commerciale che la Russia potrebbe bloccare. Pertanto, queste aziende hanno utilizzato le loro potenti reti di influenza a Washington in modo da garantire così che l'Ucraina ponga fine ai suoi attacchi [*24]. Purtroppo tutto questo ci spinge a dire che, dal 2014, l'Occidente sostiene il popolo ucraino [*25] allo stesso modo in cui una corda sostiene un impiccato, e che non esiterebbe a sacrificare l'intero territorio ucraino a partire da un armistizio in stile coreano, dettato dagli Stati Uniti.
«Un'altra amara constatazione: se l'Occidente avesse fornito all'Ucraina solo un decimo dell'equipaggiamento militare che le sta dando oggi, e se non si fosse riparato per anni dietro il principio di "non escalation" [...], probabilmente Vladimir Putin avrebbe esitato parecchio, prima di inviare le sue truppe ad attaccare il Paese» [*26].
Quando ha avuto inizio questa guerra, i capitalisti occidentali hanno usato, come pretesto per limitare i loro aiuti, anche il cosiddetto pericolo di provocare un'escalation; quella stessa che Putin sventolava davanti a loro ogni notte, per farli addormentare. «Attraverso aiuti materiali intermittenti, graduali e misurati, e attraverso il divieto che le armi fornite venissero usate sul suolo dell'aggressore, per timore di un'escalation, dal 2022 il sostegno occidentale all'Ucraina è stato forse il più pusillanime in tutta la Storia del sostegno ai Paesi in fase di Resistenza. Per trovare qualcosa di peggio, bisogna senza dubbio tornare all'atteggiamento tenuto dai Paesi europei nei confronti della guerra civile in Spagna dal 1936 al 1939» [*27]. Oggi, questo pretesto non viene nemmeno più addotto, e questo proprio mentre stiamo assistendo a una radicalizzazione genocida del discorso quotidiano in tutte le istituzioni della Russia di oggi, e a un rafforzamento delle truppe di V. Putin. Attualmente, a causa della cecità dei governanti occidentali, e di altri "leader politici", ogni mese gli ucraini e le altre popolazioni povere che non fanno parte della Federazione Russa stanno morendo a migliaia. Presto o tardi, in un modo o nell'altro, le conseguenze di una sconfitta del popolo ucraino potrebbero essere immense, non solo in Europa, ma anche nel mondo: autocrati, golpisti e altri dittatori si sentirebbero come se stessero crescendo le ali, mentre i confini internazionalmente riconosciuti non avrebbero più molto valore per loro. Per non parlare del probabile consolidamento dell'estrema destra, che unito a un caos intellettuale e politico senza precedenti nelle società civili (per molte ragioni, ben al di là del solo Occidente e molto più profondo che negli anni '30) [*28]. Per di più, bisogna anche aggiungere che ben pochi sarebbero preparati a questo.
II. IL FALLIMENTO DELL'ANALISI "GEOSTRATEGICA" DEGLI STATI UNITI
Per quanto questa "analisi" sia ben nota da tempo, è comunque importante tornarci sopra, e riassumerla come segue: i governi statunitensi vedono nella Cina il loro più serio concorrente. Ragion per cui, pertanto, per loro, nell'Indo-Pacifico - un'area classificata come la più importante al mondo in termini strategici ed economici - verrebbe a essere tutto in gioco. Di conseguenza, l'Europa sarebbe diventata "un campo di confronto secondario" [*29]. Pertanto, come è stato ripetuto molte volte, l'asse della politica statunitense è l'Ucraina: dal momento che si tratta soprattutto di indebolire la Russia, e impedire in tal modo che si formi di una sua coalizione con la Cina. Qui serve notare come in tutto ciò il popolo ucraino abbia solo un ruolo marginale.
Si tratta di un triplice errore di calcolo o di un abbandono pianificato degli ucraini?
Mentre, da un lato, si sta cristallizzando una coalizione tra Russia, Corea del Nord, Iran e Cina [*30]: per esempio, dal 22 al 26 aprile 2024 si sono svolti almeno dieci incontri bilaterali ad alto livello tra i leader di questi quattro Paesi; il 17 maggio 2024 i capi di Stato russo e cinese si sono incontrati per la quarantatreesima volta dal 2012; il giorno dopo, per la prima volta dal luglio 2000, V. Putin si è recato a Pyongyang per firmare un accordo identico a quello del 1961 [*31] e per ringraziare Kim Jong-Un per le sue migliaia di container di missili, armi e munizioni che stanno devastando l'Ucraina; il giorno dopo era in Vietnam. Del resto, va detto che anche il lento rullo compressore sovietico-stalinista ha certamente avuto bisogno di tempo per mettersi in moto, ma ora si sta muovendo lentamente e inesorabilmente, come in passato. Sul fronte, in primo luogo, come truppe "immediatamente consumabili" lanciate sulle posizioni ucraine per indebolirle, ha utilizzato le popolazioni impoverite e non russe, gli stranieri indigenti, gli immigrati dall'Asia centrale e i detenuti. Nel frattempo, V. Putin ha ordinato il bombardamento di installazioni civili per terrorizzare la popolazione e distruggere le infrastrutture energetiche del paese; tutte cose vietate dalle convenzioni internazionali. Per di più, il Cremlino incoraggia i suoi "onorevoli corrispondenti" in Occidente [*32], i suoi hacker e le sue "fabbriche di troll" a spaccare l'opinione pubblica e i governi: all'inizio del 2024 sono balzate agli onori della cronaca le operazioni Portal Kombat, Doppelganger e Matriochkas [*33]. Inoltre, grazie alle sue "riserve umane", alle sue scorte di vecchie attrezzature in fase di ristrutturazione, alla disponibilità dei produttori cinesi a fornirgli i componenti o le materie prime necessarie, e alla mancanza di efficacia delle sanzioni, per non parlare delle complici aziende occidentali [*34]; grazie a tutto questo, non solo V. Putin sarà probabilmente ancora in grado di "mantenere" il genere di guerra di logoramento che sta conducendo da diversi anni, ma non ci sarà nemmeno nessun indebolimento militare russo: è venuto meno, pertanto, il secondo argomento geostrategico dei governi statunitensi. Alla fine, anche questa "geo-strategia" americana, che mirava a evitare un riavvicinamento russo-cinese si dimostra così un fallimento. Durante una videoconferenza con il suo omologo russo, il 31 gennaio 2024, il nuovo ministro della Difesa cinese si è impegnato a sostenere la Russia perché questa sarebbe stata «una risposta necessaria all'aggressione degli Stati Uniti e della NATO contro Russia e Cina». Un simile significativo cambiamento nella posizione della Cina, si è ripetuto anche alla fine di aprile 2024 durante una visita di Antony Blinken a Pechino. Xi Jinping, infatti, muove cautamente le sue pedine: si aspetta che questa guerra sconfigga l'Ucraina,e lo faccia a poco costo, ma soprattutto che essa isoli e indebolisca gli Stati Uniti. In altre parole, mentre Washington "sostiene" tristemente un popolo ucraino che lotta per la propria sopravvivenza, il leader cinese si aspetta che gli Stati Uniti ne escano sminuiti, di fatto sconfitti da V. Putin, oppure che, in Ucraina, come è successo loro altrove, "si arrendano". Dopotutto, questo sarebbe solo il loro quarto grande pensionamento in pochi anni.
Se vuoi evitare la guerra, la cosa è semplice: «Sottomettiti!». Questa piccola melodia può essere sentita dietro gli appelli alla «de-escalation» [*35]. Peggio ancora, negli Stati Uniti c'è chi sta negoziando alle spalle degli Ucraini dall'aprile 2023, perché ritiene che gli Ucraini non possano più permettersi di recuperare tutto il loro territorio e che non sarebbe redditizio continuare a sostenerli, tanto più che non avrebbero alcun specifico interesse a farlo [*36]. Per loro bisognerebbe quindi elaborare le condizioni per una «fine onorevole». In altre parole, questi alti funzionari stanno cercando, sulle spalle degli Ucraini, le condizioni in base alle quali Putin accetterebbe di porre fine alle ostilità, almeno temporaneamente [*37].
III. GLI SCENARI DI TRUMP E PUTIN
Per sette preziosi mesi, i sostenitori di Trump hanno bloccato tutti gli aiuti militari all'Ucraina, cosa che ha permesso così all'esercito russo di riorganizzarsi e andare avanti. Ma l' eventuale elezione di Trump a novembre risuonerebbe in tutto il mondo come un enorme boato, prima ancora che egli possa prendere una qualunque decisione. Netanyahu [*38] e Putin faranno di tutto per promuovere una tale elezione, la quale consentirebbe loro poter continuare quelle guerre in corso, dalle quali dipende la loro sopravvivenza politica, e anche la sopravvivenza fisica dell'ultimo dei due. Va inoltre notato che la combinazione di questi due fronti (in cui l'Iran sarebbe coinvolto) costituirebbe il germe di una guerra di notevoli dimensioni internazionali. Infine, va detto che se l'esito delle elezioni di novembre non dovesse essere favorevole a Trump, questo sarebbe sicuramente contestato da un'ampia fetta dell'elettorato [*39]. Persino se Trump, una volta eletto, non dovesse decidere per un ritiro formale dal Trattato del Nord Atlantico, gli basterebbe un Tweet violento postato sui cosiddetti " social network " [*40] per rallegrare il Cremlino e sprofondare il popolo ucraino in una drammatica situazione economica, mentre le popolazioni europee andrebbero sotto shock e abbandonate a se stesse. La confusione politica che sta già regnando in ciò che rimane in Occidente dei contropoteri raggiungerebbe vette che non si vedevano dagli anni Trenta, per non parlare di ulteriori fattori aggravanti come l'assenza di classi lavoratrici organizzate in quanto forza sociale o come la pandemia di "peste nera del genere urbano" (con la quale intendiamo gli effetti psico-fisiologici dovuti alle cosiddette "reti sociali") che, come dice Michel Desmurget [*41], sta istupidendo le masse, soprattutto i giovani, un tempo motore di tutte le lotte contro le ingiustizie sociali e politiche [*42].A questo punto, a seconda delle circostanze, V. Putin potrebbe essere tentato da diversi scenari, tra cui quello di: asserire di "venire in aiuto dei russofoni", in Transnistria o in Gagauzia, per poter poi invadere la Moldavia, utilizzando sempre lo stesso pretesto, quello in auge fin dall'annessione dei Sudeti da parte di Hitler nel 1938 [*43]. Potrebbe anche preparare una grande offensiva - la cui data può dipendere dalle elezioni presidenziali statunitensi - per poi sfondare la linea del fronte e invadere l'Ucraina, o ridurre il Paese a brandelli sotto il proprio "ombrello nucleare". Gli europei, da soli, non potrebbero o non vorrebbero opporsi. L'invasione completa del territorio ucraino gli consentirebbe di assicurarsi la continuità territoriale con i suoi alleati slovacchi, ungheresi e serbi, vale a dire, a lungo termine, di ricostruire una sorta di glacis coloniale - degno della "immemorabile potenza russa" che asserisce di avere - e di ridisegnare così la mappa politica dell'Europa [*44]; senza contare gli effetti destabilizzanti dovuti all'esodo di milioni di ucraini verso l'UE [*45]. L'invasione e l'annessione di uno Stato sovrano ritornerebbe a essere la prassi dell'Europa prima del 1945. Per il Cremlino, costituirebbe inoltre un importante passo avanti nella realizzazione di un progetto neo-imperiale al pari degli altri due suoi concorrenti (Cina e Stati Uniti). Un terzo piano, più autonomo rispetto agli altri, consisterebbe nel "colpire in modo mirato e inavvertito" il territorio di un Paese membro della NATO per pregiudicare l'articolo 5 e la coesione dell'organizzazione a partire dal presupposto che il "sovrano immobiliare" di New York sarà riluttante a venire in aiuto di un "ex alleato europeo" [*46]. Rimane ancora una quarta possibilità, più incerta: V. Putin potrebbe tentare di occupare, insieme al suo vassallo bielorusso, il corridoio di Suwalki [*47] che "serve" Kaliningrad - un' enclave geo-politicamente cruciale dove è custodito parte dell'arsenale russo di "missili nucleari tattici". Tuttavia, la messa in sicurezza del corridoio di Suwalki isolerebbe territorialmente i Paesi baltici dal resto dell'UE e potrebbe avvenire solo se fosse certo che D. Trump ha definitivamente rinunciato all'intervento militare.

IV. LE DIMENSIONI NUCLEARI DELLA GUERRA
Oleg Dudar, in qualità di ingegnere capo della centrale di Zaporizhia, ci ha lavorato per molti anni, fino al settembre 2022, come capo della divisione operativa con oltre seicentocinquanta colleghi dei suoi dipartimenti. Nel marzo del 2023 egli rilasciò una lunga intervista sulle difficoltà che dovettero affrontare. In essa si apprende che in più occasioni la centrale, l'Ucraina e l'Europa - prima in occasione dei bombardamenti dell'esercito russo e poi sotto la sua occupazione - sono state vicine a un incidente radio-nucleare straordinario [*48]. Questo è uno dei motivi per cui diciamo che, da più punti di vista, l'invasione dell'Ucraina ha portato a ciò che né la guerra nell'ex Jugoslavia, né la guerra al terrorismo e tanto meno la guerra in Iraq avevano causato: anzi, nessuno può dire con certezza che questa guerra rimarrà militarmente convenzionale, né territorialmente circoscritta. soprattutto perché resiste. Questa situazione introduce alti rischi di disastro planetario che sono sempre stati negati dai produttori e dai promotori dell'energia nucleare, ma eccoci qui. Abbiamo analizzato diversi aspetti nucleari di questa guerra [*49], tra cui lo status delle cosiddette armi tattiche, come esso si è evoluto nell'ambito delle strategie militari statunitensi e russe, e i cambiamenti nella loro dottrina d'uso negli ultimi anni, e le ripercussioni che ciò potrebbe avere. Il risultato è che il postulato indistruttibile della "deterrenza nucleare", a cui molti si aggrappano ancora, è di fatto obsoleto dal luglio 2021 [*50]. Al di là di tutto questo, rimane una questione importante: in caso di una sconfitta vicina e inevitabile (ad esempio la riconquista di tutto il suo territorio da parte dell'Ucraina, compresa la Crimea), V. Putin userebbe una "arma nucleare tattica" [*51], nonostante gli avvertimenti di Jake Sullivan, il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, che ha dichiarato pubblicamente il 25 settembre 2022: «Abbiamo chiarito al Cremlino, direttamente, privatamente e ad altissimi livelli, che qualsiasi uso di armi nucleari avrebbe conseguenze catastrofiche per la Russia, e che gli Stati Uniti e i loro alleati risponderebbero con decisione. Siamo stati chiari e precisi su ciò che questo comporterebbe».
V. GLI ERRORI EUROPEI, IL PROSELITISMO SOVIETICO, IL DECLINO DELL'IMPERIALISMO
Il 7 febbraio 2022 si è verificato un evento patetico: E. Macron aveva cercato invano, per cinque ore, con la razionalità delle sue argomentazioni, di convincere il capo clan, quando Sarkozy, il suo mentore, ne aveva già avuto la dolorosa esperienza nel giugno del 2007. Il 20 febbraio 2022, quattro giorni prima dell'invasione, E. Macron era ancora "a tu per tu" con il suo caro Vladimir, che egli chiamava al telefono per chiedergli di sfuggita come stavano andando le manovre militari in corso sul confine ucraino, e che avrebbero dovuto concludersi la sera stessa; aveva persino detto al suo interlocutore che stava facendo pressione «su Zelensky, per calmarlo» [*52], mentre, dopo 8 minuti V. Putin gli aveva già fatto capire che aveva altre cose da fare che stare a parlare dell'Ucraina con lui. Tutto questo è evidenziato da un'interessante registrazione effettuata in loco [*53]. Il capitale francese ha collaborato intimamente con il capitalismo di Stato russo, sia negli idrocarburi, nell'industria farmaceutica, nei beni di lusso, nelle assicurazioni, nell'alimentare, nelle banche [*54] e soprattutto, per mezzo secolo, nel campo nucleare; che non è certo cosa da poco. È stato anche un fattore determinante per l'acquisizione di energia da parte della multinazionale statale Rosatom; cosa che le ha permesso di diventare la più grande società di costruzione di centrali nucleari del mondo [*55]. E anche in questo caso, quando studiamo il ruolo geostrategico di questo conglomerato statale guidato dagli amici del leader del clan, stiamo usando solo un eufemismo. Da parte sua, negli ultimi tre decenni, invece il capitale d'oltre Reno ha in parte costruito il suo dominio europeo sull'esilio delle popolazioni dell'ex ghiacciaio sovietico - la cui demografia è crollata dopo il 1991 [*56] - grazie all'importazione di risorse energetiche russe e ai suoi sbocchi in Cina. Questo paese rimane il suo primo "partner commerciale": Volkswagen genera lì il 37% del suo fatturato e le aziende più grandi realizzano lì più del 20% dei loro profitti. Da qui le frettolose visite di Olaf Scholz a Pechino, già nel novembre 2022 e poi nell'aprile 2024, quando i servizi di intelligence occidentali avevano già informazioni secondo cui «Russia e Cina stanno collaborando allo sviluppo di attrezzature da combattimento per l'Ucraina» [*57].
Permanenza o mutazione del discorso antimperialista stalinista?
Trasmesso per decenni, su ordine di tutti i partiti stalinisti, questo proselitismo è stato attualizzato, prima, a metà degli anni 2010 dai collaudati apparati di propaganda del Cremlino, e poi dalle molte società di "soft power" che gravitano intorno al potere, come quelle che componevano il gruppo del defunto Yevgeny Prigozhin [*58], per non parlare dell'utilizzo, da parte delle fabbriche di troll, dei cosiddetti "social network". Di passaggio, va notato come, in questa visione del mondo, gli Stati Uniti siano stati recentemente ribattezzati «il grande Satana», appellativo di origine controllata dagli ayatollah iraniani [*59], che avranno preceduto di mezzo secolo quello del patriarca Kirill di Mosca [*60]. La morte in volo dello "chef" di V. Putin e della sua ristretta équipe, avvenuta alla fine di agosto 2023 a nord di Mosca. non significa che i loro metodi siano stati abbandonati ( soprattutto da parte dei putschisti neocoloniali che il defunto Wagner aveva addestrato in Africa): i video delle torture dei sospetti dopo l'attentato al municipio di Crocus, alla fine di marzo 2024, riecheggiano l'esecuzione a martellate di un disertore filmata da uno dei miliziani di Wagner nel novembre 2022. Non si tratta di fughe di notizie, bensì di una strategia di comunicazione ben studiata. L'obiettivo è quello di traumatizzare tramite le immagini, per creare uno shock psichico che sia immediatamente propagato attraverso l'assuefazione a internet e ai cosiddetti "social network" allo scopo di ostacolare l'emergere di qualsiasi spirito critico o di resistenza. È una strategia analoga a quella avviata da Daesh, che filma i propri atti di violenza per rafforzare il proprio potere di distruzione, ovvero in una versione digitale e "aggiornata" del terrore. In altre parole, e in termini più teorici, si tratta di una "erotizzazione della morte" che i regimi totalitari del XX secolo avevano già messo in pratica, sia in Spagna nel grido di Franco "Viva la Muerte", sia in Germania con gli autodafé del maggio 1933, che precedono quelli del 1939 e del 1942.
Approfondire l'analisi dell'imperialismo statunitense
Sul piano teorico, ciò richiederebbe un analisi della misura in cui la schiavitù degli africani, lo sradicamento degli amerindi, la creazione e l'uso dell'energia nucleare - in altre parole, i tre crimini contro l'umanità - costituiscano una parte importante della storia di questo giovane paese; considerare fino a che punto la mentalità sia rimasta profondamente religiosa e persino bigotta; comprendere quali siano state le conseguenze della colonizzazione da parte dei coloni tedeschi sino all'inizio del XX secolo [*61]; studiare in dettaglio la relazione incestuosa [*62] precedente, durante e successiva all'ascesa del nazismo al potere; catalogare la cinquantina di interventi armati condotti dal 1945 in poi; rivedere il bilancio delle guerre in Vietnam, in Afghanistan, in Iraq e in Siria e il sostegno dato ai vari governi israeliani. Non ci lasciamo quindi ingannare dal doppio ruolo svolto dagli Stati Uniti in Ucraina; lo abbiamo persino documentato in anticipo [*63]. Ciò non toglie che - come i repubblicani spagnoli o come la Resistenza francese - gli Ucraini abbiano legittimamente accettato tutte le armi, da qualsiasi parte provenissero, per difendere la propria vita, quella dei propri cari e dei loro concittadini. Senza dimenticare che, quando Kiev è stata presa d'assalto [*64] nel marzo 2022, sono stati abbandonati a sé stessi, con Biden che offriva a Zelensky un taxi per Berlino.
VI. UN POPOLO SOLO DI FRONTE ALLA GUERRA TOTALE [*65]
Si tratta di una guerra che, per certi aspetti, assomiglia a quella del 1914-18, nel suo essere una guerra inter-statale che raduna enormi contingenti di reclute, le quali vengono usate come carne da cannone da uno stato maggiore russo che per avanzare in media di cento metri, è già pronto a perdere fino a duemila uomini [*66]; anche stavolta si tratta di una guerra di logoramento: è stato distrutto tutto su un fronte che è lungo la metà di quello del 1914-18 in Francia [*67]. Si tratta anche di una guerra industriale e totale, vale a dire che prende deliberatamente di mira la popolazione civile ucraina, facendolo però con mezzi più potenti e con gittate più ampie rispetto ad allora. Le principali differenze, risiedono nell'uso attuale che viene fatto dell'aviazione, dei droni, di Internet, del tracciamento satellitare e, soprattutto, per mezzo della sua dimensione nucleare [*68]. Resta il fatto che ogni confronto armato di tale portata cambia la posta in gioco del momento, e persino le basi della nostra riflessione (senza obbligarci ad abbandonarle). Ogni cosa viene stravolta poiché in ogni momento ci confrontiamo con la distruzione, con la questione della nostra protezione, quando non si tratta della nostra sopravvivenza o di quella dei nostri cari. La guerra semina distruzione materiale, psicologica e morale, e devastazione generale. «Il paragone non ha ragion d'essere», ma, in definitiva e fino a prova contraria, in questo caso il miglior quadro di riflessione è quello di chiedersi: cosa avrei fatto nel maggio del 1940 quando i nazisti invasero il Paese, nel momento in cui i lupi sono entrati a Parigi? Era legittimo allora unirsi alla Resistenza, ciascuno di noi a modo suo, a volte persino desiderando di non imbracciare le armi, cosa non meno pericolosa? Purtroppo, in molti ambiti continua a persistere un antimperialismo superficiale e datato, che si rivolge esclusivamente contro gli Stati Uniti e che ignora totalmente la plurisecolare storia imperiale russa. Ciò è il frutto di oltre mezzo secolo di dominio ideologico da parte dell'URSS, della sua sistematica falsificazione della storia [*69], nonché dell'insediamento dei partiti stalinisti nei circoli operai e, come ormai risaputo, dei suoi uffici e dei suoi funzionari in ombra, alcuni dei quali sono stati a lungo perfino vicini a tutti i poteri forti e a molti commentatori. È soprattutto la conseguenza dell'immenso deserto critico ereditato dalla "guerra dei trent'anni" (1914-1945) [*70]. E, contrariamente a quanto si poteva pensare, la caduta dell'URSS non ha messo fine a questo fenomeno, soprattutto nei Paesi colonizzati dall'Occidente, che la milizia armata Wagner ha sfruttato con grande efficacia in Africa.
Un mondo stupito dalla resistenza del popolo ucraino
Il 24 febbraio 2022, la prima fase dell'aggressione russa mirava a rovesciare in pochi il governo, e a ricolonizzare l'Ucraina attraverso una «semplice operazione di polizia» che si sarebbe basata su una popolazione conquistata da un tale colpo di stato. La resistenza organizzata del popolo ucraino ha stupito tutti i funzionari occidentali – e tutti i servizi segreti, compresi la CIA e l'FSB – che erano convinti che ci sarebbe stato un rapido collasso di quella società. Al contrario, una moltitudine di iniziative popolari di autodifesa hanno testimoniato la coscienza acquisita a partire dalla "Rivoluzione Arancione" del 2004. Ciononostante, l'intero sud del Paese è stato facilmente invaso a partire dalla Crimea che era stata annessa nel 2014, con l'eccezione della città di Marioupol, assediata per tre mesi e poi rasa al suolo, così come Grozny [*71] e Aleppo in una operazione di urbanicidio deliberatamente pianificato [*72]. In estate, le forze armate di Kiev hanno riconquistato il nord-est del Paese e la riva destra del Dnieper, ma a settembre la mobilitazione parziale di 300.000 riservisti decisa da Mosca, l'inizio di una campagna di bombardamenti contro le infrastrutture energetiche in ottobre e il reclutamento massiccio di prigionieri di diritto comune [*73] inviati al fronte - tramite l'ex gruppo Wagner - avrebbero cambiato la situazione: l'inizio di una guerra di logoramento tipicamente sovietico-staliniana avrebbe trincerato le truppe ucraine durante l'inverno del 2022, in particolare a Bakhmut, mentre a sud il territorio veniva massicciamente minato [*74] e fortificato con diverse linee di difesa in profondità, vanificando in tal modo la seconda controffensiva ucraina iniziata nel giugno 2023 [*75]. Successivamente l'inverno avrebbe relativamente stabilizzato il fronte, a vantaggio delle armate russe che stavano riguadagnando il terreno perduto. Da allora, infuria una guerra di logoramento. Si tratta di una guerra di logistica [*76] che riguarda l'equipaggiamento, le munizioni, la manodopera, i pezzi di ricambio, il denaro, di cui gli ucraini sono gravemente carenti. Nel frattempo, la Russia di Vladimir Putin, che era già il secondo paese esportatore di armi al mondo, ha seriamente riorientato il suo apparato industriale grazie a un potere iper-centralizzato e all'elusione delle sanzioni occidentali: basta guardare all'improvviso aumento delle esportazioni europee, in particolare a quelle provenienti dalla Germania e dalla Svizzera, verso il Kazakistan, l'Uzbekistan o i paesi del Caucaso per capire le elusioni utilizzate [*77]. In altre parole, la Russia di oggi è in procinto di passare a un'economia di guerra, e questo mentre ogni mese cadono diverse decine di migliaia di vittime civili e militari.
Un popolo che ancora una volta sta lottando per la sua sopravvivenza [*78]
Quotidianamente, gli ucraini affrontano distruzioni talmente grandi che richiederanno decenni di ricostruzione e di riabilitazione ecologica (stimate in oltre 600 miliardi di dollari nel febbraio 2024), per non parlare dei traumi e delle ferite umane che persisteranno. In due anni di guerra ci sono stati circa 80.000 soldati uccisi e 200.000 feriti da parte ucraina, e probabilmente più di 50.000 civili uccisi e altrettanti feriti, compresi quelli durante la distruzione del 95% della città di Mariupol, la quale contava quasi mezzo milione di abitanti. Dal 24 febbraio 2022, quasi 10 milioni di persone sono state costrette a lasciare le loro case, mentre 6,4 milioni delle quali si sono rifugiate all'estero [*79]; vale a dire un totale di sfollati superiore a quello conseguente all'esodo del maggio-giugno 1940 in Francia. L'Ucraina, che contava 50 milioni di abitanti alla fine del XX secolo, ora, alla fine del 2023, ne aveva solo poco più di trenta milioni. Inoltre, l'Ucraina, come ogni paese invaso militarmente, deve affrontare molti problemi, siano essi economici, sociali, politici, energetici, industriali o militari; in questo caso talmente numerosi e critici, che non si può escludere un collasso del Paese. Ciò avrebbe conseguenze gravissime per la sopravvivenza dei suoi abitanti, come testimoniano i quotidiani appelli al genocidio da parte di Margarita Simonian o di Vladimir Soloviev sul canale televisivo statale "Rossiya 1" [*80], con la benedizione del capo clan, dei suoi ideologi, della sua cerchia mafiosa e della sua chiesa. Come se non bastasse, tutti si presentano come se fossero i custodi ultimi della civiltà [*81] da cui l'Occidente si sarebbe invece allontanato; propaganda questa, che trova in Europa persone, ingenue o compiacenti, pronte a trasmetterla senza scrupoli [*82].
VII. CONCLUSIONE PROVVISORIA
Da quando questa guerra di aggressione è cominciata, abbiamo sentito di tutto. All'inizio ci è stato detto che per evitare un'escalation del conflitto, «non dovremmo provocare la Russia», o «che non dovremmo umiliare Putin» [*83]. Tutto il negazionismo, relativo ai massacri perpetrati sotto i suoi ordini fin dal 1999, non smette mai di stupirci [*84], soprattutto perché i suoi eserciti, dal momento in cui hanno attraversato il confine ucraino, hanno derubato, torturato e stuprato, sia a Irpin, Bucha, Kherson o altrove, esattamente come hanno fatto per decenni con l'incoraggiamento delle gerarchie addestrate durante i massacri coloniali in Afghanistan: uno strano modo di venire a "liberare le popolazioni ucraine" ritenute oppresse. Ci è stato anche detto in vari modi che "l'Ucraina non esiste", un discorso forgiato dai troll dell'FSB. Infine, c' è stato chi ha cercato di farci entrare «nella testa di Putin». Ahimè! Non avevano le competenze di uno psicanalista o di uno storico, tanto meno di un ricercatore. Ma hanno avuto il vantaggio di distrarre le masse dai crimini di guerra commessi in Ucraina. C'è stato anche un richiamo alla corruzione, opportunamente dimenticata, in quanto prima e più grande esportazione del colonialismo sovietico (e poi alle mafie russe dopo il crollo dell'URSS) per tre quarti di secolo, e che le autorità ucraine hanno contrastare per soddisfare le condizioni per l'ingresso nell'UE. È stata denunciata «l'avanzata della NATO» [*85], ma c'è stato un silenzio complice sulle prime otto guerre di V. Putin. E che dire del fatto che abbia spinto ad aderire Paesi notoriamente neutrali - Finlandia e Svezia - senza scatenare alcuna protesta da parte sua, anche se questo è stato uno dei suoi primi pretesti per la guerra, pretesto che è stato gradualmente abbandonato a favore di un'escatologia millenaristica e della denuncia del decadente "Occidente collettivo". Abbiamo assistito all' accanimento contro l'aggressore e l'aggredito, come alcuni sono soliti fare quando prendono in esame uno stupro, aggiungendo «se lo sono meritato». C'è stato anche un belante pacifismo alla Daladier [*86], nei confronti di un invasore armato, che nessun ucraino avrebbe ascoltato. È stato inoltre suggerito che sarebbero stati gli Stati Uniti a occuparsene, anche se l'Europa è da tempo di interesse secondario per loro. E poi, secondo alcuni leader politici, il Presidente e il popolo ucraino sarebbero solo dei burattini dell'Occidente: come spiegare che siano riusciti a respingere da soli gli invasori nei primi giorni, rifiutando la resa che era stata loro offerta? Una bella concezione della storia e di un popolo sulla bocca di populisti ispirati da Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. La cosa peggiore è stata quella di giustificare, a mezza voce, la conquista di uno "spazio vitale" necessario alla sicurezza di Mosca ignorando i confini riconosciuti a livello internazionale. Leggendo e ascoltando ciò che viene detto oggi alle due estremità dello spettro parlamentare, ovviamente non si può fare a meno di paragonare le ripetute ritirate di fronte a V. Putin a quelle che si sono verificate prima, durante e dopo gli accordi di Monaco [*87] nel 1938. Ma in questo momento i movimenti pacifisti stanno attivando la loro vecchia e generalista propaganda contro la guerra che mira a farci dimenticare chi ha scatenato l'attuale invasione dell'Ucraina: sempre la stessa inversione accusatoria propria del KGB, anche se realizzata con i moderni mezzi delle fabbriche di troll di San Pietroburgo. Inoltre, come già avvenuto con l'emergere del movimento dei Gilets Jaunes alla fine del 2018, i guardiani dell'analisi astratta, che non abbandonano mai i loro punti teorici di osservazione, ci ingiungono ancora una volta di "rimanere con le mani pulite" e di non immischiarci in ciò che non ci riguarda, ovvero la plebe che sta morendo sotto i nostri occhi. Tutto questo ci porta a parafrasare lo storico della guerra S. Audoin-Rouzeau: «I pacifisti di oggi saranno i collaborazionisti di domani? [*88] E non è il solo. Resta il fatto che a questo punto è difficile arrivare a una conclusione, se non quella secondo cui il mondo si trova in procinto di sgretolarsi, forse violentemente, mentre la maggior parte tiene la testa bassa e gli occhi incollati ai piccoli schermi. Tuttavia, ogni stato di guerra genera dei profondi shock traumatici, i quali, dopo il 1945, sono sempre stati rapidamente - troppo rapidamente - spazzati sotto il tappeto, e di cui, tre quarti di secolo dopo, non abbiamo ancora misurato la debacle del pensiero e delle relazioni tra gli uomini, o con i viventi, che ne è seguita. E questo sia che fosse nell'interesse di alcuni far dimenticare il patto Molotov-Ribbentrop, continuando a falsificare la storia [*89]; sia che gli altri avessero interesse a coprire i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità commessi a Tokyo, Dresda, Amburgo, Hiroshima e Nagasaki. D'altra parte, entrambi hanno continuato a esportare le loro ideologie, grazie alle loro sezioni di partito legali e illegali in molti paesi; o grazie ai piani Marshall e al loro hardware modernista. Ancora una volta, su entrambi i lati della "cortina di ferro", la storia è stata scritta dai vincitori, nel mentre che i dissidenti sono stati rapidamente condotti nei gulag, oppure sono rimasti sedotti dalle lusinghe del profitto. Sulla scala del tempo umano, o di quello delle civiltà, tre quarti di secolo non erano poi così tanti.
Ma ora sappiamo che non solo la civiltà del Capitale sarà la più breve che l'umanità abbia mai conosciuto, ma siamo anche a conoscenza del fatto che i suoi mezzi possono rapidamente mettere a repentaglio sulla Terra, quella vita che le masse tendono a reprimere ogni secondo della loro esistenza. È questo il motivo per cui è diventato sempre più difficile immaginare la fine del capitalismo, piuttosto che la fine del mondo, di cui la maggior parte non comprende le cause; ed è ciò che ha permesso a Hollywood di farne un grande affare per decenni. Resta il fatto che il diritto che un popolo ha di resistere continua a essere un diritto inalienabile; ma a volte, per poter rimanere in vita, bisogna arrivare al punto di prendere in mano i mezzi di auto-organizzazione.
- Jean-Marc Royer - fine giugno 2024 - fonte: AutreFUTUR.net -
Note
[1] L'enorme lavoro dell'ONG russa Memorial era tutt'altro che completo quando essa è stata sciolta il 28 dicembre 2021, in previsione dell'invasione dell'Ucraina. Questo lavoro riguardava più specificamente il Gulag, ma non è stato ripreso dalla società nel suo insieme, così come è avvenuto nel caso del Sudafrica dopo la deposizione dell'apartheid. Resta quindi da fare l'analisi storico-politica complessiva di quella che è stata l'URSS prima, e la Russia di Eltsin poi. Grazie ancora a Bernard F., Gary L., Antonin I. e Sandrine M. per la loro attenta correzione di bozze. Prima versione depositata presso la SGDL con il numero 3467.
[2] Un'allusione all'ultima corrente teorico-critica formatasi – la Scuola di Francoforte (Adorno, Marcuse, ecc.) – che aveva cercato di avvicinare marxismo e psicoanalisi.
[3] Vale a dire, l'equivalente di un libro di quattrocento pagine che inizia con una storia critica della NATO. Cfr. l'elenco nell'appendice 1.
[4] E alcune decine di migliaia di caucasici, siberiani e altre popolazioni si arruolarono negli eserciti russi.
[5] Come nel caso delle imprese russe, il capitale europeo ha forti legami di dipendenza dalla Cina: 400 miliardi di deficit commerciale annuo! Per non parlare delle dipendenze industriali strategiche di ogni tipo. Va notato per inciso che il Regno di Mezzo pesa il 18% del PIL mondiale ma cattura il 32% del suo valore aggiunto... Agatha Kratz, "Tempo di dibattito", 9° minuto, Francia cultura, 6/05/2024.
[6] Tra i molti libri sull'argomento: Virginie Coulloudon, La Mafia en Union Soviétique, Paris, JC Lattès, 1991. Evguenia Albats, La bomba a orologeria. Enquête sur la survie du KGB, Plon, 1992. Igor Kliamkine e Lev Timofeev, La Russie de l'ombre, Presses de la Cité, 2000. Catherine Belton, Gli uomini di Putin: come il KGB ha conquistato la Russia prima di attaccare l'Occidente, Talent éditions, 2022. Stéphane Courtois, Galia Ackerman, Il libro nero di Vladimir Putin, Robert Laffont, luglio 2022. Attenzione: ancora una volta, citare un autore, un libro o un sito non significa condividerne l'intero argomento.
[7] Su questo argomento, vedi War Diary #2 intitolato "L'Anschluss della DDR".
[8] Le classi lavoratrici occidentali sono state sconfitte, in tutti i sensi, dal neoliberismo, i partiti politici – tranne quelli di estrema destra – sono affondati anima e corpo, gli zombie digitali sono sempre più attrezzati e senza cervello, ecc.
[9] Totalitarismo democratico che si sta diffondendo nei paesi occidentalizzati, mentre altrove si moltiplicano dittature, colpi di Stato, collassi sociali in cui proliferano traffici e mafie di ogni tipo guidate da signori della guerra troppo armati[[ A questo proposito, siamo rimasti sbalorditi nell'apprendere, all'inizio del 2024, che erano dilaganti anche nei paesi del nord Europa, un tempo rinomati per il rigoroso autocontrollo sociale derivante dalla loro austera cultura protestante. Con gli omicidi che si moltiplicano nei cortili delle scuole dai tempi della Columbine – anche qui gli Stati Uniti erano avanti di un quarto di secolo – questo segna ovviamente una disgregazione galoppante di tutte le società e di tutte le relazioni umane, una disgregazione che è anche "globalizzata".
[10] Periodo che inizia nel 1914 e termina nel 1945. Concetto tratto dal lavoro degli storici Eric Hobsbawm ed Enzo Traverso.
[11] Jean-Sylvestre Mongrenier, "Gli Stati europei hanno i mezzi per resistere alla pressione russa", Russia Desk, 10 marzo 2024.
[12] O fare le valigie come Bolloré in Africa. Cfr. la serie dei "Diari di guerra" pubblicata su Internet.
[13] Per non parlare dei suoi rappresentanti totalmente corrotti, come Schroeder o Fillon, due personaggi che hanno cercato fino all'ultimo di risparmiare i loro compensi di presenza nei consigli di amministrazione delle grandi aziende russe. Dal 22 febbraio, un sito web ha tenuto un inventario delle aziende che continuano la loro attività in Russia: "Oltre 1.000 aziende hanno ridotto le operazioni in Russia, ma alcune rimangono", Yale School Management, amministratore delegato Leadershp Institute, 28 gennaio 2024.
[14] Articolo di rivista, "Documento 7: Trattato tra la RSFS russa e la RSS Ucraina, firmato a Kiev il 19 novembre 1990, da B. Eltsin e L. Kravchuk", Studia Diplomatica, vol. 46, n. 3/5, L'indipendenza dell'Ucraina (1993), pp. 345-348. https://www.jstor.org/stable/44836786
[15] Emma Donada, "La Russia si è impegnata a rispettare l'integrità territoriale dell'Ucraina attraverso il memorandum di Budapest?", Libération CheckNews, 11 marzo 2022 e https://www.cvce.eu/content/publication/2005/4/15/d1eb7a8c-4868-4da6-9098-3175c172b9bc/publishable_fr.pdf
[16] Memorandum sulle garanzie di sicurezza nel contesto dell'adesione dell'Ucraina al trattato di non proliferazione delle armi nucleari. Budapest, 5 dicembre 1994. Volume 3007, I-52241. https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%203007/Part/volume-3007-I-52241.pdf
[17] https://2009-2017.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/dec/133204.htm
[18] Entrambi i paesi hanno sostenuto il "Vietnam del Nord" militarmente, e su larga scala, con piloti russi che hanno persino pilotato i propri aerei per farlo. Un cobelligerante è un paese che "presta" il suo territorio all'attacco o invia i suoi soldati a fianco degli "amici".
[19] Il gruppo di monitoraggio Belaruski Hayun ha riferito che treni che trasportavano dozzine di carri armati e camion sono stati inviati in Russia. Secondo queste stime, a novembre 2022 erano state trasferite più di 65.000 tonnellate di munizioni. Inoltre, il complesso militare-industriale bielorusso produce mirini per i veicoli corazzati russi per il trasporto di truppe, nonché per i suoi carri armati T-72 e T-90. Infine, la Bielorussia produce veicoli corazzati "Kaiman", camion militari MAZ e telai MZKT per attrezzature pesanti. Inoltre, questo complesso militare-industriale produce droni da ricognizione, sistemi di razzi a lancio multiplo e modernizza i carri armati sovietici.
[20] Laurent Lagneau, "La Bielorussia modifica la sua Costituzione per autorizzare il dispiegamento di armi nucleari russe sul suo territorio", Military Zone opex360.com, 7 febbraio 2022. "La Bielorussia modificherà la sua dottrina sull'uso di armi nucleari tattiche", Courrier International, 17 gennaio 2024.
[21] Thorniké Gordadze, "La guerra è pace. Dovremmo negoziare con Putin ora? ", La Grande Conversation, 23 gennaio 2023.
[22] Su questo argomento, si veda War Diary #5, intitolato "La popolazione ucraina sta affrontando una guerra totale... ", dicembre 2022-aprile 2023.
[23] Tuttavia, l'Occidente continua a porre il veto o a consegnare troppo tardi e alla spicciolata l'equipaggiamento che consentirebbe al popolo ucraino di difendersi: sistemi Patriot e altre difese antiaeree, missili a lungo raggio, proiettili da 155 mm, ecc.
[24] Mykhailo Gonchar, "L'Ucraina dovrebbe affrontare l'industria russa della raffinazione del petrolio?", Russia Desk, 28 aprile 2024. Infine, gli Stati Uniti sembrano aver dimenticato che l'esercito di V. Putin aveva iniziato a distruggere sistematicamente le infrastrutture petrolifere ucraine già dal 27 febbraio 2022.
[25] Stiamo usando la nozione di "popolo" per la prima volta in questa guerra di aggressione russa. È usato qui nel senso di antropologia politica. In altre parole, pensiamo che un "popolo" sia il più delle volte costruito nelle avversità, vale a dire di fronte a un pericolo esistenziale e finché sopravvive, come è stato il caso, ad esempio, dei "Galli" dopo la guerra che Cesare ha condotto contro le decine di tribù dell'epoca.
[26] Thorniké Gordadze, art. già citato.
[27] Michel Goya, "Sostegno militare all'Ucraina", 22 maggio 2024: "Hitler e Mussolini si fanno beffe allegramente del 'patto di non aggressione' vendendo o fornendo attrezzature ai franchisti senza la minima ritorsione, per paura di 'provocare' questi dittatori. […] L'impegno materiale e umano da entrambe le parti non ha portato ad alcuna escalation del conflitto. Pochi mesi dopo la fine della guerra civile spagnola, la Germania e l'Unione Sovietica, che si erano appena scontrate lì, divennero persino alleate [il patto Ribbentrop-Molotov, che ha portato all'invasione, all'occupazione e all'annessione congiunta di alcuni stati o territori: Polonia, Finlandia, paesi baltici, Bessarabia]".
[28] Su questo argomento si vedano le serie di "Diari di prigionia" e "Diari di guerra" riprodotti su Internet.
[29] Un'allusione al fatto che, durante la "Guerra Fredda", gli scontri Est-Ovest si svolgevano al di fuori dell'Europa e del Nord America, su terreni cosiddetti "secondari", cioè gli altri continenti. Tuttavia, questa retorica presuppone che sia rimasto nell'era Eltsin e che consideri ancora la Russia di V. Putin come una potenza secondaria, che non è pronto ad accettare e che non tiene conto del "nuovo spirito imperiale" su cui ha costruito il suo potere dalla fine degli anni '90. Le amministrazioni americane, prima fuorviate dal maccartismo della Guerra Fredda, poi da un anticomunismo disordinato e da una profonda ignoranza storico-sociale della Russia – in particolare a causa della mancanza di ancoraggio alla sua realtà – hanno sempre avuto una visione totalmente fantastica di questo paese, sia ai tempi dell'URSS che dopo.
[30] Il 28 marzo 2024, la Russia ha imposto lo scioglimento del sistema di controllo delle sanzioni delle Nazioni Unite contro la Corea del Nord al fine di "restituire" le massicce consegne di proiettili, missili e armi del suo vicino Kim Jong-un. In Iran, oltre ai Sukhoi-35, elicotteri d'attacco, missili e sistemi di difesa aerea ottenuti in cambio di migliaia di droni iraniani Shahed-136 forniti o prodotti su licenza, questa cooperazione bilaterale include ora la messa in orbita di satelliti di sorveglianza iraniani con razzi Soyuz. Infine, nel 2023, il commercio russo-cinese (240 miliardi di dollari) è cresciuto del 26,3% su base annua e le esportazioni di beni cinesi a duplice uso verso la Russia (macchine utensili, componenti microelettronici, tecnologie di droni e missili da crociera) sono aumentate del 30% dall'inizio della guerra. Libération e Reuters, 13 ottobre 2023. Courrier International, 24 gennaio 2024. La Dépêche.fr, 19/03/2024. Notre Temps e AFP, 01/03/2024. Le nouvel Economiste, 03/05/2023. Libération, 25 maggio 2023. Le Grand Continent, 23 maggio 2024, L'Opinion, 13 aprile 2024.
[31] ISW del 20 giugno 2024.
[32] Cfr. la comprovata corruzione di alcuni eurodeputati, lo scandalo che circonda l'emittente radiofonica "Voice of Europe" e la rivelazione delle numerose talpe che sono state arrotolate, a volte per lungo tempo, in molti mezzi di comunicazione tra cui Le Monde Diplomatique; quando Anne Cécile Robert, la sua direttrice, è stata interrogata su Olesya Orlenko, una delle sue due giornaliste sospettate di "lavorare con l'FSB" fino a settembre 2022, ha risposto: "Abbiamo controllato il suo CV solo in superficie, non abbiamo i mezzi per svolgere indagini approfondite su ogni dipendente". Apprezzeremo la risposta di un giornale che si vanta di condurre indagini serie. Nicolas Quénel, "Questo giornalista russo che si è infiltrato a Le Monde diplomatique e L'Humanité", Le Point, 13 febbraio 2024. Leggi anche: Commissione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, Paul Massaro, Amélie Rausing, La Russia usa la corruzione come arma (e la complicità occidentale), martedì 6 giugno 2017.
[33] Così come i graffiti delle stelle di David, le mani rosse sul Museo dell'Olocausto, la deposizione di bare davanti alla Torre Eiffel o l'infelice manipolazione di esplosivi in una stanza d'albergo all'aeroporto di Roissy.
[34] Su questo argomento si vedano gli studi di Yale (già citati) e il sito web Disclosure. Ulysse Legavre-Jérôme, "Gas russo: la Francia è il campione europeo delle importazioni nonostante la guerra in Ucraina", Les Echos, 12 aprile 2024.
[35] Jean-Sylvestre Mongrenier, art. già citato.
[36] Si tratta di Richard Haass e Charles Kupchan, che sono membri del Council on Foreign Relations, il think tank che pubblica la rivista Foreign Affairs. Si dice che anche Thomas Graham e Mary Beth Long facciano parte di questi negoziati segreti. In un articolo sulla loro rivista del 17 novembre 2023, hanno proposto una nuova linea "incentrata sulla negoziazione di un cessate il fuoco riorientando l'azione militare [ucraina] sulla difensiva": la priorità non sarebbe più il ripristino della sua integrità territoriale, ma come compensazione, alcuni Stati occidentali offrirebbero garanzie di sicurezza all'Ucraina, Come è stato fatto dal 1975 e all'inizio del 2024: caso o necessità programmata? Gli autori, nella loro ricerca di una soluzione, ignorano da un lato la messa in discussione degli obiettivi di guerra di V. Putin e dall'altro le loro implicazioni per l'Ucraina". Articolo "Guerra in Ucraina: Russia e Stati Uniti conducono negoziati di pace in segreto da mesi", La Rédaction, La Libre.be, 07.07.2023.
[37] Cfr. Olivier Sueur, "Quale strategia per l'Occidente in Ucraina: rinuncia per default", Le Rubicon, 21 febbraio 2024. O. Sueur è un ex direttore delle SS presso il Ministero delle Forze Armate, professore a Sciences Po e ricercatore associato presso l'Istituto di Studi Geopolitici Applicati. Ancora una volta, citare o riassumere un testo non significa approvare tutti gli orientamenti dell'autore o del suo sito.
[38] Per non parlare delle fabbriche di Troll e Pegasus, per Netanyahu, questo potrebbe comportare una conflagrazione generalizzata del Medio Oriente che costringerebbe Biden a impegnarsi ulteriormente in questo pantano e quindi a perdere le elezioni contro Trump.
[39] E alcune istituzioni, tra cui la Corte Suprema. Gli Stati Uniti potrebbero allora sprofondare in un disordine politico e costituzionale senza precedenti, che avrebbe effetti non meno deleteri dell'elezione del "re del real estate". Più del 50% degli americani è convinto delle teorie del complotto, secondo un sondaggio congiunto dell'IFOP e dell'ambasciata degli Stati Uniti in Francia. "Teorie del complotto in Francia e negli Stati Uniti: un inventario che interroga e preoccupa", UP, 13 aprile 2023. Mike Rothschild, "QAnon e il futuro della politica americana", in Erodoto 2022/1-2 (n. 184-185), pp. 185-200. Theodore McLauchlin, "Una minaccia latente per il 2024: quanto è probabile che si verifichi una violenta crisi costituzionale negli Stati Uniti?", The Rubicon, 7 aprile 2023.
[40] Mathéo Malik, "Nucleare: affrontare Putin, una deterrenza di tipo europeo, conversazione con B. Tertrais", Le Grand Continent, 11 marzo 2024 e Nona Mikhelidze, "Ucraina: dove finisce la guerra?", Le Grand Continent, 23 febbraio 2024. Tertrais è un nucleocrate di lunga data.
[41] Michel Desmurget, La fabrique du crétin digital, Paris, Seuil, 2019.Cf. Grazie ad Antonin per aver attirato la mia attenzione su questo argomento, che avevo affrontato nei seguenti "Diari di prigione": "Coronavirus e dispositivi di controllo sociale: l'esempio cinese", #1, marzo 2020; "Indietro per tutti", #2, aprile 2020; "La morte nera del genere urbano", #11, febbraio 2022.
[42] Dal punto di vista teorico-politico, sarebbe più corretto dire che, essendo esposti principalmente a questo tipo di estorsione psichica, sensibile, cognitiva e fisiologica, essi sono proletarizzati continuamente e molto più profondamente degli operai del capitalismo termo-industriale all'inizio del XIX secolo. È l'ignoranza del ruolo loro affidato – quello di essere le piccole mani delle imprese digitali sovranazionali – che rende certe lotte politiche scollegate dalla dura realtà del capitalismo o dalla continua redistribuzione delle sue vocazioni imperiali.
[43] La peggiore ipocrisia assunta da alcuni, dato che dagli anni '20 e in diverse occasioni, non solo il popolo ucraino è stato decimato dalla fame, non solo il paese è stato colonizzato e russificato con la forza, ma anche l'intellighenzia di questo paese è stata esplicitamente sterminata; Questo si chiama genocidio. Inoltre, il grano, il carbone e il ferro ucraini provenienti dal Donbass e da altre risorse sono stati sistematicamente saccheggiati dagli stalinisti.
[44] Anche in questo caso, la lunghezza del nuovo confine con un paese della NATO, vale a dire la Romania settentrionale, verrebbe aumentata di 650 km.
[45] V. Putin "vittorioso in Ucraina, non mancherà di tornare alla carica, una volta che le ferite di questa guerra saranno state rimarginate in due o tre anni".
[46] Il 10 febbraio 2023 la Romania e la Moldavia sono state sorvolate da due missili da crociera russi prima di entrare in Ucraina; i rumeni semplicemente negavano, era più pratico. In Polonia, almeno tre missili russi hanno violato lo spazio aereo dall'inizio della guerra; i detriti di uno di questi missili (il KH 55, 8 m, 2 t.) sono stati trovati addirittura a 220 km a nord-ovest di Varsavia. Infine, tre giorni dopo l'ultimo sorvolo del territorio polacco, il 24 marzo 2024, l'ambasciatore russo non ha ritenuto opportuno partecipare alla convocazione del governo polacco. D'altra parte, quando il 24 novembre 2015, lo spazio aereo turco è stato sorvolato per una decina di secondi da un Sukhoi SU24, l'aereo è stato abbattuto immediatamente. V. Putin aveva gesticolato per sette mesi e poi si era calmato. Non c'è dubbio che le reazioni occidentali agli attuali "errori di sparatoria" siano interpretate politicamente al Cremlino. Questo è uno dei tanti modi del KGB di mettere alla prova i governi dell'"Occidente collettivo".
[47] L'unico punto di passaggio terrestre tra Kaliningrad e la Bielorussia, quindi con la Russia, e che misura circa 65 km in linea d'aria. Questa exclave è rifornita da una ferrovia che passa per Minsk (Bielorussia) e Vilnius (Lituania).
[48] Questo è ciò che ha ispirato War Diary #13 intitolato "Come l'Ucraina e l'Europa sono sfuggite a un disastro nucleare: un grave incidente, rispetto al quale Chernobyl e Fukushima potrebbero essere nient'altro che un gioco da ragazzi", febbraio 2024. La traduzione personale di questa intervista è tratta da quella pubblicata dal sito pro-nucleare ICC in Ucraina: https://rdcentre.com.ua/zaporizka-aes-rik-heroizmu-boliu-ta-vyprobuvan/
[49] Cfr. a questo proposito i diari di guerra #3, #4, #13 e #15 già citati e pubblicati su Internet.
[50] Cfr. l'evoluzione delle dottrine dell'uso delle armi nucleari negli Stati Uniti e in Russia nel "War Diary" #4.
[51] Al fine di distruggere le infrastrutture strategiche. O lo lancerebbe in un'area scarsamente popolata con l'obiettivo di terrorizzare la popolazione, anche al di là del campo di battaglia? Peggio ancora, il progetto neo-imperiale di Putin potrebbe ospitare la riduzione di parte del territorio ucraino a un deserto post-nucleare inabitabile grazie a una bomba al neutrone, quando questo gesto equivarrebbe a un suicidio collettivo? La presentazione di Putin della possibilità di una guerra nucleare è diventata identica a quella della guerra santa attraverso la Jihad: "Certo, moriremo tutti, ma come vittime di aggressioni, come martiri, andremo in paradiso, e loro [i nemici della Russia] semplicemente moriranno, perché non avranno nemmeno il tempo di pentirsi". ha detto il 18 ottobre 2018 dal simposio del Valdai Club a Sochi. AFP, Courrier International, La Presse, Le Devoir ecc.
[52] "Un giorno prima dell'invasione, la Germania e la Francia sostenevano ancora che Putin aveva promesso loro che non avrebbe attaccato l'Ucraina!" Intervista a Zelensky a Kiev di Isabelle Lasserre, Le Figaro, 10 febbraio 2023.
[53] In un documentario intitolato "Un presidente, l'Europa e la guerra" trasmesso il 30 giugno 2022 su France 2, il giornalista Guy Lagache filma i consiglieri diplomatici del presidente francese mentre ascoltano la telefonata fatta tra i due leader il 20 febbraio, quattro giorni prima dell'inizio dell'offensiva russa in Ucraina. https://www.youtube.com/watch?v=TN-PrKMgKXE Nonostante il fallimento di questa "diplomazia delle relazioni intime", E. Macron ha ripetuto l'esperienza con Xi Jinping invitandolo in un luogo della sua infanzia, il Col du Tourmalet, nei Pirenei orientali.
[54] Cfr. le società francesi quotate dal CELI dell'Università di Yale. https://urlz.fr/pXKQ Alla fine del 2023, Total era ancora coinvolta nel mega-progetto del gas nella penisola di Yamal in Siberia con la società russa Novatek, Camillle Escudé, "Le Temps du débat", France Culture, 25 dicembre 2023.
[55] Su questo argomento, si veda il Quaderno di Guerra n. 15 intitolato "CEA, EDF, Orano, Engie, Framatome, Alstom e Rosatom vanno in barca"
[56] I contadini e le altre popolazioni dell'ex Unione Sovietica furono coinvolti nel rapido sviluppo del capitale tedesco dopo l'Anschluss della RDT. Ad esempio, l'Ucraina ha perso 8,39 milioni di abitanti tra il 1991 e il 2021 (da 52,18 a 43,79 milioni). Fonte: Banca Mondiale. A questo proposito, lo storico americano T. Snyder ha ricordato al Bundestag nel 2017 tutto il "lavoro di memoria" che resta da fare per quanto riguarda le atrocità naziste commesse in Ucraina sotto l'influenza di uno spirito coloniale. Altrimenti, persisterebbe, ha detto. Cfr. Diario di guerra #12 intitolato "La responsabilità storica della Germania nei confronti dell'Ucraina, conferenza di T. Snyder davanti al Bundestag".
[57] Conferenza sulla difesa di Londra: Russia e Cina stanno collaborando su attrezzature da combattimento in Ucraina, Kings's College London. The Guardian, 23 maggio 2024.
[58] Compresa la sua società, Internet Research Agency (IRA). Le attività del gruppo, anche in Africa, sono state rilevate dal Cremlino. A questo proposito, una delle migliori fonti di informazione è il sito web dell'opposizione russa The Insider, che fa spesso riferimento ad altri siti o giornali seri e riconosciuti con cui collabora e che i media mainstream francesi hanno scoperto all'inizio di aprile 2024 sulla cosiddetta "sindrome cubana".
[59] In un fenomeno del tutto simile a quanto accaduto in URSS, gli Ayatollah persero buona parte del loro potere effettivo a vantaggio di un regime mafioso guidato dalle "Guardie Rivoluzionarie", quindi un più facile riavvicinamento con il Cremlino. Una buona analisi di Gilles Kepel.
[60] Kirill era un agente del KGB negli anni '70, con il nome di Mikhailov: mentre era rappresentante del patriarcato a Ginevra, ebbe un incidente stradale al volante della sua BMW, che guidava ad alta velocità. Nel veicolo c'erano due passeggeri, un colonnello del KGB e suo figlio che è rimasto ferito. Cirillo fu quindi rimpatriato a Leningrado. Cfr. Bernadette Sauvaget, "Kirill, patriarca che ha Dio solo per Putin", Libération, 5 maggio 2022. Marc Nexon, "Kirill, l'angelo custode di Putin", Le Point, 29 novembre 2012 e Irina Filatova, "Il patriarca politico", The Guardian, 2 febbraio 2009.
[61] Contrariamente a quanto generalmente si dice o si scrive, è stata l'immigrazione di origine tedesca che è stata la maggioranza negli Stati Uniti durante il primo XX secolo. Johann Chapoutot, Storia della Germania dal 1806 ai giorni nostri, Parigi, PUF, 2017, p. 55.
[62] Esportazione dell'ideologia eugenetica, razzismo antisemita ampiamente diffuso nel paese da Ford dal 1920 in poi, prestiti finanziari vantaggiosi, trasferimenti di tecnologie avanzate, stretta collaborazione legale nella stesura delle leggi di Norimberga, partecipazioni azionarie interindustriali e bancarie, costruzione di attrezzature militari... Cfr. l'appendice intitolata "Dall'eugenetica al nazismo (1868-1939)" in Jean-Marc Royer, Le Monde comme projet Manhattan. Dai laboratori nucleari alla guerra generalizzata ai vivi, Le Voyageur Clandestin, 2017.
[63] Cfr. Diario di guerra #5, "La popolazione ucraina sta affrontando una guerra totale. Alcuni guardano dall'altra parte mentre il capitale occidentale è pronto a lasciarlo andare", 19 dicembre 2022 e War Notebook #6, "Gli ucraini pagano con la vita il cinismo di alcuni e la barbarie di altri", 20 gennaio 2023. Inoltre, dovremmo anche rivedere l'atteggiamento del capitale europeo nei confronti del Cremlino da un quarto di secolo e dell'Azerbaigian, il nuovo Eldorado del petrolio e del gas dal 2022. Cfr. su questo argomento i Diari di Guerra #2, #12 e #15.
[64] Il 27 febbraio 2022, la Germania ha autorizzato la consegna di nove obici dall'Estonia e gli Stati Uniti hanno trasferito 200 Stinger. Il 28 febbraio la Polonia ha trasferito 100 mortai e munizioni e ha avviato discussioni sul trasferimento di diversi suoi caccia e aerei d'attacco all'Ucraina. La Francia ha inviato i sistemi anticarro Milan e Javelin e i Mistral MANPADS. Molti altri paesi hanno inviato armi simili: lanciagranate, mortai, MANPADS, proiettili e giubbotti antiproiettile. Tutto ciò era certamente utile, ma non poteva invertire il corso delle ostilità. Insider Giugno 17, 2024, https://theins.ru/en/politics/272467
[65] Una guerra "totale" prende esplicitamente di mira i civili del campo avversario. L'espressione "genocidio" si applica, tra le altre cose, alla deportazione di bambini ucraini in Russia per la quale Putin è ricercato dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia. Cfr. Diario di guerra #11 in cui questo termine è esaminato in dettaglio.
[66] The Insider, Veaceslav Epureanu, “Tanks still matter, drones trump jets, nukes don’t deter : 18 key takeaways from the war in Ukraine”, 2 march 2023.
[67] Ce front mesurait alors 750 km, celui de l’Ukraine 1 200. Le Nord de la France avait perdu les deux-tiers de son patrimoine architectural et de grandes « zones rouges » interdites y persistent, plus d’un siècle après. Ce sera le cas en Ukraine, mais le minage et les produits utilisés sont tels qu’une grande partie du territoire sera pollué et dangereux encore bien plus longtemps qu’ici.
[68] Su questo argomento, vedi i diari di guerra #3, #4, #13 e #15, che sono facilmente accessibili su Internet.
[69] Le fabbriche di troll hanno solo modernizzato questa pratica.
[70] Ancora negli anni '70, famosi giornali e scrittori passavano allegramente da uno stalinismo bonario all'altro: il maoismo. In entrambi i casi, i milioni di morti di queste dittature non sono stati conteggiati prima del "grande balzo in avanti" acquisito da questi popoli grazie all'industrializzazione massiccia e alla proletarizzazione violenta dei contadini.
[71] Descritta nel 2003 dalle Nazioni Unite come "la città più distrutta della Terra".
[72] Il film "20 giorni a Mariupol" di Mstyslav Chernov, 2023 è assolutamente da vedere nonostante la sua durezza. https://vu.fr/pplYc
[73] I video hanno mostrato come il suo leader, Prigozhin, reclutasse lui stesso i detenuti riuniti nei cortili delle carceri, ovvero questo tipo di arruolamento metteva di fatto fuori gioco i servizi penitenziari, la giustizia e la legge con l'accordo di V. Putin che avrebbe dovuto perdonare i sopravvissuti. Questo la dice già abbastanza sul tipo di Stato e di regime che regna in Russia. Si tratta di uno studio discusso nel Diario di guerra #7 intitolato "Trentuno tesi sulla Russia post-sovietica" e sul quale dovremo tornare.
[74] Al punto da renderlo il paese più minato al mondo: Cleaning the Augean Stables: Humanitarian Demining in Ukraine, PDF, Luliia Osmolovska e Nataliia Bilyk, GLOBSEC, Programma Ucraina ed Europa orientale, gennaio 2024, 44 p.
[75] Queste sono state alcune delle "mancate anticipazioni" che sono costate al generale Zaluzhny la sua posizione di capo di stato maggiore l'8 febbraio 2024. Inoltre, l'intervista rilasciata il 1° novembre 2023 all'Economist è stata un grave errore militare e politico: da un lato, non è stata chiaramente coordinata con la presidenza ucraina e, dall'altro, ha rivelato le debolezze ucraine.
[76] Gli europei hanno votato per i 50 miliardi di euro di aiuti all'Ucraina, ma a quale scopo? "È importante notare che l'Ucraina non è autorizzata a utilizzare questi aiuti finanziari per le sue esigenze militari. Per quanto sorprendente possa sembrare, due anni dopo l'inizio dell'invasione russa su larga scala dell'Ucraina, l'Occidente si rifiuta formalmente di finanziare la guerra. Pertanto, l'Ucraina può coprire le sue spese militari solo con entrate provenienti da tasse, dazi doganali, dividendi di imprese statali, prestiti interni (come le obbligazioni militari) ecc. Pavlo Kalashnyk, "Il tuo portafoglio o la tua vita: l'Ucraina si trova di fronte a una difficile scelta tra necessità militare e ripresa economica", The Insider, 4 marzo 2024.
[77] La Vigie, Weekly Report (Ukraine War) n. 82 del 18 febbraio 2023 e Trading Economics, Switzerland Exports to Uzbekistan, 2024 Data 2025 Forecast 1993-2023 Historical.
[78] Cfr. Quaderno di guerra #11 "I raccolti sanguinosi dell'Holodomor o il precedente tentativo di sterminare il popolo ucraino", settembre 2023.
[79] Julia Pascual e Faustine Vincent, "In Ucraina, tra i tre e i quattro milioni di persone hanno dovuto lasciare le loro case, distrutte da un drone o da un razzo", Le Monde, 26 gennaio 2024. Amandine Hess, "Ucraina: il bilancio di due anni di guerra in cifre", Euronews, 24/02/2024. Da parte russa, 150.000 morti e 300.000 feriti entro la fine di marzo 2024. Stime: Mediazona e BBC News russo, A. Xerri con AFP, "Invasione russa. In un'inchiesta congiunta, Mediazona e BBC News Russian hanno stilato, settimana per settimana dall'invasione dell'Ucraina del 24 febbraio 2022, un elenco delle vittime del conflitto", L'Express, 22-02-2022. Air et Cosmos, Xavier Tytelman, gennaio 2024: https://www.youtube.com/watch?v=C1WCDRMBjSg e "Affaires étrangères" di France Culture, 24 febbraio 2024 e The Insider, https://theins.ru/en/news/250063
[80] "Mi spieghi perché Kiev è ancora in piedi. Perché questa città nazista non è ancora rasa al suolo? […] Questa città deve semplicemente essere annientata. Tutto deve scomparire dalla faccia della terra. E il presentatore Sergei Mardan ha chiarito il programma: "L'Ucraina deve diventare un cumulo di macerie... Tutta l'Ucraina sarà metodicamente trasformata in una zona sanitaria, cioè in una zona di guerra, dove non c'è elettricità, non ci sono ponti, non ci sono ferrovie, non ci sono trasporti, non ci sono tubature, non ci sono servizi di emergenza, non ci sono ospedali in grado di funzionare. Insomma, una zona di esodo di massa... Tra i dirigenti russi non c'è più un partito di guerra, un partito di pace. C'è solo il partito della vendetta... ». Commenti riportati da Françoise Thom in un articolo intitolato "La grande impostura russa", 14 aprile 2024, Desk Russia.
[81] Un discorso comune in Germania, anche prima che Hitler salisse al potere. Cfr. l'appendice "Dall'eugenetica al nazismo (1868-1939)", già citata.
[82] Anche nell'esercito. Buon articolo di Antoine Izambard e Vincent Lamigeon, "Russia: rivelazioni su questi soldati francesi sotto influenza", Sfide, 27.04.2023.
[83] I parenti delle decine di migliaia di vittime delle precedenti guerre di Putin devono aver apprezzato questa clemenza occidentale per il suo vero valore.
[84] Avevamo già indicato le "ragioni capitali" di questa amnesia ipocrita nel primo "Diario di guerra".
[85] Per quanto riguarda la NATO, il "Diario di guerra #1" intitolato "Note sull'invasione dell'Ucraina" fa un'analisi critica delle azioni di questa alleanza. Resta il fatto che la spesa della NATO è cambiata poco tra il 2012 (997 miliardi di dollari) e il 2022 (1051 miliardi di dollari) secondo questa organizzazione, mentre dal 2000, secondo il National Peace Research Institute di Stoccolma, la spesa militare della Russia è balzata del 227% e quella della Cina del 566%. Nel 2022, la spesa militare della Russia è stata di oltre 86 miliardi di dollari, un raddoppio del budget dal 2007. Aumenterà del 68% nel 2024 con 115,5 miliardi di dollari votati dalla Duma, ovvero 2,7 volte di più rispetto al 2007.
[86] Il "Movimento per la Pace" è solo un residuo decrepito delle cinghie di trasmissione del Cremlino e delle sue ramificazioni.
[87] E decisamente, sembra che questo stato d'animo sia moralmente e politicamente senza tempo in questo paese. D'altra parte, coloro che da tempo hanno disonorato la storiografia francese e giurano ai loro dèi che il ricordo delle ripetute ritirate davanti a Hitler prima, durante e dopo l'accordo di Monaco (1938) non ha ragione di esistere oggi, hanno ancora gli occhi chiusi e le orecchie tappate, mentre nel 1972 lo storico Robert Paxton – Francia di Vichy. 1940-1944, Le Seuil – aveva già fatto loro notare che "il silenzio francese di trent'anni" era durato troppo a lungo, per quanto riguardava la collaborazione.
[88] Stéphane Audoin-Rouzeau, "Purtroppo abbiamo bisogno di una decisiva sconfitta russa in Ucraina", Médiapart, 13 febbraio 2023. Va notato che questo è esattamente ciò che sostiene contemporaneamente un altro storico, Timothy Snyder, su Le Monde del 7 aprile 2023 e Géo del 10 aprile 2024.
[89] In particolare, quello della loro resistenza tardiva: in Francia ci furono tra i 4.000 e i 7.000 fucilati dai nazisti, il che non impedì al PCF di definirsi "il partito dei 100.000 fucilati" e, più recentemente, quello dei soli 70.000 fucilati...