Narcisismo collettivo di crisi
- Quando il soggetto in crisi si gonfia con sufficienza fino a sembrare grande quanto una «nazione» -
di Clément Homs
«Sicuramente, c'è l'economia e la disoccupazione, ma quel che essenzialmente conta è la battaglia culturale e identitaria» (Manuel Vallis, 4 aprile 2016)
Il processo che ha a che fare con la formazione dell'identità moderna, ovviamente, non è di certo estraneo alla sua iscrizione nel funzionamento logico e nella dinamica del capitalismo. Si potrà, beninteso, parlare di recrudescenza di identità etniche e religiose negli anni '80 e '90, soprattutto nel mondo arabo (il cosiddetto processo di reislamizzazione è caratteristico di ciò che Ernst Lohoff e Norbert Trenkle chiamano «religionismo» [*1]) e in Africa, durante quello che è stato chiamato il «decennio del caos», oppure si potrebbe evocare anche «l'ondata di passioni e di odio nazionalista che ai nostri giorni sta travolgendo l'Europa post-comunista» (Leszek Kolakowski), di cui si è conosciuto il drammatico esito nei giorni della guerra nella ex Jugoslavia. Durante la configurazione che il capitalismo assumerà a partire dagli anni '80, si è già potuto vedere come, cronologicamente, la peste identitaria immanente al capitalismo sarebbe stata un fenomeno che avrebbe colpito prima le periferie già collassate, a Est come a Sud. Luoghi come l'Ungheria di Victor Orban, la Russia di Putin o la Polonia totalmente cattolica e conservatrice ne sono gli odierni testimoni. Con un certo sfasamento cronologico, quasi due decenni, compatibilmente con la fine della moltiplicazione auto-sostenuta dal capitale fittizio avvenuta a partire dagli anni 2000, e con il collasso del boom post-fordista che si basava su una tale moltiplicazione [*2], troviamo nei centri capitalisti il medesimo rigurgito di quell'intolleranza identitaria desiderosa di instaurare un ordine culturale ed etnico omogeneo. Ancora una volta si rivendica, «La France aux Français», «America First», «Britain First» ( insieme a tutti i complementi gastronomici di ciò che costituisce la relazione polare tra «prima i bianchi» e «prima gli indigeni») e quindi la pretesa omogeneizzazione «etnica» e culturale della forza lavoro nazionale o della forza lavoro «specificamente in lotta».
Le ideologie di crisi e l'esperienza del soggetto moderno
A differenza delle società premoderne dove la forma del soggetto sociale viene assegnata, soprattutto nelle società di Ordini e caste, l'individuo modellato nella forma del soggetto moderno deve affermare costantemente la sua identità, la quale non è mai determinata in anticipo, ma viene realizzata come un compito coercitivo e obbligatorio attraverso un'autodisciplina, interiorizzando quelli che sono i vincoli del contesto-forma che affronta e riproduce. Come tale, la forma soggetto della società dove regna il modo di produzione capitalista appare come una gigantesca collezione di identità funzionali, la cui forma elementare consiste nell'identità individuale. Questa identificazione primaria viene sempre ad essere associata a un'adesione dei soggetti capitalisti a vaste identità collettive. In tal senso, le nazioni capitalistiche hanno anche - ieri come oggi - una molla interna annidata nella forma soggetto moderna. Le ideologie di crisi del capitalismo - e in particolare l'adesione soggettiva del soggetto moderno alla forma-nazione, nella sua modalità di nazionalismo classico e di neo-nazionalista - si basano sull'esperienza d questo soggetto «monetarizzato». Marx ha mostrato già che il soggetto modellato dai rapporti sociali capitalistici, si innamora strutturalmente di una potenziale onnipotenza perché nella forma capitalistica della vita sociale:
«Ciò che mediante il denaro è a mia disposizione, ciò che io posso pagare, ciò che il denaro può comprare, quello sono io stesso, il possessore del denaro medesimo, Quanto grande è il potere del denaro, tanto grande è il mio potere. Le caratteristiche del denaro sono le mie stesse caratteristiche e le mie forze essenziali, cioè sono le caratteristiche e le forze essenziali del suo possessore. Ciò che io sono e posso, non è quindi affatto determinato dalla mia individualità. Io sono brutto, ma posso comprarmi la più bella tra le donne. E quindi io non sono brutto, perché l'effetto della bruttezza, la sua forza repulsiva, è annullata dal denaro. Io, considerato come individuo, sono storpio, ma il denaro mi procura venti quattro gambe». [*3] Il soggetto monetarizzato si trova perciò ad essere in ogni istante combattuto tra questa potenziale onnipotenza, alla quale potrebbe accedere attraverso l'ottenimento di questo denaro capace di tutte le metamorfosi, e ciò che gli fa sperimentare l'esperienza quotidiana: vale a dire, la sua concreta impotenza a fronte del suo proprio rapporto con la società che gli si contrappone come un vincolo sociale cosificato, in particolare in quello che si concretizza sotto forma del processo di valorizzazione e delle sue dinamiche che gli impongono una situazione senza che lui possa intervenire concretamente. Questa scissione è alla base delle ideologie di crisi del capitalismo.
Capitalismo e Mercato dell'Identità
Durante gli anni 2000, e più ancora a partire dalla crisi del 2008, il neo-nazionalismo e quel che rimaneva della peste identitaria di cui il neo-nazionalismo è solo un caso particolare, li abbiamo visti ovunque di ritorno insieme al loro desiderio di tornare alle vecchie identità collettive funzionali; fantasmi di un'onnipotenza compensatoria per l'impotenza concreta dei soggetti monetarizzati di fronte al loro rapporto con la società che si contrappone loro come una forza estranea cosificata e naturalizzata, vale a dire, senza che essi possano intervenire. Il narcisismo individuale di onnipotenza potenziale non può più realizzarsi, in particolare nella situazione di crisi, e viene compensato da un narcisismo di sostituzione: l'individuo si gonfia partendo dal fantasma della propria grandezza e attraverso una «comunità immaginata» identitaria più vasta che possa ingigantire tutta la sua virilità bloccata, in modo che ciò gli possa consentire di dimenticare la sensazione della propria inferiorità: un narcisismo collettivo di crisi (Erich Fromm). In questo quadro, i primitivismi contemporanei (J.-L. Amselle) che fioriscono dovunque, non possono essere altro che le materie prime contemporanee delle neo-tradizioni capitaliste che serviranno da supporto per l'ancoraggio al capitalismo di queste identità funzionali; nel senso che, dopo la prima ondata - della seconda metà del 19° secolo - ecco che una nuova «produzione di massa di tradizioni inventate» (Eric Hobsbawm) fornisce in anticipo al Mercato dell'Identitario ciò che serve al fine di equipaggiare le monadi isolate per la guerra culturale generalizzata nel contesto dell'immutato quadro dell'ontologia capitalista.
Al supermercato dell'identità funzionale, il religionismo, il neo-nazionalismo, il micro-nazionalismo identitario e separatista (il cosiddetto nazionalismo regionale), il populismo identitario, il neo-virilismo, o i due estremi del rapporto polare che costituisce il neo-identitarismo postmoderno «antirazzista» (di sinistra) e il neo-razzismo etno-differenzialista di estrema destra, si vendono come il pane. Il culturalismo diventa così la logica ideale del tardo capitalismo, e ne costituisce la sua principale ideologia di crisi. In tal senso, esso diventa il comune brodo di coltura tanto dei partigiani dello «scontro tra culture» quanto quelli del «dialogo tra le culture», visto che tutti quanti affermano il primato della questione delle identità collettive culturali-religiose o neo-nazionaliste, quando invece le democrazie borghesi di centro non fanno altro che strombazzare i cosiddetti presunti valori universali «europei» e «occidentali» (anche se questi vengono sempre più demonizzati dalla logica di esclusione sociale e razzista che viene prodotta dal sistema della concorrenza capitalistica e de del suo mortifero gioco delle sedie in cui uno rimane in piedi). A sinistra così come a destra, gli imprenditori delle identità collettive di ogni tipo sono qui solamente nella veste di funzionari del capitale nell'epoca della sua decomposizione. Lungi dall'opporsi al flusso seguito dal mondi. essi nuotano (anche) con la corrente.
- Clément Homs - 8 ottobre 2017 -
NOTE:
[*1] - Si veda: Norbert Trenkle, «Pourquoi l'islamisme ne peut pas être expliqué à partir de la religion ?» ( http://www.palim-psao.fr/2015/05/pourquoi-l-islamisme-ne-peut-pas-etre-explique-a-partir-de-la-religion-par-norbert-trenkle.html ). Sull'interpretazione di questa re-islamizzazione vista come fenomeno reattivo e identitario, si vedano anche le opere di François Burgat; soprattutto "L’islamisme à l’heure d’Al-Qaida", La Découverte, 2005 .
[*2] - Su questo, si veda Ernst Lohoff e Norbert Trenkle, "La Grande dévalorisation. Pourquoi la spéculation et la dette de l'Etat ne sont pas les causes de la crise", Post-éditions, 2014.
[*3] - in Karl Marx, "Manoscritti economico-filosofici del 1844". Einaudi.
fonte: Critique de la valeur-dissociation. Repenser une théorie critique du capitalisme

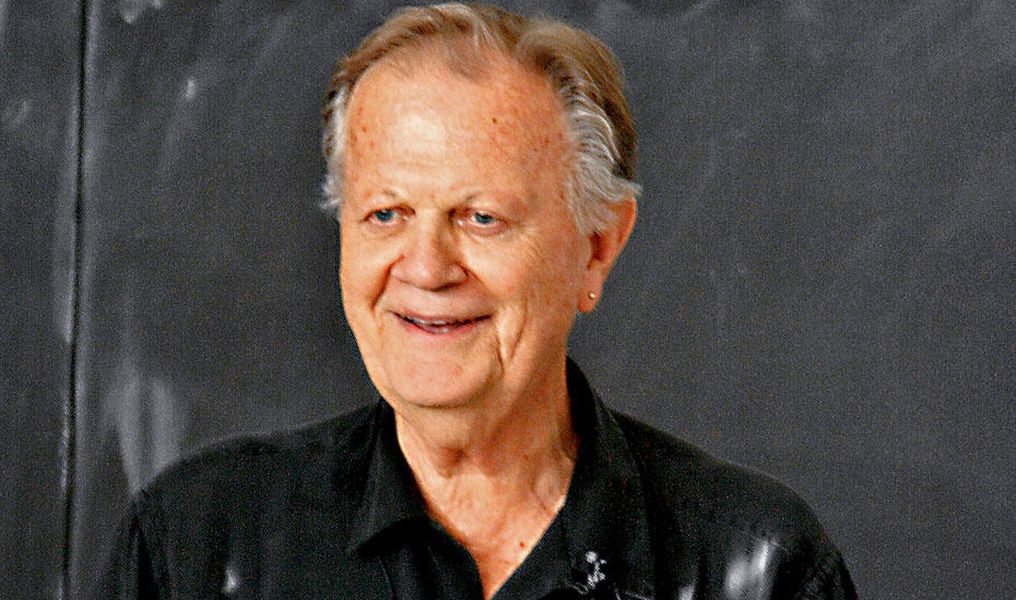




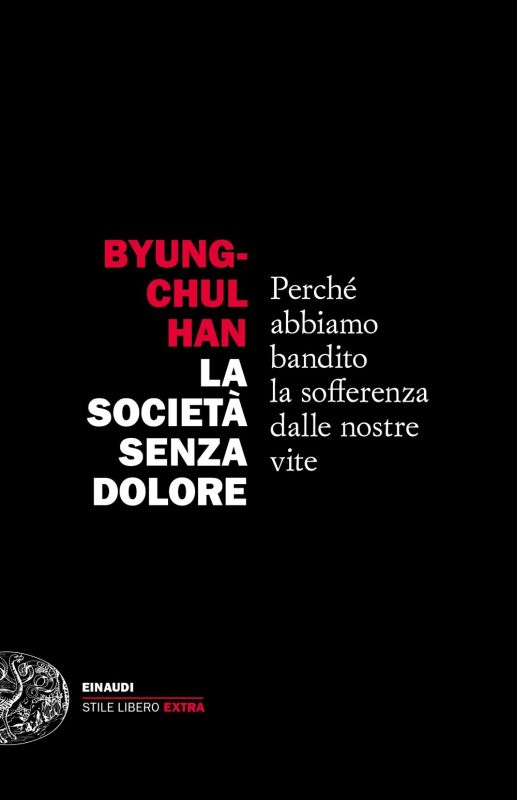













 nascosta sotto la veste nera, verrà onorata con una targa nella capitale irlandese.Forse proprio nella georgiana Marrion Square, dove nacque e crebbe con un papà importante, Lord Aushborne, la più alta carica del Paese fino alla creazione dello Stato libero d'Irlanda nel 1922 dopo la guerra civile contro i britannici e la partizione dell'isola.
nascosta sotto la veste nera, verrà onorata con una targa nella capitale irlandese.Forse proprio nella georgiana Marrion Square, dove nacque e crebbe con un papà importante, Lord Aushborne, la più alta carica del Paese fino alla creazione dello Stato libero d'Irlanda nel 1922 dopo la guerra civile contro i britannici e la partizione dell'isola. 