
Nota critica su "Islam e capitalismo" di Maxime Rodinson
- Marx, Weber, Kurz e presunte «forme antidiluviane» del capitale -
di Clément Homs
Maxime Rodinson, nel suo classico, "Islam e Capitalismo" - in un dibattito, cominciato negli anni '50, sulla presunta incapacità da parte dell'Islam di generare il capitalismo (quest'ultimo termine, all'epoca veniva eufemizzato sotto la categoria borghese e naturalizzante di «sviluppo» o di «economia di mercato») - ha il merito di combattere contro la visione orientalista che vede un mondo arabo arretrato, immobile e immerso in una stagnazione multi-secolare. Tuttavia, nel pensare che il capitalismo sarebbe sempre esistito nelle società musulmane premoderne, sotto forma embrionale, la sua posizione rimane implicitamente segnata dall'idea problematica di uno sviluppo progressivo e trans-storico, ad un livello sempre più elevato, della forma valore e del denaro; ed è anche vero che è stato lo stesso Marx a suggerire una simile comprensione erronea, quando ha evocato le «forme antidiluviane» del capitale, nelle società precapitalistiche (anche Jacques Camatte rimarrà intrappolato in questa problematica erronea).
Secondo Robert Kurz - che ha mostrato la tensione e la contraddizione in Marx sia su tale questione che su altre (in particolare, l'aporia di Marx circa la questione del lavoro [*1]) - evocando, da un lato, questa teoria delle «forme antidiluviane», in quanto stato sottosviluppato di una logica trans-storica semplice, Marx soccombe all'ideologia della storia della modernità capitalista, sostenuta dall'Illuminismo, per la quale tutta la storia precedente non costituisce altro che un cammino verso sé stessa. Dall'altro lato, si vedono ugualmente in Marx alcuni sviluppi molto più radicali che sfuggono a questa ideologia, quando egli si oppone agli «economisti che cancellano tutte le differenze storiche e vedono in tutte le forme della società, quelle che sono le forme della società borghese» [*2]. Marx arriva persino a storicizzare le categorie stesse quando afferma che «il concetto economico di valore non si incontra affatto nell'Antichità [...]. Il concetto di valore rientra integralmente nell'economia più moderna, in quanto esso è l'espressione più astratta del capitale stesso e della produzione basata sul capitale» [*3].
Per questa linea argomentativa che si può trovare nel Marx esoterico e che verrà ampliata dalla corrente della Critica del Valore, il «concetto» di valore corrisponde infatti ad una realtà sociale storicamente specifica unicamente della sola formazione sociale capitalistica e, viceversa, la realtà deve generare a sua volta il suo «concetto» in quanto «forma oggettivata del pensiero», e quindi anche in quanto contenuto cosciente della riflessione. In questa nuova prospettiva, è proibito proiettare la forma della ricchezza astratta, caratteristica della sola società capitalistica, sulle società precedenti. Robert Kurz scioglierà i fili di questo Marx esoterico, mostrando che se il «valore» non esiste prima del capitalismo - e quindi «non si pone affatto» anche nel modo di pensare - come possono esistere in tali condizioni allora la merce ed il denaro? Facendo seguito agli storici dell'Antichità, i quali affermano che «non si farà riferimento ai concetti e alla terminologia dell'economia moderna, dal momento che questi concetti in realtà non si applicano altro che al mondo per il quale sono stati creati» [*4], facciamo appello ad una «revisione straziante» che ora dobbiamo affrontare, nel momento in cui, per il Medioevo, invitiamo Jacques Le Goff, Alain Guerreau e Bartolomé Clavero, chiedendo loro di «ignorare la storiografia» [*5]. In questo Medioevo, così come per tutto l'insieme delle società antiche, «l'economia non esiste», «esiste del denaro, ma non l'economia». In definitiva, si tratta della totalità delle nostre categorie moderne (lavoro, denari, merce, valore, valore di scambio, produzione, modo di produzione, economia, ecc.) le quali non possono più essere retroproiettate su tutte le società umane precapitaliste, se vogliamo comprendere in maniera adeguata i rapporti sociali ed il loro principio costitutivo [*6].
Maxime Rodinson rimane legato ai vecchi presupposti della filosofia della storia borghese, ereditata dal Marx essoterico e quindi dall'insieme del marxismo tradizionale. Per troncare il dibattito sulla responsabilità dell'Islam per quanto riguarda la mancanza di sviluppo dei Medio Oriente, tutta la tesi di Rodinson, svolta nel terzo capitolo del suo libro, consiste nel forgiare il concetto di «settore capitalistico» a partire dall'esistenza riconosciuta nel mondo musulmano medievale di queste «forme antidiluviane» di capitale evocate da Marx: il «commercio», il «capitale mercantile» ed il «capitale finanziario» (portatore di interesse) [*7].
In maniera assai logica, Rodinson arriva a fondere il Marx essoterico delle «forme antidiluviane» con la definizione borghese, naturalizzante e trans-storica, del capitalismo data da Max Weber [*8]. Seguendo quest'ultimo, in Rodinson, la totalità viene colta a partire dall'approccio secondo quei mattoni elementari che sono gli Ideal-tipi weberiani, e qui, più specificamente, a partire dal mattone più elementare, il quale incarna la forma, o il modo di comportamento qualificabile come «capitalista» (ricerca del guadagno monetario attraverso lo scambio ed il calcolo economico). Ed è proprio sulla base della logica delle azioni, delle strutture o delle particelle elementari individuali (qui di natura economica), che vengono in seguito gonfiate oppure «aggregate» le quantità di relazioni relative alla società vista al livello del tutto, dell'insieme, vale a dire che Rodinson chiama la «formazione socio-economico capitalista». Qui, Rodinson è particolarmente vittima dell'individualismo metodologico, quando nelle prime pagine del suo libro si appoggia alle definizioni problematiche di Julian Hochfeld e di Max Weber [*9]. Secondo questo punto di vista - quello della successione logica o dello sviluppo sequenziale - delle «forme embrionali» del capitale, viste come risultato di numerose altre forme di azione logica, in pratica, possono essere isolate e per così dire dissezionate, come se fossero dei fenomeni distinti, senza che si prenda simultaneamente in considerazione il contesto sociale e storico in cui sono immersi.
L'individualismo metodologico, è sempre stato caratteristico della filosofia e della scienza borghese nel suo insieme, e, in particolare, dell'economia politica, quando non struttura in maniera soggiacente i «modelli storiografici della transizione» (Jérôme Baschet) dal feudalesimo al capitalismo (ed in maniera caricaturale nella costruzione grottesca del concetto di «capitalismo popolare» per il Medioevo di Jacques Heers). In sostanza, questo individualismo metodologico (che in parte ritroviamo anche in Marx, come ha mostrato Robert Kurz [*10]) vorrebbe esporre e spiegare una logica globale e determinante il tutto sulla base e a partire dal caso di ciascun individuo isolato, che quindi appare come un «modello» per la comprensione, non solo di queste azioni individuali definite come «fondamentali», ma anche delle forme strutturali definite come «embrionali».
Per l'individualismo metodologico, quella logica isolabile che può essere rappresentata dal caso particolare, esiste indipendentemente dal suo grado di determinazione nell'insieme; di conseguenza, questa logica isolabile è ancora più valida per una «forma di nicchia», di quanto non lo sia per la forma sociale globale e, a partire da un punto e attraverso una zona delimitata, si estende alla totalità, pur rimanendo sempre identica a sé stessa. Al contrario, per l'approccio dialettico alla totalità, la logica di una forma di relazione «esiste» nella misura in cui essa è già determinata dalla totalità; il caso individuale deve derivare dalla logica di questo insieme e, di conseguenza, non fornisce - ora più che mai - alcun «modello», poiché la totalità ha la propria qualità, decisiva, e come tale essa è assai più - e qualcosa di diverso - della semplice somma delle sue parti. Di conseguenza - conclude Kurz - una parte o un momento che dovesse sembrare apparentemente identico o simile in delle situazioni storiche diverse, senza tener conto della qualità specifica della totalità, non può mai essere considerato secondo una logica identica a quella dell'elemento individuale. Ed è proprio quello che si ritrova nell'approccio genetico-storico dell'individualismo metodologico: le categorie vengono comprese sulla base dello svolgersi di un'azione isolata, ed in un modo strutturalmente e storicamente decontestualizzato, vale a dire, in maniera assolutamente erronea.
Puntando alla compatibilità logica con la definizione weberiana, quando si tratta di riconoscere dei criteri precedenti all'avvento del capitalismo, che permettano di valutare l'esistenza di un «settore capitalista» («Marx e Weber individuano, a partire dai loro criteri convergenti, lo stesso tipo di settore economico precedente all'avvento del capitalismo moderno»), Rodinson ha il merito di aver dimostrato, senza rendersene conto, quanto la problematica del Marx essoterico delle «forme antidiluviane» non sia altro che l'espressione della concezione borghese ereditata dall'Illuminismo, in cui viene affermato lo sviluppo storico che avviene nella modalità unitaria di un'identica logica storica immanente a tutta la storia umana.
Una posizione che afferma quindi, consciamente o inconsciamente, la trans-storicità del capitalismo, e che fa risalire le sue premesse fino alle primissime società umane [*11]. Secondo Rodinson, si tratterà di vedere se «i mercanti si conformano bene ai criteri weberiani dell'attività capitalistica. Se approfittano di qualsiasi opportunità di profitto e se calcolano le loro spese, le loro entrate ed i loro benefici in termini monetari» [*12]. «È su questi criteri che qui verrà valutata l'esistenza di un tale settore "capitalista" nel mondo musulmano». E la sua conclusione, a partire da dei presupposti così problematici, sarà categorica, «a prima vista, bisogna sottolineare che nel mondo musulmano medievale troviamo delle forme [antidiluviane] analoghe a quelle del capitale» [*13], ovunque ci sia «un'atmosfera assolutamente conforme ai criteri weberiani dell'economia capitalista» [*14].
Perciò, quando si tratterà di studiare la pseudo-forma antidiluviana del «capitale di mercato», per la società musulmana del VII secolo, Rodinson, senza avere alcun timore della retroproiezione delle categorie capitaliste su dei rapporti sociali non economici, parlerà di una vera e propria «economia "disincastrata", per riprendere tutt'al più la terminologia di Karl Polanyi». Rodinson conosce male Polanyi, poiché da un lato evoca l'esistenza di un'economia «che non è per niente incastrata in un contesto non economico come il clan» [*17], mentre poche righe più avanti riconosce che «i beduini dovevano sottomettersi in una qualche misura ai sistemi di equivalenza fissa imposti dagli Stati» (cosa che Polanyi nella sua tipologia definisce come «amministrazione del commercio», e che ai suoi occhi è esattamente il contrario di una «economia disincastrata»). Si trattava quindi di una «struttura economica», e perciò concludeva che gli autori «sono giustificati quando parlano di "capitalismo"». Insomma, nella dimostrazione di Rodinson. la confusione fra il commercio ed il capitalismo, giustamente criticata da Ellen Meisksins Wood, è completa. In questa anacronistica visione weberiana segnata dall'individualismo metodologico, il mercante che realizza profitto per mezzo dell'alienazione, trasferendo da un punto A ad un punto B un bene che verrà alienato, è di già un capitalista. Eppure «il principio commerciale dominante non era il plusvalore estratto dalla produzione, ma piuttosto il profitto tratto dall'alienazione, vale a dire, il principio che consiste nel comprare a buon mercato e rivendere a caro prezzo» [*18].
Dobbiamo quindi parlare di commercio non capitalista e distinguerlo radicalmente da ciò che appartiene alla sfera della circolazione delle merci nella formazione sociale capitalistica. Qui, Rodinson cade nella caratteristica trappola in cui cade tutta la storiografia borghese e marxista tradizionale che «presenta il capitalismo come il risultato più o meno automatico di pratiche commerciali antiche quanto la storia, o perfino come il prolungamento di un'inclinazione naturale che ha l'uomo per il baratto, per il pagamento in natura e per lo scambio, tanto per parafrasare Adam Smith» [*19]. Mentre Le Goff è critico, riguardo l'Occidente medievale, dell'esistenza di un pensiero economico scolastico e dell'esistenza di «trattati economici» medievali, Rodinson non esita a vestire i panni dell'anacronismo storico parlando di «trattati puramente economici dell'Islam medievale» [*20].
Per quanto riguarda l'altra «forma antidiluviana» del capitale, il capitale finanziario, Rodinson si pone la domanda giusta quando riconosce che «qui si pone un problema sempre più importante. Prima della formazione socio-economica capitalista, ogni prestito ad interesse e qualsiasi commercio (nel senso più ampio, cioè qualsiasi scambio di beni) poteva essere considerato come costitutivo per natura di un "settore capitalistico"» [*21]. Ma per poter rispondere rapidamente in maniera affermativa, assimilando erroneamente l'usura protocapitalista del periodo medievale o antico (l'usura, che non ha niente in comune con il capitalismo) al capitale portatore di interesse che come tale esiste solo nella formazione sociale capitalista. Quest'ultimo capitale portatore di interesse, si trova collegato al contesto-forma inscritto nella totalità sociale capitalista costituita dal principio di socializzazione per mezzo del lavoro astratto, e quindi viene così riferito in maniera soggiacente al carattere singolare della forma di ricchezza astratta (e storicamente specifica che è la società capitalista) che viene presupposta dal capitale portatore di interesse, e della quale quest'ultimo è un'emanazione. In realtà, il capitalismo non si accontenta affatto solamente del divenire-merce della ricchezza sensibile-materiale, o della forza lavoro, ma vuole l'estensione dell'universo della merce anche al capitale che si trova sotto forma di denaro, quando questo denaro si trasforma in una merce negoziabile: «il capitale in quanto tale diviene una merce» [*22].
A differenza dell'usura medievale o antica - che non rappresenta una derivazione da qualcosa di soggiacente che storicamente non esiste ancora - nel sistema capitalista di credito che emerge nel XVII-XVIII secolo, il prestito, l'interesse e le azioni rappresentano la ricchezza astratta capitalista (del valore) [*23]. Questo capitale portatore di interesse si distingue dal «capitale funzionale» che controlla i processi reali di produzione industriale. Si tratta di un capitale in denaro prestato alle imprese, allo Stato o perfino alle famiglie, che in cambio devono pagare degli interessi (prezzo del credito) quando rimborsano la somma prestata. Si tratta di una forma di capitale derivato, che sembra far soldi in maniera occulta senza passare per il processo di produzione reale, ma questa forma di capitale portatore di interesse va pertanto mostrata e spiegata, come ha fatto Marx a partire dal concetto stesso di capitale, vale a dire nella sua relazione reale e interiore con il «capitale funzionale». Il capitale portatore di interesse viene prestato sotto diverse forme al «capitale funzionale» delle imprese affinché esse possano trasformare la forza lavoro in valorizzazione e l'interesse «non è nient'altro che un'etichetta, una voce particolare per quella che è una parte del profitto che il capitalista attivo deve pagare al proprietario di capitale, anziché metterlo di tasca propria» [*24]. «Una frazione del profitto, l'interesse» [*25]. Sotto forma di interesse, «il denaro riflette soltanto ciò che è stato speso come capitale funzionale» [*26]. Anche se la connessione del credito con il processo reale di valorizzazione può rompersi. La frattura con le società precapitaliste ha fatto emergere una nuova forma di ricchezza sociale, sia per il contenuto che al livello della sua forma. L'usura antica e medievale non è quindi per niente una «attività economica di tipo moderno», come afferma Rodinson, in altre parole è una delle forme antidiluviane del capitale, e in questo caso del «capitale finanziario».
- Clément Homs - Pubblicato nella primavera 2016 -
NOTE;
[*1] - Robert Kurz, « Die Substanz des Kapitals. Abstrakte Arbeit als gesellschaftliche Realmetaphysik und die absolute innere Schranke der Verwertung. Erster Teil », Exit!, n°1, Horlemann, 2004 [ da me tradotto in http://francosenia.blogspot.com/2015/12/assoluto-e-relativo.html ]
[*2] - Karl Marx, Grundrisse.
[*3] - ivi
[*4] - Michel Austin e Pierre Vidal-Naquet, "Economia e società nella Grecia antica", Bollati Boringhieri
[*5] - Prefazione di Jacques Le Goff, al livro di Bartolomé Clavero, "La grâce du don. Anthropologie catholique de l’économie moderne", Albin Michel, 1996. Su tale questione si vede anche J. Le Goff, "Lo sterco del diavolo. Il denaro nel Medioevo", LaTerza; e Robert Kurz, "Geld ohne Wert. Grundrisse zu einer Transformation der Kritik der politischen Ökonomie", Horlemann, 2012.
[*6] - Emerge un nuovo continente teorico-analitico sconosciuto, che qui tralasceremo: come fare a comprendere in maniera storicamente adeguata quel che ci appare (agli ideologhi moderni, più precisamente) come una «merce», come «lavoro» e come «denaro» nel neolitico, nell'antichità e nel medioevo, e che presuppongono già il concetto di valore? Per tutte queste questioni rimandiamo sempre a Robert Kurz, "Gheld ohne Wert", op.cit., ma anche a Marshall Salins, "Culture and Practical Reason". Chicago : University of Chicago Press, 1976; e Philippe Descola, "Oltre natura e cultura", Seid.
[*7] - «Per facilitare la discussione, propongo di chiamare "capitalistico" quello che è l'insieme del settore coperto dal capitale di mercato e dal capitale finanziario in queste società precapitaliste».
[*8] - In Max Weber, l'attività viene qualificata capitalista, quando si tratta di un'attività «che si aspetta un profitto dall'utilizzo di tutte le circostanze favorevoli ad un cambiamento, vale a dire, che si basa su delle occasioni di profitto (formalmente) pacifico ». Ciò che Weber non vede, è che l'analisi dello scambio così come esiste nella società capitalista, «non attiene affatto ad un prodotto cui capita di essere scambiato, senza tener conto della società in cui viene prodotto; non riguarda la merce al di fuori del suo contesto sociale, o come può esistere in maniera contingente in numerose società» (Moishe Postone, "Tempo, lavoro e dominio sociale"). L'errore centrale di Max Weber è quello di non vedere che la semplice esistenza dello scambio dal quale può essere un guadagno attraverso un calcolo (quel che Marx comprende ancora come «forma antidiluviana» quando parla di capitale mercantile in una società non capitalista), non è confrontabile con lo scambio di merci nella totalità sociale capitalista: questa situazione descritta da Weber, non ha niente «del capitalismo». Ad essere interessante in Weber è il fatto che egli illustra perfettamente il lato oscuro, o il rovescio, della retroproiezione delle categorie moderne su tutta la storia umana: la sua definizione di ciò che costituisce un «comportamento capitalista» non è solamente una proiezione del presente sul passato, ma è anche una proiezione del passato sul presente, quella che io chiamerei una retroproiezione in feedback. Dopo aver naturalizzato ed ontologizzato il contesto formale muto delle forme di base capitalistiche che vengono retroproiettate sulla Cina, l'India, Babilonia, l'Egitto ed il Mediterraneo antico, egli ritaglia nel passato il mattone elementare ontologizzato in quelle società passate che crede di riconoscere in maniera anacronistica come rivelatore di un «comportamento capitalistico», per poter poi costruire, a partire dall'aggregazione di questi mattoni a formare una totalità, i concetti di «nichtrationalen Kapitalismus» (per le società passate) e di forma razionale del capitalismo per le società contemporanee. La costruzione concettuale di Weber illustra l'economia circolare delle retroproiezioni e delle proiezioni in feedback, che finisce per definire il pensiero economico borghese come un pensiero eminentemente autoreferenziale in quanto prigioniero della gabbia d'acciaio della «forma di pensiero oggettivato» generato nel rapporto sociale capitalistico. E se la distinzione fondamentale fra commercio e capitalismo, stabilito da Ellen Meiskins Wood, ha anche questo merito in rapporto a Weber (fa, quindi, di Weber, come di Braudel, due tipici esempi del «modello della commercializzazione»), ciò avviene senza che la sua tesi sull'origine agraria del capitalismo, così come viene colta attraverso dei presupposti problematici del «marxismo politico», ci appaia pertinente. Ma, in maniera più generale, la definizione weberiana del capitalismo che si basa sull'individualismo metodologico, e quindi centrato sui processi di circolazione e sull'attività razionale dell'agente economico, si inscrive come contenuto della forma cosciente feticizzata borghese, aderendo alla fine alla formulazione neoclassica di fine secolo di questa forma di pensiero. Nel seguente passaggio, citato positivamente da Rodinson, si riconosce la posizione naturalizzante e trans-storica di Max Weber, che logicamente è quella dell'ideologia borghese del progresso e dell'Illuminismo: «In questo senso, il capitalismo e le imprese capitaliste, e perfino con una considerevole razionalizzazione del calcolo capitalistico, sono esistiti in tutti i paesi civilizzati del mondo..., in Cina, nell'India, in Babilonia, in Egitto, nell'antichità mediterranea e nel Medioevo così come nei tempo moderni».
[*10] - Robert Kurz, "3: Der Begriff der ‘‘Nischenform’’ und der methodologische Individualismus", in "Geld ohne Wert. Grundrisse zu einer Transformation der Kritik der politischen Ökonomie", Horlemann, 2012, pp. 57-67.
[*11] - La storiografia apologetica della nascita del capitalismo è perciò, come ha dimostrato Ellen Meisksins Wood, una «storiografia della rimozione degli ostacoli» la quale permette di comprendere come l'homo capitalisticus sia sempre in agguato da qualche parte nell'ombra, fin dalla notte dei tempi, e che finirà per riuscire a superare coraggiosamente le porte del paradiso del migliore dei mondi, e ad imporsi. In tal senso, questa storiografia del «lasciar fare, lasciar passare» oltre gli ostacoli, non è altro che un espediente narrativo per aprire la strada alle affermazioni storiche del discorso neoliberista, che si è sempre richiamato al «far saltare le serrature» per meglio lasciar fiorire un homo oeconomicus presunto come naturale.
[*12] - Maxime Rodinson - Islam e capitalismo.
[*13] - ivi
[*14] - ivi
[*15] - ivi
[*16] - ivi. Ai suoi occhi, questo sarebbe piuttosto l'incontro fra le forme antidiluviane di questo «settore capitalistico» ed il «fattore esogeno», che darà origine alla nascita del capitalismo nel «Medio Oriente».
[*17] - Maxime Rodinson - Islam e capitalismo.
[*18] - Ellen Meiksins Wood - The Origin of Capitalism. Monthly Review Press, 1999.
[*19] - ivi
[*20] - Maxime Rodinson - Islam e capitalismo. È noto che il riconoscimento di un testo, considerato come rivelante «trattato economico», nell'antichità greca, ha suscitato tutto un dibattito a partire dai giudiziosi avvertimenti di Moses Finley. Su questo si veda: "Sull'invenzione greca della parola "economia" in Senofonte- Critica di un inganno etimologico moderno", di Clément Homs : http://francosenia.blogspot.com/2016/09/definizioni-e-significato.html
[*21] - Maxime Rodinson - Islam e capitalismo.
[*22] - Karl Marx, Il Capitale, Libro III.
[*23] - «Infine, sia ben chiaro che il capitale-denaro non può diventare merce se non sulla base della produzione generalizzata della ricchezza astratta, sottolineano Trenkle e Lohoff, e per insistere sulla differenza che l'oppone alle merci circolanti sul mercato dei beni e del lavoro, i membri di questa classe di merci in seguito verrano qualificati come "merci derivate", o più precisamente come "merci di 2° ordine"», in: Norbert Trenkle & Ernst Lohoff, La Grande dévalorisation. Pourquoi la spéculation et la dette de l’État ne sont pas les causes de la crise, Post-éditions, 2014, pp. 136-137.
fonte: Critique de la valeur-dissociation. Repenser une théorie critique du capitalisme
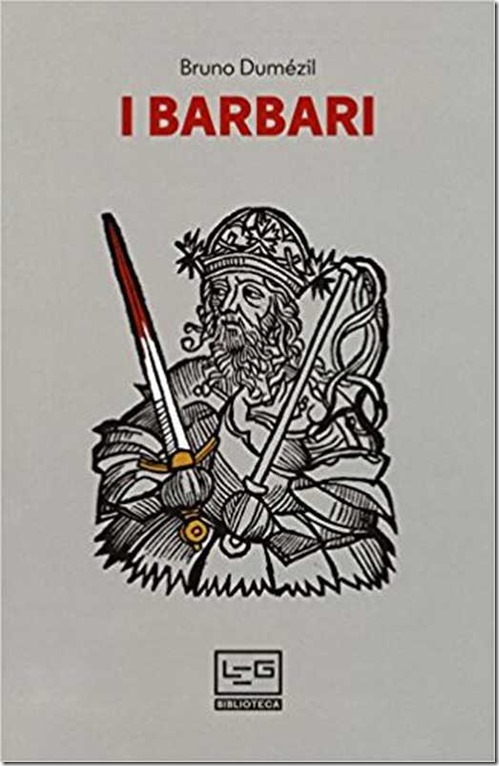








 Buoni rapporti con i cavalli [Chorošee otnošenie k lošadjam]
Buoni rapporti con i cavalli [Chorošee otnošenie k lošadjam]