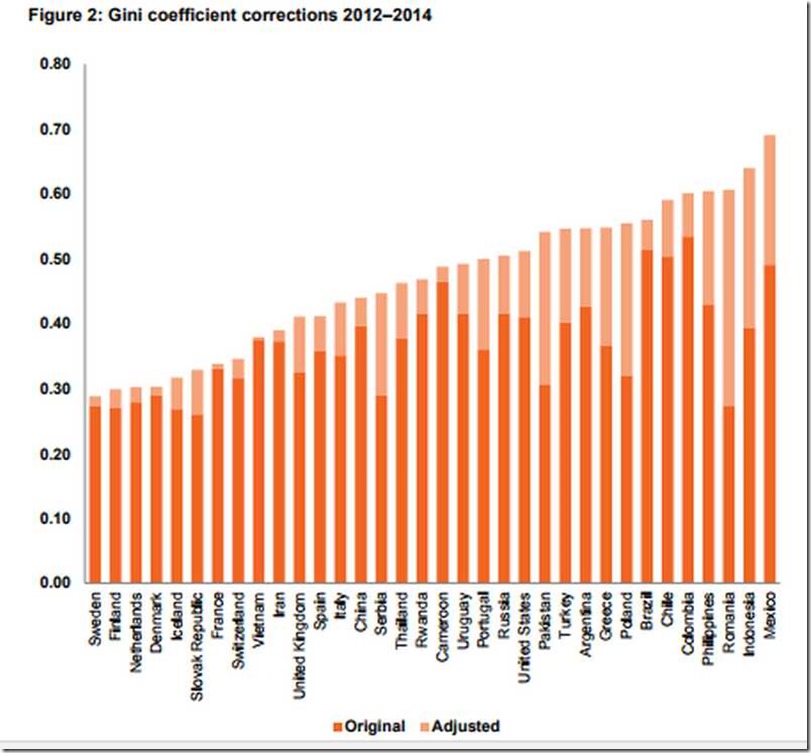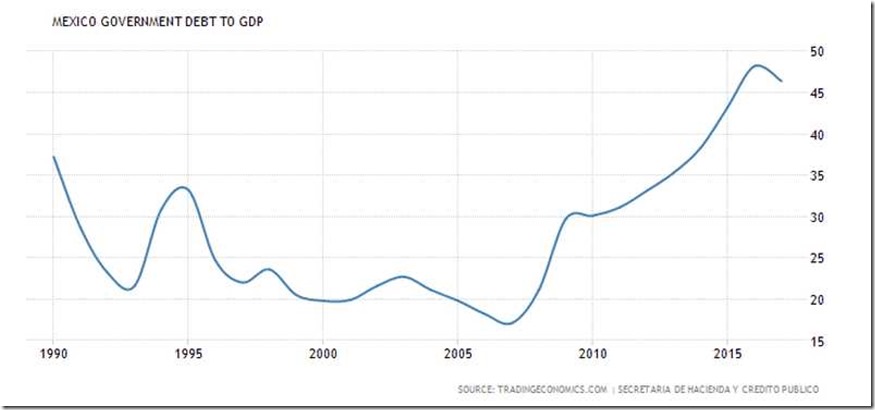La funzione degli individui nel capitalismo in crisi
- Brevi riflessioni a partire dalla letteratura di Stephen King -
di Joelton Nascimento
Nel racconto lungo di Stephen King, "La Nebbia" (1985), tutto ha inizio con una violenta tempesta. Poco dopo questa tempesta, una strana nebbia si impadronisce di una piccola città nell'entroterra del Maine, scenario preferito delle storie del Re. Un padre e suo figlio si recano in un supermercato, mentre la madre/moglie resta a casa. Padre e figlio, così come gli altri clienti del supermercato, rimangono sorpresi dall'improvvisa apparizione di terribili creature - metà insetti, metà mostri - che a quanto pare provengono da un esperimento militare sbagliato che ha avuto luogo in una base vicina. Decine di persone che rimangono bloccate in un supermercato stipato di merci e circondate da orrende creature assetate di sangue umano: è questo lo scenario in cui si svolge la trama di "The Mist", che nel 2007 diventa un film per la regia di Frank Darabont.
La storia può esser letta come un'allegoria del momento di crisi strutturale del capitalismo che stiamo vivendo [*1]. Persino in un mondo come il nostro, pieno zeppo di merci, anche così, siamo rimasti stupiti dalla mostruosa sorpresa dovuta al fatto che questo mondo non è esattamente quello che pensavamo che fosse. Abbiamo come la sensazione che degli esperimenti segreti, condotti da coloro che hanno il dovere di proteggerci e vigilare sulla normalità del nostro mondo, siano andati a finire male e che ora esistono dei mostri liberi di divorare le nostre "vite" o, meno drammaticamente, di divorare le nostre "economie", che fino ad un momento prima erano normali e relativamente sane.
È questo l'aspetto che hanno le cose, nel senso comune.
Fin qui tutto bene! Richiamo l'attenzione del lettore sul fatto che, quanto maggiore è la crisi, tanto maggiori sono le sue ripercussioni. Una crisi strutturale profonda può generare ansietà e, al limite, il panico. In una situazione di panico, siamo portati a fare cose che in generale non faremmo. Per di più, diamo ascolto a dei discorsi a quali, in altre situazioni, non concederemmo nessuna attenzione.
È questo quel che accade nel supermercato fittizio del racconto di King allorché, da un momento all'altro, molti cominciano a dar retta al discorso religioso fondamentalista della signora Carmody, una bigotta fino a quel momento inoffensiva per la comunità. Lei se ne viene fuori e comincia a dare una spiegazione bell'e pronta per spiegare come mai siano apparse queste creature, riuscendo a convincere tutti che la cosa fa parte di un piano divino di purificazione dei tanti peccati degli esseri umani, che devono essere redenti dai loro errori davanti a Dio ed ai suoi comandamenti, e così via.
Abbiamo visto come negli ultimi anni la destra politica, e anche l'estrema destra, si siano sempre più alzati in piedi per dire, come la signora Carmody, qualcosa che può essere riassunto come un «io so che cosa sta succedendo e so anche quello che dobbiamo fare per uscire da questa situazione». Ha fatto un discorso che, in alcuni luoghi, come in Ucraina ed in Ungheria, ha sedotto le classi medie, insegnando loro a marciare per il "valori tradizionali", Dio e famiglia, come se questo fosse un modo per affrontare la valanga della crisi economica del liberismo senza freni. [*2]
Non c'è alcun dubbio che il discorso reazionario sia incoerente. Porre valori come la "famiglia" o come "Dio" per far fronte alla complessità dell'economia capitalistica presumibilmente globalizzata, e alle sue paralisi e contraddizioni, alle sue crisi e alle sue distruzioni, è in po' come usare un fucile per fare il gelato, vale a dire, un puro disastro, qualcosa che è evidente di per sé.
Ma perché questo discorso assurdo riesce ancora a trascinare così tante persone? Per le stesse ragioni per cui la signora Carmody convince alcuni clienti del supermercato di Stephen King a fare dei sacrifici umani per placare l'ira divina: viviamo in una situazione perturbante in cui tutto appare essere fuori luogo, le persone sono scioccate, stordite, traumatizzate, sconvolte. In circostanze normali, nessuno presterebbe molta attenzione alla signora Carmody, ma in quel momento di crisi, lei sembra essere l'unica che continui a mantenere della convinzioni! Per cui allora la sua retorica «in fondo, non sembra poi così fuori luogo». Quelle che sono delle circostanze di emergenza richiedono certamente dei punti di vista e delle misure estreme, giusto? Ok. Poco a poco, ecco che la signora Carmody comincia a formare una piccola sezione di fondamentalisti.
Bisogna leggere il racconto, o vedere il film di Darabont, per scoprire cosa succede con la signora Carmody ne "La Nebbia". Ma l'Ucraina ha dimostrato che la destra non offre alcuna via d'uscita. L'unico motivo per cui è riuscita ad avere un discorso seducente, è stata l'audacia e la prontezza di proporsi come risposta ai problemi del momento. Quell'audacia che assai spesso manca a sinistra, la quale non di rado sposa in maniera passiva il compito di salvare il capitalismo, e dimentica che è possibile agire per la costruzione di un'alternativa sociale e strutturale a quello che è il "capitalismo del disastro" (Klein). Anche se non c'è nessuno veramente onesto e intelligente che abbia nella manica "l'uscita" dalla crisi strutturale del capitalismo che stiamo vivendo, tuttavia possiamo già dire NO! alla signora Carmody. [*3]
A partire dal momento in cui il Brasile è entrato al centro del turbinio della crisi economica, abbiamo anche visto nascere, in maniera ancora più accentuata a partire dal giugno del 2013, diversi nuovi "odi politici", dovuti principalmente all'incomprensione della natura, dalla totalità e dalla profondità della crisi strutturale in corso del capitalismo.
C'è un altro romanzo assai più vecchio di Stephen King che ci può aiutare a pensare questo problema che riguarda gli affetti politici in tempi di crisi, ed è "La Zona Morta", del 1979, il quale ha avuto anch'esso una versione cinematografica diretta da David Cronemberg nel 1983. Un insegnate di scuola superiore, John Smith, resta vittima di un grave incidente automobilistico e rimane per più di quattro anni in coma; al risveglio, oltre a dei lievi danni neurologici, acquisisce il misterioso dono di predire il futuro toccando le persone. Quando stringe la mano di un cinico candidato alle elezioni, Greg Stillson, Smith prevede il suo futuro come presidente degli Stati Uniti, e di come egli farà precipitare il mondo in una guerra nucleare di proporzioni bibliche, causando un'apocalisse globale. L'insegnate vive perciò il dilemma fra il dover agire in maniera drastica per evitare la catastrofe, e lo stare semplicemente a guardare aspettando gli eventi senza interferire con il destino. Lascio al lettore il compito di scoprire da solo quale sarà la decisione di Smith, sia nel romanzo di King che nel film di Cronenberg - in entrambe le versioni il finale è abbastanza simile. Qui richiamo l'attenzione del lettore sul fatto che in questa storia, l'apocalisse è vista come un futuro certo che viene considerato come se fosse la conseguenza dell'azione di un singolo uomo, e non di tutta un'epoca. Sembra che la tendenza all'individualismo abbia ripercussioni non solo sulla nostra concezione della vita nella società, ma anche sulla concezione della morte nella società.
Smith è convinto che Stillson sia qualcosa come un "anticristo" in grado di piombare, in gran misura per mezzo delle sue proprie azioni, tutta una società nelle tenebre del caos. Nei momenti di crisi, è cosa più che normale cercare quanto prima una narrazione confortevole nella quale sistemarci. A quanto pare, sembra che, come Smith, abbiamo bisogno di credere che le cause e gli effetti dei più grandi problemi che viviamo si inquadrino nel miglior modo possibile nei comportamenti soggettivi degli individui "chiave" della storia. [*4]
Questa convinzione deriva anche dal modo in cui intendiamo la politica nella modernità. La politica viene solamente praticata, per la maggior parte delle volte, come la presa di coscienza degli antagonismi e dei consensi in atto, in una data situazione. Pertanto, chi fa che cosa, con chi, perché, sotto quali bandiere e con quali risorse, tutte queste cose sono gli enigmi ai quali ogni e qualsiasi agente politico deve rispondere se vuole agire politicamente, quando ciò è nel suo interesse. È da questo che proviene la nostra fissazione sui tratti caratteriali visti come i tratti che definiscono il nostro destino: coraggio, amore, perseveranza, ma anche, cinismo, crudeltà e freddezza; chi sono gli amici e quali sono i nemici, e così via. Per cui i nostri destini sarebbero legati non ad una qualche astrazione, bensì piuttosto ai tratti concreti del carattere degli individui che, per opportunità del destino, si trovano in dei punti "chiave" dello sviluppo della storia. Il fatto di aver messo in moto dei processi storico-sociali che hanno luogo a prescindere dal nostro controllo cosciente, di solito non fa parte del modo in cui concepiamo generalmente il mondo in cui viviamo. [*5]
Questa fissazione per i personaggi "chiave" della storia appare in maniera chiara in altre opere di Stephen King. Nel romanzo "22/11/'63" (2011), ad esempio, un altro insegnante, Jacob Epping, trova un modo per realizzare dei viaggi nel passato, più precisamente, in un determinato punto del passato, nel 1958. A partire da questo, pertanto, si rende conto che può modificare profondamente la storia, evitando l'omicidio di John Keneddy il 22 novembre del 1963. Epping è del tutto convinto che salvare la vita a Kennedy cambierà - in meglio - tutta un'epoca storica, ignorando il fatto che i profondi shock vissuti globalmente negli anni '60 e '70 sono andati molto al di là di quello che un politico avrebbe potuto fare - anche se stiamo parlando del presidente del paese più influente del mondo. Coloro che ritengono che i nostri problemi siano "politici" nel senso detto precedentemente, vale a dire, che sono il risultato dell'azione concertata ed orchestrata dei malvagi onnipotenti che controllano il sistema capitalista globale, e che devono essere combattuti da quelli che subiscono le conseguenze nefaste delle azioni di questi cattivi, non rimane altro che aggrapparsi a questo sentimento che muove i personaggi di Stephen King, come John Smith, Jacob Epping - ed in una qualche misura, anche la signora Carmody - per i quali alcune figure "chiavi" sono tutto ciò che abbiamo bisogno di estirpare per migliorare la situazione del mondo. A mio avviso, questa è una fonte inesauribile di odio politicamente orientato, piuttosto che una misera fonte per la vera emancipazione sociale.
Siamo parte dei principali problemi che invece pensiamo di trovare nei "cattivi" del nostro tempo. In generale, tendiamo ad acquistare l'idea secondo lo quale noi facciamo parte di quel 99% di innocenti, contro l'1% dei colpevoli, ma dall'altro lato, ad un certo livello, sappiamo che lo cose non stanno esattamente in questo modo: una catastrofe che ha le dimensioni di quella che si profila all'orizzonte dei nostri giorni non è opera di una minoranza malvagia, non importa quanto possiamo considerarla potente!
Come afferma Anselm Jappe, «in una società che non solo si basa sulla produzione delle merci, ma nella quale è il lavoro che le produce ad essere la principale relazione sociale, era inevitabile che, con il tempo, il narcisismo diventasse il tratto psichico più tipico» (2012, p.103).
E questo cosa comporta? «Il narcisista può apparire come se fosse una persona "normale", ma in realtà egli non ha mai abbandonato la sua originale fusione con il mondo circostante, e fa di tutto per mantenere l'illusione di onnipotenza che da questo gli proviene» (2012, p.128). E di conseguenza, continua, «Non per caso, troviamo in tutto questo la medesima perdita di realtà, e la medesima assenza del mondo - di un mondo riconosciuto nella sua autonomia fondamentale - che caratterizza il feticismo della merce» (2012, p.128-129). Quella che esiste, è una dimensione del mondo che può riuscire a sfuggire interamente alla libera volontà, propria o di altri, e che pertanto non è una creazione ideologica di un gruppo o di una classe qualsiasi, ma è il risultato di una socializzazione narcisistica che produce soggettività narcisistiche, anziché essere prodotta da esse, ed è qualcosa che difficilmente riusciamo a concepire.
I meccanismi impersonali della produzione e dello scambio sociale costituiscono fondamentalmente il capitalismo, a differenza di quanto avveniva in tutte le altre epoche della storia umana. [*6]
Il denaro, la forma della merce ed il lavoro salariato sono assai più che gli artifici con cui una classe inganna un'altra. Anche se il marxismo del movimento operaio possiede una forte retorica morale contro lo sfruttamento del lavoro, il capitalismo è il primo sistema ad estrarre vantaggi dall'attività umana che non dipende da relazioni personali dirette e, di conseguenza, esso è il sistema che meno può essere descritto e criticato come moralmente condannabile.
Tuttavia, non è questa la ragione della diffusa depressione sociale generalizzata, o dell'accettazione senza restrizioni della colpa e dei castighi che deriverebbero da tale colpa. Sì, siamo tutti partecipi, ed è proprio per questo che possiamo realizzare una trasformazione qualitativa nella nostra situazione sociale ed ambientale. Per farlo, dobbiamo abbandonare una volta per tutte la convinzione secondo cui abbiamo solo bisogno di sconfiggere, di annullare, o addirittura sterminare un determinato gruppo di persone, per poter risolvere i nostri grandi problemi: non c'è nulla che possa provenire da una simile convinzione, oltre l'odio che l'alimenta.
- Joelton Nascimento - Pubblicato su Baierle & Co. il 9 luglio 2018 -
NOTE:
[*1] - Descriviamo qui la crisi strutturale come un'altra modalità della crisi socio-economica capitalista che eccede quelli che sono i limiti della mera crisi ciclica. Attualmente, ci sono diverse letture della crisi vista nella chiave del suo carattere strutturale (cfr. MÉSZÁROS, 2009).
[*2] - Sembra che la situazione descritta negli anni '30 da Marcuse sia una costante nella storia del capitalismo: nei momenti critici, c'è sempre terreno fertile per una critica al liberalismo che viene fatta da destra (cfr. MARCUSE. 1997).
[*3] - È ovvio che esistono dei principi e delle premesse in grado di rendere chiara una ricostruzione della socializzazione che vada oltre il capitalismo: consiliarismo, autogestione, associativismo, (neo)comunismo; tuttavia, tutti questi principi non sono manuali d'istruzione nelle mani di individui e gruppi (soprattutto di quelli intelligenti e onesti) ma sono piuttosto dei punti di partenza per una difficile ricostruzione teorica e pratica di quello che deve essere un superamento a venire quasi completo. Non esistono mappe e riferimenti che ci possono guidare completamente in questo superamento, il quale, teoricamente e praticamente, rimane ancora da fare.
[*4] - Anche il marxismo tradizionale ha la sua narrazione confortevole. Secondo tale narrazione, la classe lavoratrice è l'unica forza capace di presiedere al superamento del capitalismo, per mezzo della sua volontà organizzata; ogni e qualsiasi tesi che sfugga seppur minimamente a questa narrazione viene subito considerata come appartenente al campo opposto, antagonista, "controrivoluzionaria”.
[*5] - Per una visione più dettagliata della questione della politica nel nostro tempo, cf. (JAPPE, 2013)
[*6] - Circa il passaggio dai feticci personali al feticcio della merce, cfr. (KURZ, 2014)
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
Anselm Jappe - Sobre a Balsa da Medusa - Ensaios Acerca da Decomposição do Capitalismo
____________ - Crédito à morte – a decomposição do capitalismo e suas críticas
Stephen King - La Zona Morta
____________ - La nebbia (in Scheletri)
____________ - 22/11/'63
Robert Kurz - Dinheiro sem valor - Linhas gerais para uma transformação da crítica da economia política.
Herbert Marcuse - O combate ao liberalismo na concepção totalitária de Estado. In Cultura e Sociedade. Volume I.
István Mészáros - A crise estrutural do capital.
fonte: Baierle & Co.

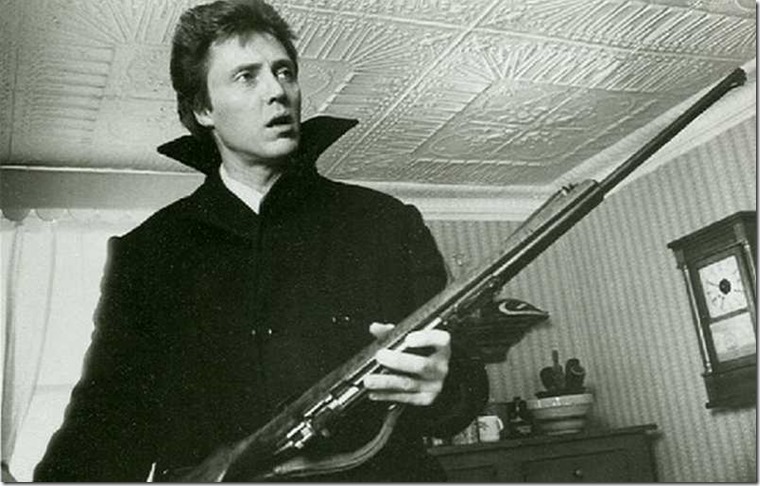









 Femminismo intersezionale
Femminismo intersezionale

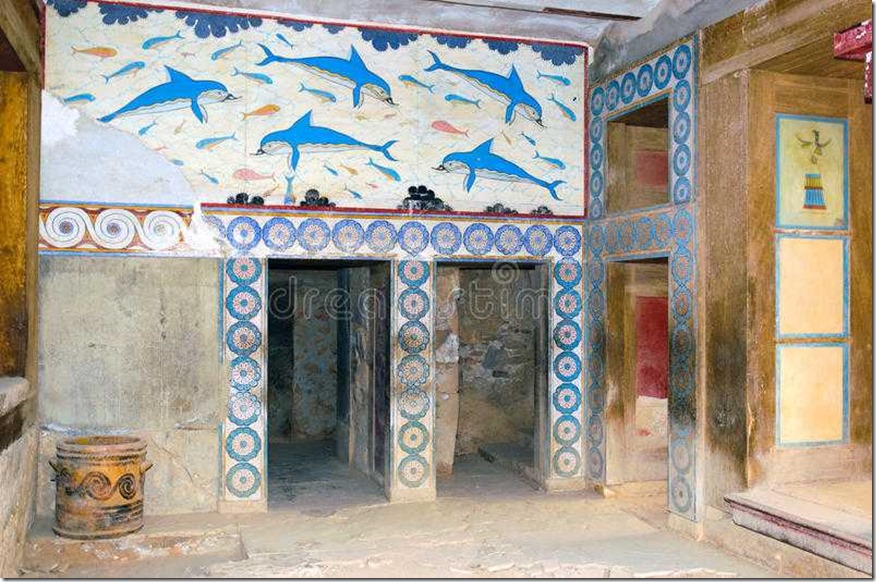

 In media, in Messico, nel messe di maggio, ogni quindici minuti è stato ucciso qualcuno, e questo ha messo il paese nelle condizioni di poter superate il record dello scorso anno, con 29.168 omicidi. Sono aumentati anche gli omicidi politici, con 130 politici, inclusi 48 candidati ad una carica che sono stati uccisi dall'inizio del ciclo elettorale di settembre, secondo Etellekt, agenzia di consulenza politica.
In media, in Messico, nel messe di maggio, ogni quindici minuti è stato ucciso qualcuno, e questo ha messo il paese nelle condizioni di poter superate il record dello scorso anno, con 29.168 omicidi. Sono aumentati anche gli omicidi politici, con 130 politici, inclusi 48 candidati ad una carica che sono stati uccisi dall'inizio del ciclo elettorale di settembre, secondo Etellekt, agenzia di consulenza politica.