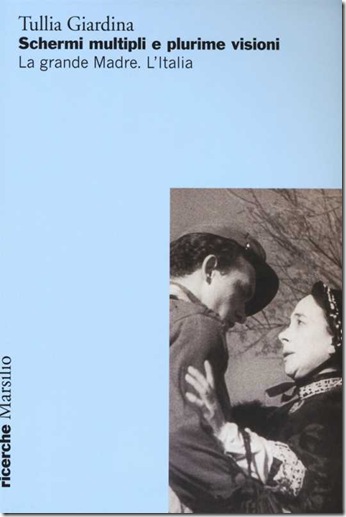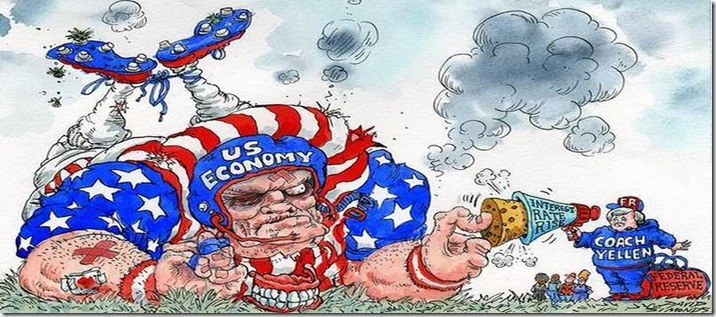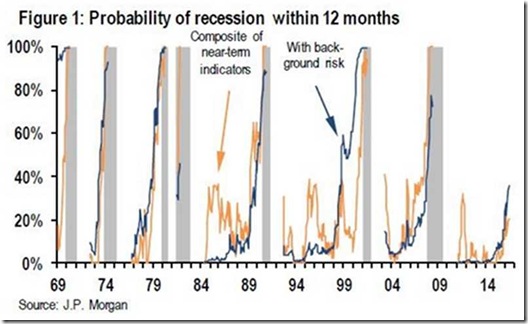Frutto di un'attenta ricerca di storia culturale, condotta su fonti d'archivio in parte inedite, il volume - realizzato grazie anche al contributo della Fondazione Cesare e Doris Zipelli - analizza l'importante ruolo svolto dal Cinema e dalla Televisione nel costruire e diffondere, attraverso film e sceneggiati di argomento storico, nel più ampio processo di Nation-building e State-formation otto-novecentesco, varie interpretazioni dei concetti di Madre-Patria e di identità nazionale. Filtrando la storia risorgimentale attraverso le suggestioni di alcuni dei maggiori romanzieri e poeti del canone letterario italiano, ma anche tedesco come nel caso di Schiller, si individuano alcuni sistemi simbolici e allegorici originali, funzionali sia all'elaborazione di una «estetica della politica» finalizzata alla nazionalizzazione delle masse nell'ottica crispina della «rivoluzione cinta dal diadema», sia alla decostruzione critica del percorso storico da cui era scaturita l'unificazione nazionale.
(dal risvolto di copertina di: Tullia Giardina, "Schermi multipli e plurime visioni. La grande Madre. L’Italia", Marsilio, pp. 278, euro 28)
L’amor di patria salvato da cinema e tivù
- I film di Blasetti e Martone e le ossessioni di Visconti: un saggio sulla Grande Madre Italia rivela come il Risorgimento, tra grande e piccolo schermo, abbia costruito la nostra identità -
di Roberto Coaloa
Marsilio ha pubblicato della studiosa del cinema Tullia Giardina il volume Schermi multipli e plurime visioni. La grande Madre. L’Italia (pp. 278, euro 28), esito felice di un’accurata ricerca di storia culturale condotta su fonti d’archivio. È pure l’occasione per riscoprire capolavori assoluti del cinema italiano, come 1860 di Alessandro Blasetti, film del 1934, che ha ispirato la copertina del bellissimo volume. Partendo dalle recenti riflessioni dello storico del Risorgimento Alberto Mario Banti, la studiosa analizza l’importante ruolo svolto dal cinema e dalla televisione nel costruire e diffondere la storia del Risorgimento, attraverso film e sceneggiati, nel più ampio processo di Nation-building e State-formation otto-novecentesco, e ripercorre le varie interpretazioni dei concetti di MadrePatria e d’identità nazionale, il carattere o i caratteri presunti del popolo italiano offerti dal mondo di celluloide.
Il tema risorgimentale corre attraverso tutta la storia novecentesca del cinema italiano, fino a lambire il primo quindicennio del XXI secolo. Nel suo esordio, infatti, avvenuto nel 1905 con il film La presa di Roma di Filoteo Albertini, costruisce un’immagine mitologica dello Stato. Dopo più di un secolo, nel 2010, un altro film, Noi credevamo di Mario Martone, incrina quel mito risorgimentale, frutto di una visione oleografica e pacificante del Risorgimento. Costruzione di una memoria condivisa, nel primo caso. Restituzione di una memoria divisa e lacerata, nel secondo. Fra questi due estremi cronologici, 1905-2010, più di cinquanta film che, nel presentare una narrativa per immagini della lunga e complessa storia ottocentesca del Belpaese, hanno finito per oscillare dalla semplificazione e dalla retorica celebrativa all’assunzione di paradigmi storiografici forti e polarizzanti, quali a esempio quello gramsciano, non adeguato a una lettura complessa della realtà del Mezzogiorno, prima e dopo l’Unità. In questo discorso è entrato prepotentemente il regista Luchino Visconti, che in due occasioni, con Senso e Il Gattopardo, ha riscritto la storia del Risorgimento. È interessante notare lo sforzo della studiosa Giardina: distinguere un angolo visuale per leggere la storia di quella complessa epoca. I film del suo canone sono ambientati nella Sicilia del 1860. Ciò che più colpisce è anche la storia di questa narrazione: al cinema, Garibaldi è il personaggio che più aleggia sullo schermo, anche quando è assente; in televisione, soprattutto dalla seconda metà degli anni Ottanta, in un clima di rinnovata attenzione alla figura e al pensiero di Garibaldi da parte di alcune forze politiche, quali il Partito socialista e il Partito repubblicano, l’Eroe dei due Mondi fu arruolato di peso per essere protagonista di un telefilm di Luigi Magni, in quattro puntate della durata di circa 100 minuti ciascuna.
Giardina, però, prima di arrivare a questo recupero di Garibaldi, nota la modernità di un racconto, mai retorico, offerto in alcuni fortunati momenti dal cinema italiano durante il fascismo. È il caso del ricordato 1860, dove il regista Blasetti pone attenzione alla frammentazione linguistica della Penisola e al ruolo delle varie parti popolari e ideologiche della spedizione dei Mille, lasciando in secondo piano l’Eroe. Gli altri film del Ventennio cercano di creare un’estetica della politica funzionale alla nazionalizzazione delle masse. Per avere Garibaldi si deve aspettare Rossellini, che grazie a una formidabile documentazione lo presentò, addirittura, in pantofole e camicia da notte, tormentato dalla gotta e dall’artrite reumatoide. Nel telefilm di Magni si nota poi lo stesso sguardo, mesto e amichevole, su Garibaldi, ripreso di spalle nel momento in cui l’Eroe si congeda da Re Vittorio Emanuele II e da Cavour senza stringere loro la mano, uscendo dalla scena nella consapevolezza di essere stato usato.
- Roberto Coaloa - 3 giugno 2016 -