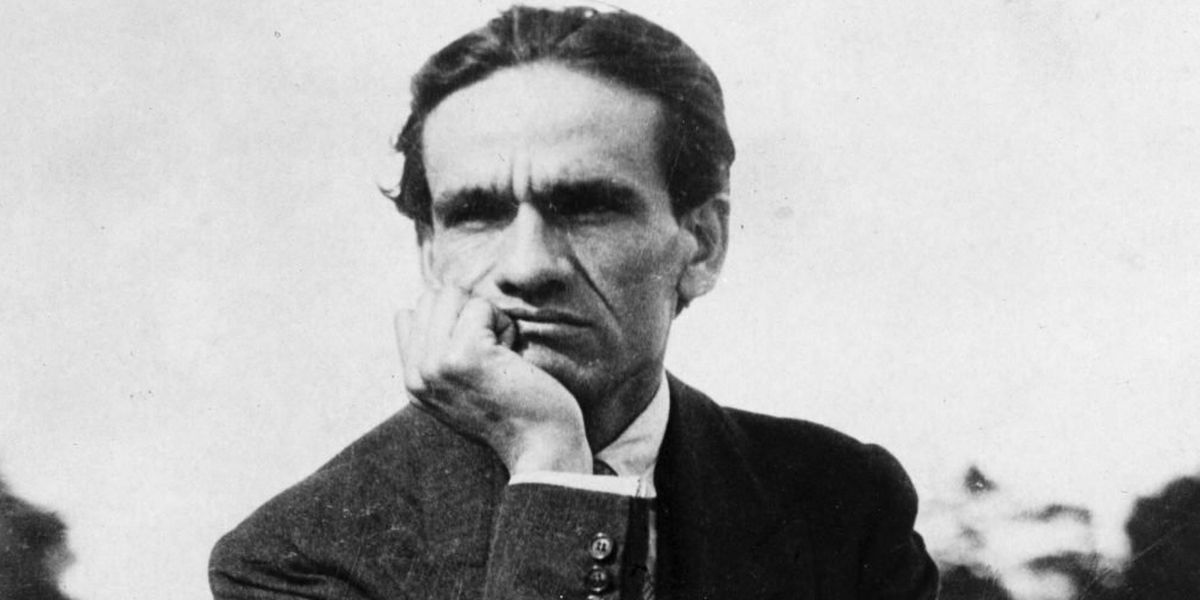Quali che siano le critiche che possono essere fatte a Michael Heinrich - il suo "circolazionismo", la sua cecità relativa alla teoria della crisi, il suo sostegno a Die Linke, ecc.; e rispetto a tutto questo si può fare riferimento a Kurz, Lohoff, Backhaus, Reichelt per quelli e per quello che ci interessa -, Heinrich sviluppa però una marxologia assai spesso antagonista rispetto al marxismo tradizionale, argomentando assai bene alcuni punti, come quelli che, per esempio, riguardano la questione ed il significato delle classi e della lotta di classe nella critica marxiana della maturità (la quale non ha niente a che vedere con le elucubrazioni del Manifesto del Partito comunista), viste, rispettivamente, come rapporto derivato dalle categorie di base capitalistiche, e come lotta immanente al capitalismo non necessariamente rivoluzionaria, come invece pretendono molti marxisti (insieme a tutta la teoria proletaria della rivoluzione), i quali immergono il loro soggetto - il Proletariato - nella metafisica del soggetto rivoluzionario. L'analisi di classe, senza la mediazione di una critica categoriale, diventa immediatamente - a causa del suo sociologismo - una delle forme dell'anticapitalismo tronco, ed insieme a questo solo un travestimento della ricca critica marxiana dell'economia politica della maturità (al quale, di per sé, non è a sua volta neanche esente da contraddizioni, cecità ed aporie). Nel testo che segue, vengono affrontati quelli che sono alcuni punti importanti, e almeno qui la cosa viene svolta a partire da una certa congruenza con le correnti critiche del valore e critiche della dissociazione-valore. Questo estratto, inedito, è stato tradotto in francese da un compagno, prendendolo dal libro di Michael Heinrich, "Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung". (dalla pagina facebook di Palim Psao)
Classe, lotta di classe e determinismo storico, di Michael Heinrich
Estratto dal libro di Michael Heinrich, "Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung" [Critica dell'economia politica. Un'introduzione], capitolo 10.3. Il capitolo 10, di cui questo estratto costituisce l'ultima parte, ha come titolo "Il Feticismo delle relazioni borghesi".
Molte correnti del marxismo tradizionale hanno compreso l'analisi di Marx come se fosse innanzitutto un'analisi di classe e della lotta tra borghesia e proletariato. Oggi, per la maggior parte dei conservatori e dei liberali, i concetti di «classe», e in particolare quello di «lotta di classe», sono «ideologici»; cosa che non vuol dire altro che sono «non scientifici». Di norma, è soprattutto a sinistra che vengono utilizzati questi concetti. È importante ricordare, innanzitutto, che il «discorso di classe» non è in nessun caso specifico del contributo di Marx. Già prima di lui, gli storici borghesi parlavano di classi e di lotta di classe, e David Ricardo, il rappresentante più importante dell'economia politica classica, era arrivato addirittura a sottolineare che le tre grandi classi delle società capitaliste (capitalisti, proprietari terrieri, e lavoratori) avevano degli interessi fondamentalmente opposti. Nel Manifesto comunista (1848), i concetti di classe e di lotta di classe costituiscono il nodo centrale di quella che è l'argomentazione di Marx. [...] Ma in una lettera del 1852, scritta al suo amico Weydemeyer, Marx riassume ciò che egli identificava come la natura del suo contributo alla teoria delle classi, sottolineando come non abbia in alcun modo scoperto l'esistenza delle classi, o della loro lotta:
« Ora, per quel che mi riguarda, non è affatto a me che va attribuito il merito di avere scoperto l'esistenza delle classi nella società moderna, non più dell'esistenza della lotta che tali classi conducono. Gli storici borghesi avevano descritto molto prima di quanto facessi io l'evoluzione storica di questa lotta di classe, e degli economisti borghesi ne avevano tratteggiato l'anatomia economica. La mia originalità ha consistito nel: 1) dimostrare che l'esistenza delle classi è legata solo a determinate fasi storiche della sviluppo produttivo; 2) che la lotta di classe porta necessariamente alla dittatura del proletariato; 3) che questa stessa dittatura rappresenta a sua volta solo una transizione verso l'abolizione di tutte le classi e verso una società senza classi. » [*1].
Qui, il termine «dittatura» non designa affatto una forma autoritaria di dominio, ma solamente il dominio di una classe, indipendentemente da quale sia lo forma politica di tale dominio. I punti 1) e 2), hanno una forte connotazione determinista: nel loro contesto, la storia appare come se - animata dalla lotta di classe - fosse già orientata verso un fine determinato. Si tratta di una concezione che può essere ritrovata, per capirci, nel Manifesto comunista.
Se nel Capitale Marx parla ancora certamente di classi, lì non c'è alcun tentativo di un loro trattamento sistematico, e nemmeno un tentativo di darne una definizione. È solo alla fine del III Libro che Marx dà inizio ad un capitolo sulle classi, ed a quel punto, appena dopo poche frasi, il manoscritto si ferma. [*2] A partire dal fatto che ciò avvenga solo a quel punto, si può dedurre che un trattamento sistematico delle classi non costituisca affatto una condizione della descrizione del modo di produzione capitalistico, ma piuttosto un risultato di tutto questo.
Qui, non faremo alcuna speculazione su ciò che Marx avrebbe potuto scrivere dopo queste prime righe del III Libro. Quello che dobbiamo fare, è piuttosto individuare quello che si può dire riguardo le classi e la lotta di classe [...]. Al termine di classe sociale, vanno dati due significati differenti. In senso strutturale, le classi sociali sono determinate da quella che è la loro posizione nel processo sociale di produzione. A partire da questa posizione, ed in questa misura, una persona può appartenere ad una classe pur senza esserne chiaramente consapevole. Questo significa di classe, dev'essere distinto da quello delle classi comprese nel loro senso storico. In tal senso, si tratta di gruppi sociali che possono essere compresi nella misura in cui si distinguono dalle altre classi in una situazione storica determinata, ecco che allora i membri di queste classi hanno una «coscienza di classe». Nel Capitale, Marx utilizza il termine «classe» in senso quasi esclusivamente strutturale. Quindi, constata che alla base del rapporto capitalistico si trova un rapporto di classe: partendo dai possessori di denaro e dei mezzi di produzione, da una parte, e dei lavoratori «liberi» nel doppio senso di questa parola, mentre dall'altra, Marx designa come classe media, o anche piccola borghesia, dei gruppi che non sono né borghesi né proletari: innanzitutto, gli «indipendenti» come gli artigiani, i piccoli commercianti o i piccoli agricoltori. Le classi in senso strutturale non possono essere identificate con quelle che è la loro forma (Ausprägung) storica: non è necessariamente proprio del capitalista, fumare il sigaro ed avere un autista, così come non è necessariamente proprio dei lavoratori lasciarsi ridurre ad essere degli operai industriali che vivono nei quartieri operai. La scomparsa di questo genere di stereotipi non è una prova della fine delle classi, ma dimostra solo che c'è stata una modifica di quelle che sono le loro forme storiche (historischer Gestalt).
A partire da quelle che sono delle proprietà formali, come ad esempio l'esistenza di rapporti salariali, non è possibile determinare chi è che appartiene in senso strutturale a quale classe; pertanto, solamente dalla sua funzione in seno al processo di produzione. Più esattamente: la classe può essere colta solo a quel livello di «processo generale [Gesamtprozess] di produzione» a cui Marx arriva nel III Libro del Capitale, dove viene già presupposta l'unità tra processo di produzione e processo di circolazione. A questo livello diventa chiaro come il possesso, o meno, dei mezzi di produzione non sia determinante ai fini dell'appartenenza di classe. Formalmente, l'amministratore delegato di una società per azioni può essere un lavoratore salariato, ma in realtà egli svolge le funzioni di un capitalista, dispone del capitale (anche se questo non è di sua proprietà), organizza lo sfruttamento, e la sua «retribuzione» non viene determinata dal valore della sua forza lavoro, ma piuttosto dal profitto che è stato prodotto. Al contrario, ci sono numerosi lavoratori indipendenti da un punto di vista formale (che possono perfino possedere i propri modesti mezzi di produzione) che, come in passato, devono essere ancora considerati dei proletari, i quali di fatto vivono della vendita della loro forza lavoro, solo che eventualmente ciò può avvenire in condizioni ancora più sfavorevoli di quelle che avvengono in una relazione salariale formale. Certo, è vero che al giorno d'oggi le condizioni di vita (reddito, istruzione, anche i possibili progetti di vita) tra quelle che sono le classi strutturalmente definite della «borghesia» e del «proletariato» rimangono chiaramente distinguibili, ma la realtà relativa a quelle che sono delle vite diverse anche all'interno del «proletariato» stesso (a partire dal lavoro, dal reddito, dall'istruzione, così come a partire dai comportamenti di consumo e dall'uso che viene fatto del tempo libero). Il fatto che una situazione generale di classe si trasformi in una coscienza ed un'azione comune; il fatto che la classe determinata strutturalmente si trasformi in una classe storico-sociale è tutt'altro che scontato: può avvenire, ma anche no. Ma non c'è niente di automatico nel fatto che la rappresentazione di un superamento emancipatorio di quelli che sono i rapporti capitalistici appartenga al proletariato (determinato strutturalmente), o parti di esso, nel momento in cui è diventato una classe storica che ha sviluppato una coscienza di classe. Il proletariato che ha una coscienza di classe, non è automaticamente «rivoluzionario».
Nel processo di produzione capitalistica, la borghesia e il proletariato si confrontano direttamente, lo sfruttamento del proletariato rende innanzitutto possibile l'esistenza del capitale in quanto valore che si valorizza. Le condizioni concrete nelle quali ha luogo la valorizzazione del capitale vengono costantemente contrastate: il valore della forza lavoro deve soddisfare la riproduzione normale, ma ciò che serve per diventare «normale» dipende anche da quelle che sono le rivendicazioni che la classe dei lavoratori riesce ad imporre. Vengono perciò ad essere oggetto del conflitto, la durata del tempo di lavoro e le condizioni in cui si svolge il processo di produzione. In tal senso, ed in questa misura, con il rapporto capitalista, esiste sempre la lotta di classe, che si chiami o meno così. Ed è specialmente nella lotta di classe, che quelli che sono in lotta possono sviluppare una coscienza di classe, ma ciò può presentare degli effetti differenti secondo quelli che sono le circostanze storiche.
Le lotte di classe non assumono solamente la forma di scontri immediati tra borghesia e proletariato, ma possono anche estendersi allo Stato, in quanto le leggi stabiliscono o avversano quelle che sono delle posizioni particolari (limitazioni dell'orario di lavoro, protezione contro i licenziamenti, protezione sociale, ecc.). Inoltre, i conflitti di classe non sono le uniche forme di conflitto esistenti nelle società capitalistiche. I conflitti relativi alla posizione di genere, al dominio razzista o alla gestione dei movimenti migratori sono di grande importanza per lo sviluppo della società.
Assai spesso, il marxismo tradizionale ha considerato i conflitti di classe come se fossero gli unici conflitti veramente importanti. L'«operaismo» italiano, una corrente radicale di sinistra apparsa negli anni '60, considerava addirittura le lotte come fattore determinante nelle crisi capitalistiche. È indiscutibile che le rivendicazioni che la classe dei lavoratori riesce ad imporre rafforzino lo scatenarsi delle crisi. Lo presuppongono perfino gli economisti borghesi, così come i neoclassici moderni, nel momento in cui riconoscono che salari troppo alti, sindacati troppo forti, o regolamentazioni del mercato del lavoro troppo favorevoli alle direzioni aziendali sono la causa della crisi, o della disoccupazione. Le forme e l'intensità della lotta di classe sono senza alcun dubbio di enorme importanza, in quella che è l'analisi dello sviluppo del capitalismo in un paese, in un determinato periodo storico. Ma se, tuttavia, a livello del modo in cui si presenta il modo di produzione capitalistico «secondo quella che è la sua media ideale» (vale a dire, a livello in cui viene esposto nel Capitale di Marx), le crisi si riducono alla lotta di classe, ecco che allora si perde il senso decisivo della teoria delle crisi di Marx. Di fatto, Marx ha cercato di dimostrare che il capitale ha delle tendenze immanenti alla crisi, e che esse sono totalmente indipendenti dalle circostanze, per cui si verificano delle crisi che a loro volta sono del tutto indipendenti dalla situazione della lotta di classe. Ciò significa che si verificano delle crisi che avvengono perfino quando la lotta di classe si è assopita.
Innanzitutto, le lotte di classe sono lotte che avvengono in seno al capitalismo: il proletariato lotta per le proprie condizioni di esistenza in quanto proletariato, per dei salari più elevati, per condizioni lavorative migliori, per definire legalmente i diritti, ecc. In tal senso, ed in questa misura, le lotte di classe non sono il segno della debolezza del capitale, e neppure l'avvisaglia di una rivoluzione imminente, ma sono piuttosto la forma normale del movimento che viene assunta da quella che è la conflittualità tra borghesia e proletariato. La stessa cosa vale anche per la giustificazione delle rivendicazioni formulate, le quali per la più parte rimangono nel quadro stabilito dalla formula trinitaria: quella per cui si rivendichi un «giusto» salario e a partire da questo venga cancellata l'irrazionalità della forma - salario (vale a dire, il salario in quanto retribuzione del valore del lavoro, e non come remunerazione del valore della forza lavoro); cosa, riguardo cui Marx aveva già constatato che essa costituiva la base di ogni rivendicazione dei diritti dei lavoratori, così come vengono rappresentati dai capitalisti. [*3] Ciò significa che quando in una società borghese gli uomini, siano essi dei lavoratori o dei capitalisti, tentano di imporre i loro interessi, come prima cosa questo avviene nelle forme feticizzate del pensiero e della percezione, le quali dominano la coscienza quotidiana.
Qualsiasi cosa succeda, le lotte di classe posseggono inoltre una loro dinamica propria. Esse possono portare a dei processi di apprendimento di radicalizzazione in cui anche il sistema capitalistico viene messo in discussione nella sua totalità. Il feticismo non è propriamente impenetrabile (undurchdringlich). Ed è in particolare durante la fase del costituirsi del capitalismo industriale moderno che le lotte di classe dei lavoratori vengono represse dalla reazione brutale dello Stato (ad esempio, vietando i sindacati e gli scioperi, o perseguendo gli attivisti), cosa che spesso, a sua volta, ha rafforzato i processi di radicalizzazione. Rispetto al 19° secolo e all'inizio del 20°, in molti paesi questa repressione immediata è diminuita (ciò malgrado, in tutta una serie di paesi gioca sempre un ruolo decisivo).
Oggi, nei paesi capitalisti avanzati (führend) esiste una regolamentazione giuridica, più o meno forte, di quelle che sono le forme in cui avviene il conflitto diretto tra borghesia e proletariato: la lotta di classe deve sicuramente potersi svolgere, ma senza costituire un pericolo per il sistema (in Germania, ad esempio, il diritto di sciopero e di coalizzazione sono garantiti legalmente, ma lo è anche il diritto di serrata del datore di lavoro, invece lo sciopero politico è vietato). In modo tale che alcune determinate forme di lotta sono state affrancate dalla repressione diretta dello Stato, così come invece altre vengono represse più violentemente. Pertanto, nella storia del marxismo abbiamo visto sovente due conclusioni sbagliate relative al concetto di classe e di lotta di classe. Da un lato, la situazione di classe e la coscienza di classe sono state collegate in maniera tale che la seconda si sarebbe sviluppata necessariamente più o meno rapidamente; e dall'altro lato, si accettava il fatto che questa coscienza di classe aveva più o meno un contenuto «rivoluzionario».
Ed è per questo motivo che non è raro che ogni lotta di classe venga considerata come se fosse l'annuncio dell'avvicinarsi della lotta finale. Si è pertanto accettato che il proletariato si sarebbe necessariamente sviluppato in modo da poter così divenire una classe cosciente e rivoluzionaria via via che il capitalismo cresceva. Certo, la storia ci mostra delle situazioni in cui certe parti del proletariato hanno agito in maniera rivoluzionaria, ma tali situazioni, tuttavia non sono da intendersi come il risultato di una tendenza generale delle metamorfosi del proletariato in una classe rivoluzionaria, ma piuttosto come l'espressione di circostanze storiche concrete (per esempio, il 1918 nella Germania sconfitta, con la perdita di legittimità della cerchia aristocratico-militare che aveva comandato fino a quel momento). Per questo motivo, il fatto che parti del proletariato avessero un orientamento rivoluzionario è stato solo un fenomeno passeggero.
Tuttavia, numerose «analisi di classe» marxiste che si sono poste la domanda «chi è che appartiene al proletariato?» partivano da questa rappresentazione di un proletariato che avrebbe necessariamente dovuto diventare rivoluzionario. Si pensava che, con un proletariato definito analiticamente, si fosse trovato il «soggetto rivoluzionario». Fino al momento in cui i veri proletari non fossero stati chiari rispetto al loro ruolo, era perciò necessario aiutarli - soprattutto per mezzo di un «partito di classe», un titolo rivendicato da parecchi candidati e per il quale sono state combattute aspre battaglie. Queste due conclusioni errate, le si ritrovano anche nello stesso Marx, oltre che in una concezione deterministica della storia su cui sono state basate, e soprattutto nel Manifesto comunista, vale a dire proprio in quel testo che ha sempre giocato un ruolo assai importante nel marxismo tradizionale e nei partiti dei lavoratori.
Nel Capitale, Marx è particolarmente assai più prudente. Comunque sia, continua a rimanere come un'eco del determinismo storico della sua gioventù. Alla fine del I Libro, Marx tratteggia, in maniera succinta, in tre pagine, la «tendenza storica dell'accumulazione capitalistica» (secondo quello che è il titolo della sezione). Innanzitutto, riassume l'emergere del modo di produzione capitalistico, visto come l'espropriazione di piccoli produttori privati (i piccoli produttori e gli artigiani). Nel corso della cosiddetta presunta «accumulazione primitiva», essi perdono quella che era la loro proprietà dei mezzi di produzione, in maniera tale da essere costretti a vendere la forza lavoro ai capitalisti. Quindi, a quel punto, si verifica un cambiamento fondamentale del processo di produzione che avviene su base capitalistica: le piccole fabbriche diventano delle grandi fabbriche, ha luogo una concentrazione ed una centralizzazione del capitale, la scienza e la tecnologia verranno utilizzate in maniera sistematica, i mezzi di produzione verranno ottimizzati, e le economie nazionali verranno ad essere integrate in un mercato mondiale. Marx prosegue:
« Con la diminuzione costante del numero dei magnati del capitale che usurpano e monopolizzano tutti i vantaggi di questo processo di trasformazione, cresce la massa della miseria, della pressione, dell’asservimento, della degenerazione, dello sfruttamento, ma cresce anche la ribellione della classe operaia che sempre più s’ingrossa ed è disciplinata, unita e organizzata dallo stesso meccanismo del processo di produzione capitalistico. Il monopolio del capitale diventa un vincolo del modo di produzione, che è sbocciato insieme ad esso e sotto di esso. La centralizzazione dei mezzi di produzione e la socializzazione del lavoro raggiungono un punto in cui diventano incompatibili col loro involucro capitalistico. Ed esso viene spezzato. Suona l’ultima ora della proprietà privata capitalistica. Gli espropriatori vengono espropriati. » [*4]
In questa descrizione, lo sviluppo del proletariato in classe rivoluzionario ed il rovesciamento del dominio del capitale appaiono essere un processo inevitabile. E a tal riguardo, in una nota Marx cita ancora una volta il Manifesto comunista, dove dice della borghesia: «La sua caduta e la vittoria del proletariato sono altrettanto inevitabili ». [*5]
Nel nascente movimento operaio, simili annunci sono stati accolti molto allegramente, perfino quando era moneta corrente fare l'esperienza quotidiana di venire esclusi e sfiduciati da quella stessa società borghese di cui era stata annunciata la fine. Nella stampa socialdemocratica precedente alla prima guerra mondiale, e più tardi in quella comunista, queste tre pagine del Capitale vennero stampate e citate così sovente che la concezione dell'analisi marxista che ne sarebbe rimasta fortemente impregnata. In ogni caso, questi pronostici non vennero assolutamente confermati dalle ricerche di Marx. In che misura il monopolio del capitale si è «trasformato in ostacoli insopportabili» (cfr. Il Capitale)? Questo non è stato verificato. Il fatto che i frutti e i costi sociali dello sviluppo capitalistico fossero ripartiti inegualmente in maniera così estrema non è un ostacolo al suo sviluppo, ma - proprio come evidenziato dall'analisi di Marx - si tratta del fatto che è questa la forma primitiva del suo movimento. E che il proletariato, con l'affermarsi del modo di produzione capitalistico, è cresciuto di numero e, grazie alla grande industria esso si sia «unito» e «formato» [*6] (e in qualche modo il proletariato avrebbe dovuto organizzarsi in sindacati e politicamente, per esistere in quanto proletariato), questo è certamente vero, ma che si sviluppi necessariamente in una classe rivoluzionaria, certo questa non è una deduzione fatta a partire dall'analisi di Marx. Al contrario, il Capitale ci fornisce degli elementi che permettono di comprendere perché gli sviluppi rivoluzionari sono così rari, perché l'«indignazione» alla quale si fa riferimento nella citazione non divenga immediatamente una lotta contro il capitalismo: con l'analisi del feticismo, dell'irrazionalità della forma - salario e della formula trinitaria, Marx ha mostrato come il modo di produzione capitalista costruisca un'immagine di sé stesso nella quale i rapporti della produzione capitalistica emergono dalle condizioni di tutta la produzione in modo tale che i cambiamenti possono avvenire solo nel quadro delle relazioni capitalistiche. Ci può essere uno sviluppo rivoluzionario, ciò non è escluso, ma è tutto tranne che un risultato necessario. Marx trae, nel passaggio citato, delle conclusioni che si basano su un determinismo storico che non è giustificato a partire da quella che è la sua descrizione delle categorie del Capitale. In tal senso, questo passaggio è l'espressione delle sue speranze, piuttosto che delle sue analisi, si tratta dell'entusiasmo rivoluzionario che in questo caso ha il sopravvento sullo «scienziato freddo». La descrizione del modo di produzione capitalistico, non è tuttavia in alcun modo legata a queste discutibili conclusioni che vengono fatte sulle classi sociali. Non è possibile determinare in anticipo se, e come arriverà alla sua fine questo modo di produzione. Al punto in cui ci troviamo, non c'è più alcuna certezza. C'è solo una lotta, il cui esito rimane aperto.
- Michael Heinrich -
NOTE -
[*1] - Karl Marx, Friedrich Engels, Corrispondenza, volume 3, 1852-1853, lettera del 5 marzo 1852. Non posso trattenermi dal mettere la seguente frase tratta dalla lettera: «...Mascalzoni ignoranti come Heinzen, i quali non solo negano la lotta, ma persino l’esistenza delle classi, dimostrano soltanto, nonostante i loro latrati sanguinari e le loro pose umanistiche, di ritenere le condizioni sociali nelle quali la borghesia domina come il prodotto ultimo, come il non plus ultra della storia, di non essere che servi della borghesia, una servitù che è tanto più ripugnante, quanto meno questi straccioni riescono a capire anche solo la grandezza e la necessità transitoria del regime borghese stesso. ... »
[*2] – Eccola nella sua totalità: « I proprietari della semplice forza-lavoro, i proprietari del capitale e i proprietari fondiari, le cui rispettive fonti di reddito sono salario, profitto e rendita fondiaria, in altre parole, gli operai salariati, i capitalisti e i proprietari fondiari, costituiscono le tre grandi classi della società moderna, fondata sul modo di produzione capitalistico.
Senza dubbio è in Inghilterra che la società moderna nella sua struttura economica ha raggiunto il suo sviluppo più ampio e più classico. Tuttavia la stratificazione delle classi non appare neppure lì nella sua forma pura. Fasi medie e di transizione cancellano anche qui tutte le linee di demarcazione (nella campagna tuttavia in grado molto minore che nelle città). Ma per la nostra analisi ciò è irrilevante. Abbiamo visto che la tendenza costante e la legge di sviluppo del modo di produzione capitalistico è di separare in grado sempre maggiore i mezzi di produzione dal lavoro e di concentrare progressivamente in larghi gruppi i mezzi di produzione dispersi, trasformando con ciò il lavoro in lavoro salariato ed i mezzi di produzione in capitale. E a questa tendenza corrisponde, d’altro lato, la separazione autonoma della proprietà fondiaria dal capitale e dal lavoro, o la trasformazione dì tutta la proprietà fondiaria nella forma di proprietà fondiaria corrispondente al modo di produzione capitalistico.
La prima domanda a cui si deve rispondere è la seguente: che cosa costituisce una classe? E la risposta risulterà automaticamente da quella data all’altra domanda: Che cosa fa si che gli operai salariati, i capitalisti ed i proprietari fondiari formino le tre grandi classi sociali?
A prima vista può sembrare che ciò sia dovuto all’identità dei loro redditi e delle loro fonti di reddito. Sono tre grandi gruppi sociali, i cui componenti, gli individui che li formano, vivono rispettivamente di salario, di profitto e di rendita fondiaria, della valorizzazione della loro forza-lavoro, del loro capitale e della loro proprietà fondiaria.
Tuttavia, da questo punto di vista, anche i medici, ad esempio, e gli impiegati verrebbero a formare due classi, poiché essi appartengono a due distinti gruppi sociali, e i redditi dei membri di ognuno di questi gruppi affluiscono da una stessa fonte. Lo stesso varrebbe per l’infinito frazionamento di interessi e di posizioni, creato dalla divisione sociale del lavoro fra gli operai, i capitalisti e i proprietari fondiari. Questi ultimi, ad esempio, divisi in possessori di vigneti, possessori di terreni arativi, di foreste, di miniere, di riserve di pesca.» [Qui il manoscritto si interrompe.]
[*3] - « Man begreift daher die entscheidende Wichtigkeit der Verwandlung von Wert und Preis der Arbeitskraft in die Form des Arbeitslohns oder in Wert und Preis der Arbeit selbst. Auf dieser Erscheinungsform, die das wirkliche Verhältnis unsichtbar macht und grade sein Gegenteil zeigt, beruhn alle Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des Kapitalisten, alle Mystifikationen der kapitalistischen Produktionsweise, alle ihre Freiheitsillusionen, alle apologetischen Flausen der Vulgärökonomie. »
« Si comprende quindi l’importanza decisiva che ha la metamorfosi del valore e del prezzo della forza-lavoro nella forma di salario, ossia in valore e prezzo del lavoro stesso. Su questa forma fenomenica che rende invisibile il rapporto reale e mostra precisamente il suo opposto, si fondano tutte le idee giuridiche dell’operaio e del capitalista, tutte le mistificazioni del modo di produzione capitalistico, tutte le sue illusioni sulla libertà, tutte le chiacchiere apologetiche dell’economia volgare.» (Il Capitale. Libro I.)
[*4] - « Mit der beständig abnehmenden Zahl der Kapitalmagnaten, welche alle Vorteile dieses Umwandlungsprozesses usurpieren und monopolisieren, wächst die Masse des Elends, des Drucks, der Knechtschaft, der Entartung, der Ausbeutung, aber auch die Empörung der stets anschwellenden und durch den Mechanismus des kapitalistischen Produktionsprozesses selbst geschulten, vereinten und organisierten Arbeiterklasse. Das Kapitalmonopol wird zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht ist. Die Zentralisation der Produktionsmittel und die Vergesellschaftung der Arbeit erreichen einen Punkt, wo sie unverträglich werden mit ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt. Die Stunde des kapitalistischen Privateigentums schlägt. Die Expropriateurs werden expropriiert. » (mew 23, S. 790)
[*5] - « Ihr Untergang und der Sieg des Proletariats sind gleich unvermeidlich » (mew 23, S. 791, Fn 252)
[*6] - Cfr. Il Capitale
fonte: Lire Marx