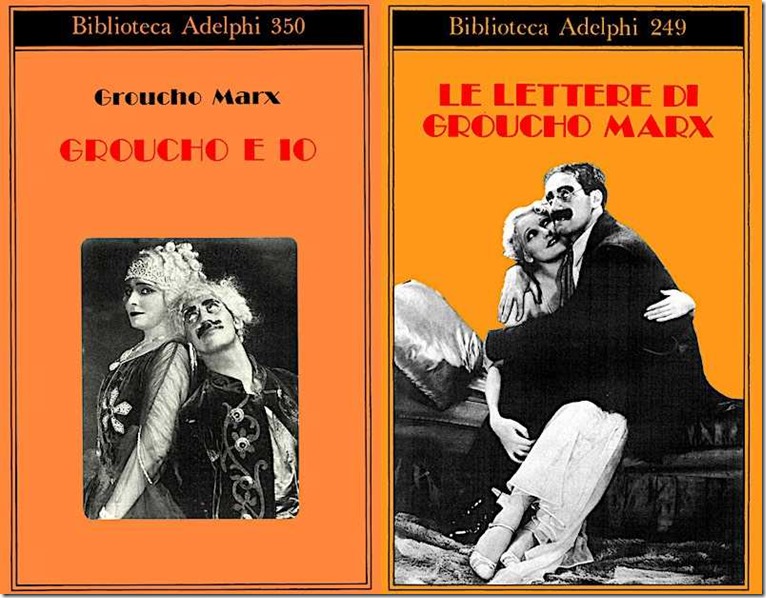Alcune precisazioni sull'anti-lavoro
- di Bruno Astarian -
Introduzione
Sul concetto di anti-lavoro regna una certa confusione. A questo non sfugge neanche il mio opuscolo «Aux origines de l’anti-travail» [Echanges et Mouvement, 2005]. La confusione consiste nel non specificare sufficientemente il concetto di anti-lavoro. Da un lato, esso consiste nel collocare nella medesima categoria dell'anti-lavoro alcuni comportamenti, come la pigrizia del lavoratore salariato che cerca normalmente di fare il meno possibile, o come la scelta secondo cui è preferibile la disoccupazione (e la sua indennità), oppure la vita ai margini. Queste pratiche di rifiuto del lavoro, di resistenza, sono vecchie come il proletariato, e non servono a definire l'anti-lavoro moderno. D'altra parte, la confusione consiste nel collocare nella categoria dell'anti-lavoro quelle pratiche di resistenza allo sfruttamento che in realtà sono pro-lavoro, come ad esempio il luddismo. Ora, io ritengo che per quanto riguarda le lotte della nostra epoca (a partire dal '68) - le quali dimostrano che il proletariato non è più la classe che si affermerà nella rivoluzione come la classe del lavoro egemonico, come quella che renderà il lavoro obbligatorio per tutti e che sostituirà la borghesia alla direzione dell'economia - sia meglio mantenere il termine di anti-lavoro.
Per meglio comprendere la specificità che dev'essere associata al termine di anti-lavoro, è necessario assumere una prospettiva storica. Precisiamo che qui siamo interessati alle lotte che si svolgono sul luogo di lavoro, le lotte contro le modalità attuali del rapporto fra i lavoratori ed i loro mezzi di produzione (assenteismo, sabotaggio, indisciplina in generale).
1 - Il luddismo
Il luddismo viene spesso identificato con una reazione spontanea e rabbiosa da parte degli operai inglesi dell'inizio del XIX secolo contro l'introduzione di nuove macchinari. Il fatto che abbiano fatto a pezzi delle macchine fa pensare ad alcune forme moderne di sabotaggio, in special modo nel contesto del lavoro alla catena di montaggio. Questa valutazione, che non è per niente esatta, spiega che il luddismo verrebbe così equiparato all'anti-lavoro.
Ricordiamo le caratteristiche principali del luddismo, che si riassumono in tre episodi, tutti avvenuti nel corso degli anni 1810:
- Gli Stockfinger (filatori di calzini) di Nottingham: oltre ai normali problemi relativi ai salari e alle tariffe, i filatori si oppongono al cut-up (cucitura fatta a partire da tessuto già filato "a maglia") ed al colting (impiego di troppi apprendisti). Le loro lotte per difendere la qualifica del proprio lavoro li porta a distruggere delle macchine (che non sono nuove). Lottano contro delle pratiche di lavoro e di sfruttamento.
- I Croppers (i tagliatori di stoffe) del West Riding: si oppongono al "gig mill" (una macchina non nuova) e allo "shearing frame" (più recente). Queste due macchine permettono di poter fare a meno del loro lavoro (molto qualificato).
- I tessitori di cotone del Lancashire: i loro caso è più complesso, in quanto mescola rivolte dovute alla fame, rivendicazioni salariali ed opposizione alla prima macchina a vapore.
La violenza contro le macchine non deve portarci fuori strada: il luddismo è pro-lavoro. Difende la qualifica contro la meccanizzazione, ma anche, e forse soprattutto, contro il lavoro di cattiva qualità (cut-up), che favorisce l'utilizzo di lavoratori non qualificati (colting), perfino delle donne! Il suo contenuto è solo apparentemente anti-lavoro. Il luddismo difende il lavoro vecchio stile. Afferma la dignità del lavoratore contro la dequalificazione e, eventualmente, contro la meccanizzazione. Tutto ciò passa attraverso un'attività politico-sindacale che si associa alla violenza contro padroni e macchine. Il luddismo è stato attivo all'interno delle correnti sindacali clandestine, e non si è opposto alle lunghe, costose ed inutili campagne di lobbyng parlamentare. Le distruzioni di macchine non erano dei movimenti di rabbia spontanei, ma delle operazioni meticolosamente organizzate. È questo che alla fine spiega il fatto che i luddisti non abbiano distrutto le macchine su cui lavoravano, ma solo quelle dei padroni o dei lavoratori colpevoli di utilizzare delle macchine proibite, sia per il fatto che fabbricavano merci di qualità inferiore, sia di lavorare al di sotto della tariffa. La rivendicazione di un lavoro di buona qualità, svolto secondo i metodi del lavoro qualificato e remunerato in maniera adeguata, ecco cosa caratterizzava il luddismo.
2 - Il sabotaggio secondo Pouget e Smith
Pouget ha fatto entrare il sabotaggio nel discorso sindacale al congresso della CGT del 1897. Il suo opuscolo, "Il Sabotaggio", da allora ha visto un numero incalcolabile di riedizioni. Pouget viene regolarmente ricordato come il precursore degli OS (operai specializzati, in realtà non qualificati) di oggi. Spesso, il suo sabotaggio viene indicato come fondatore dell'anti-lavoro. Bisogna guardarlo più da vicino: il sabotaggio invocato da Pouget (1911) non è anti-lavoro, è anti-padrone.
Pagate al lavoratore un un buon salario, ed egli ti fornirà quel che ha di meglio, e come lavoro e come condotta.
Pagate al lavoratore un salario insufficiente, e voi non avrete più il diritto di esigere la migliore qualità e la più grande quantità di lavoro che vi ha permesso di ottenere un cappello da 5 franchi per 2 franchi e mezzo.
Peuget vuole innanzitutto dimostrare che il sabotaggio è un modo efficace per piegare i padroni riguardo le questioni di salario, ecc. Inoltre, il sabotaggio dimostra che sono i lavoratori produttivi, attraverso i loro sindacati, a gestire la produzione. Il sabotaggio di Pouget non è arrabbiato e distruttivo. È calcolato, preparato. Partecipa del controllo che i lavoratori hanno rispetto al proprio lavoro, sia in quanto tecnica, sia in quanto organizzazione collettiva.
Nel suo opuscolo, Pouget cita numerosi esempi, che praticamente riguardano tutti dei lavoratori qualificati. E spesso non sono dei veri e propri casi di sabotaggio, ma si tratta di idee, di proposte che riguardano ciò che i lavoratori potrebbero fare. Il suo sabotaggio arriva a sostegno delle rivendicazioni, in preparazione di uno sciopero (come prevenzione rispetto ai sindacati "gialli").
Per Pouget, il sabotaggio è soprattutto rallentamento della produzione. Egli menziona anche la bassa qualità del lavoro (per coloro che lavorano al montaggio), quindi il danno alle merci prodotte. La distruzione parziale o totale, reversibile o meno, dei mezzi di produzione viene citata meno spesso. Ma anche in questi casi, nei confronti del lavoro non c'è una particolare ostilità. E Pouget cita, approvandolo, un sindacalista ferroviario:
«Bisognerebbe che dei compagni, fra i professionisti, i quali, conoscendo meglio il funzionamento del servizio, sapessero trovare i luoghi sensibili, i punti deboli, colpendoli a colpo sicuro senza mettere in atto delle distruzioni imbecilli e, per mezzo delle loro efficace azione, svelta ed intelligente oltre che energica, renderebbero, con un solo colpo, inutilizzabile per alcuni giorni l'attrezzatura indispensabile...»
Negli Stati Uniti, il testo di Pouget è stato in gran parte ripreso da Walker C. Smith, membro degli Industrial Workers of the World. Ma Smith è più esplicito di Pouget per quel che riguarda la disposizione pro-lavoro del sabotaggio. Egli si basa sulla padronanza che hanno i lavoratori sui processi di produzione, per arrivare ad invocare un "sabotaggio costruttivo": il sabotaggio organizzato rafforza la solidarietà fra i lavoratori, e conferisce loro un controllo supplementare sulla produzione. Per cui chiama sabotaggio costruttivo il fatto di migliorare discretamente la qualità dei prodotti che vengono venduti ai lavoratori, e che i padroni adulterano per aumentare i loro profitti. E conclude:
«Se la situazione evolverà secondo il corso attuale, ivi compresa la possibilità di un controllo sempre maggiore da parte dei lavoratori sull'industria, allora la tattica di lotta si svilupperà in base a ciò, ed il sabotaggio costruttivo farà parte di tutto questo.»
Alla svolta del XX secolo, il sabotaggio ha partecipato all'affermazione della centralità del lavoro nella società capitalistica dell'epoca. I lavoratori (almeno quelli che vengono menzionati in entrambi i testi) hanno una relativa autonomia per quel che riguarda la loro attività. Certo, esercitano un ferreo controllo sui loro ritmi e sulla loro qualità. I lavoratori sanno come vengono tecnicamente prodotte le merci. Il sabotaggio consiste nel fare abbassare la quantità e/o la qualità, cosa che ovviamente infastidisce il padrone. Ma questo sabotaggio dà anche prova della possibilità di un controllo da parte dei lavoratori sulla produzione e, per estensione, sulla società nel suo insieme. Il sabotaggio di Pouget e di Smith fa parte del progetto programmatico della rivoluzione operaia.
«Per quanto attiene ai processi di produzione, noi siamo in possesso dell'industria, E tuttavia noi non abbiamo né la sua proprietà né il suo controllo, a causa di un'assurda fede nel diritto di proprietà.» [ WC Smith, Sabotage, its history, philosophy and fonction, 1913.]
La lotta dei luddisti si inscrive in un movimento più generale di formazione dei sindacati e dei partiti della classe operaia inglese. Allo stesso modo, il "sabotaggio costruttivo" fa parte dello sviluppo del movimento operaio in quello che dovrebbe diventare un grande esercito disciplinato capace di prendere il potere, L'evoluzione verso il sindacalismo industriale va in tal senso. Le lotte degli operai qualificati sindacalizzati sono state un momento di formazione del sindacalismo industriale. In realtà, con la resistenza degli operai specializzati, essendo frazionata in piccoli gruppi di lavoratori relativamente specializzati, alcuni conflitti si sono potuti sviluppare solo federando più sindacati di mestiere sotto un medesimo ombrello.
Nello stesso stabilimento, o nella stessa città, gli operai sono divisi in più sindacati professionali, e la condizione del successo delle loro rivendicazioni è che il loro astenersi dal lavoro non si limiti alla loro specialità, né al loro stabilimento. La pratica degli scioperi spontanei di solidarietà, contro il parere dei sindacati, farà sì che essi evolvano verso il sindacalismo industriale, al fine di prevenire ed inquadrare questi movimenti.
«Le azioni di solidarietà fra macchinisti, fonditori, lucidatori, pulimentatori, fabbri, modellatori e stagnini sono sempre stati frequenti. Una lega che riuniva i loro leader sindacali nazionali, esisteva fin dal 1894. Ma il movimento per il raggruppamento formale di una federazione dotata di consigli localo, che ha avuto inizio nel 1901 ed è sfociato in una convenzione nel 1906, mirava a promuovere l'arbitraggio dei conflitti e la negoziazione congiunta, sopprimendo sia gli scioperi di solidarietà che la spinta a raggruppare i sindacati.» [David Montgomery : Workers control in America, Cambridge 1979] Il movimento operaio evolve poco a poco verso un'affermazione sempre più centrale ed organizzata della classe. Il sabotaggio costruttivo s'inscrive in questa logica. Lo scopo delle pratiche di rallentamento e di sabotaggio non è quello di rifiutare il lavoro. «La principale preoccupazione dei rivoluzionari è quella che il sabotaggio distrugga il potere dei padroni in maniera tale che i lavoratori acquisiscano un maggior controllo industriale.» (WC Smith). Lungi dall'essere anti-lavoro, il sabotaggio è parte della preparazione del proletariato all'egemonia del lavoro nella società futura.
Prima di cambiare periodo storico, notiamo di passaggio che "Il Diritto all'Ozio" di Paul Lafargue non è un testo anti-lavoro, ma un testo che rivendica il lavoro con moderazione.

3 - La resistenza al lavoro di fronte alla OST (Organizzazione Scientifica del Lavoro) e al fordismo
Segnaliamo qui anche "Il lavoro è un crimine" di Herman Schuurman, pubblicato negli anni '20 dal gruppo olandese Mokers Groep. Questo testo è notevole per la sua epoca. Esprime il disgusto per il lavoro senza rivendicare il tempo libero. È contro la scuola, contro lo sport, contro i lunghi scioperi, contro il periodo di transizione, per il furto, per il sabotaggio. Ma i Mokers Groep sviluppano queste idee in assenza di qualsiasi movimento reale che si muova in tale direzione, nella società olandese di quell'epoca. Il suo anti-lavoro non riesce perciò a svincolarsi dai principi consiliaristi, e si riduce pressoché ad un'attività individuale.
3.1 - Dalle origini al '68
Notiamo innanzitutto che la resistenza all'introduzione dell'OST, da parte degli operai di mestiere (che l'OST voleva eliminare), non ha dato origine a delle lotte di massa. Ma ha spinto, ancora una volta, il sindacalismo americano alla transizione verso i sindacati d'industria, attraverso delle "system federations", una sorta di inter-sindacati di mestiere, i quali si formano soprattutto nelle lotte contro l'introduzione del cronometraggio.
A sua volta, la resistenza degli operai non qualificati (quelli che l'OST mirava a sfruttare) è stata rapida.
Ricordiamo come il famoso "Five Dollars Day" proposto da Ford nel 1914 non sia affatto un regalo. Ford stava cercando di risolvere un enorme problema di turnover, legato al lavoro alla catena di montaggio: fra ottobre 1912 e ottobre 1913, aveva dovuto assumere 54.000 operai per coprire 13.000 posti di lavoro. E quel giorno di gennaio del 1914, in cui Ford annuncia la giornata di lavoro di 8 ore a 5 dollari, ci sono delle risse fra gli operai per poter entrare in fabbrica. Ford approfitta di questo entusiasmo per scegliere i candidati in funzione della loro moralità, mandando nelle case più di 100 sociologhi per identificare gli alcolizzati, quelli le cui case sono più o meno decorose ed i bambini più o meno ben tenuti. Quindi istituisce dei corsi di inglese obbligatori per gli immigrati più recenti, e fa una grande festa per la consegna dei primi diplomi ottenuti, con una parata di seimila operai che celebrano questo "americanisation day".
Malgrado l'entusiasmo degli operai, ivi compresi i lavoratori qualificati, per i salari del fordismo, i vicoli che derivano dall'OST e dalla catena di montaggio non ci mettono molto a far sì che compaiano delle forme di lotta specifiche. Il turnover massiccio c'è già, anche prima della prima guerra mondiale. Negli anni '20, uno studio sull'OST (ed in parte sul fordismo) denuncia le pratiche di imbroglio e frenata. L'autore spiega come queste pratiche si siano sviluppate a partire dalla debolezza e dall'incapacità dei capi ad opporvisi per il fatto che sono già soddisfatti per gli importanti guadagni di produttività ottenuti grazie al solo cronometraggio. Ed anche lui si stupisce del fatto che «a volte, il frenaggio è semplicemente il risultato di una perversità: una disaffezione nei confronti del lavorare con entusiasmo.» [Stanley Matthewson : Restriction of output among unorganized workers, New York 1931].
L'autore stesso pensa che il modo giusto di lottare contro il frenaggio che si può osservare nelle fabbriche taylorizzate, è passare al fordismo. Quindi, è il nastro trasportatore che determina il ritmo del lavoro, che non può essere frenato. Cita, tuttavia, il caso di una fabbrica fordizzata nella quale gli operai hanno una serie di gesti da fare che risulta essere troppo lunga, cosicché si verificano dei ritardi. Periodicamente, gettano un pezzo negli ingranaggi della catena, in modo che essa si arresti. È qui che, a partire da questo momento, appare una forma di sabotaggio che di fatto è anti-lavoro.
Il capitalismo del dominio formale ha spossessato l'artigiano dei suo mezzi di produzione, ma gli ha lasciato la sua qualifica. Il dominio reale del capitale sul lavoro mette in atto un secondo spossessamento con cui priva il lavoratore salariato delle sue qualifiche.
Nel lavoro alla catena di montaggio, il lavoratore non ha alcun controllo né sui tempi né sui metodi di lavoro (si vedrà più avanti come questo "secondo spossessamento" non avviene di colpo, ed il capitale continua a cercare di eliminare quel che rimane dell'autonomia del lavoratore fordizzato o post-fordizzato). Il lavoro diviene un gesto elementare, la cui natura ed il cui ritmo sono controllati dal macchinario. Le qualifiche del lavoro sono state integrate nella macchina, nel capitale fisso. Se il lavoro vivente vuole aggiustare la quantità del suo gesto, ha solo un'opzione: fermarsi. Se vuole aggiustarne la qualità, l'unica sua opzione è quella di sabotare. Al contrario, se l'operaio vuole lavorare - perché ha bisogno di soldi - la sua unica qualifica è quella di "non fermarsi". In queste condizioni, essere contro il capitale, significa essere necessariamente contro il lavoro, le cui caratteristiche si trovano nel macchinario. Non si tratta di voler lavorare per sé stessi. I lavoratori qualificati del XIX secolo potevano opporre al capitale un progetto di società fondata su quello che erano. Per gli Operai Specializzati del XX e del XXI secolo non è così. Non hanno un progetto cooperativista o auto-gestionale.
Quel che rimane attribuito al lavoro vivente, i gesti ripetitivi che vengono imposti ai lavoratori e che li esauriscono fisicamente e psichicamente, questi gesti non sono motivo di alcun orgoglio, bensì di disgusto, di rifiuto.
Il sabotaggio, che è stato uno dei mezzi di cui il proletariato si è servito per lottare contro il capitale, continua a servire, ma diventa anti-lavoro. Il sabotaggio alla Pouget/Smith dimostrava che i lavoratori avevano il controllo tecnico della produzione, e che a loro per realizzare il socialismo mancava perciò solo il controllo dei mezzi di produzione.
Oggi, il sabotaggio dimostra solamente una cosa, ed è che tutte le vecchie qualifiche dei lavoro vivente gli si oppongono in maniera antagonistica nel capitale fisso. La lotta contro il capo, per mezzo del sabotaggio o dell'assenteismo, è diventata in maniera indissociabile lotta contro il lavoro. Questo è ciò che spiega la mancanza di rispetto nei confronti dello strumento del lavoro e l'indisciplina cui si assiste nel contesto della crisi del modello fordista degli anni '60 e '70. A differenza dei luddisti, gli OS attaccano le macchine sulle quali lavorano.
3.2 - Nel '68
La crisi del '68 è stata determinata dal fatto che il capitale ha principalmente cercato l'aumento della produttività per mezzo dell'aumento dei ritmi ed attraverso il degrado generale delle condizioni di lavoro, anziché con l'attuare il superamento significativo della soglia dell'automazione oppure abbassando i salari, come poi farà più tardi.
Negli Stati Uniti, è stato coniato il termine di "negrizzazione" per designare le modalità di aumento della produttività: sostituire dei lavoratori bianchi con un numero più esiguo di lavoratori neri che svolgeranno la stessa quantità di lavoro.
3.2.1 - Sabotaggio
Il sabotaggio e l'assenteismo sono le forme salienti dell'indisciplina generale che regna nelle fabbriche fordiste degli anni del '68. E non solo in Italia, anche se è lì che i lavoratori si spingono più lontano. Ad esempio, alla FIAT, gli operai abbandonano il loro posto di lavoro e si raggruppano per formare dei cortei interni che poi marciano nella fabbrica, senza preavviso e senza sindacati. Per obbligare le persone a partecipare, quelli che sfilano in corteo utilizzano una corda con la quale "accerchiano" coloro che sono rimasti alla catena di montaggio, trascinandoli così nel corteo. Avviene anche che forzino le porte che separano i reparti e che si espandano nelle officine vicine. I capisquadra sono del tutto impotenti a far prevalere la disciplina.
Nelle officine, avvengono anche delle gare di corsa con i carrelli elevatori. Dopo il 1973, nelle officine si vedrà l'apparizione di mense selvagge che offrono bevande e giornali agli operai. Non appena avviene un qualche scontro, i pezzi di ricambio lavorati con precisione servono da armi e da munizioni. Dal punto di vista dei capi e dei padroni, le officine sono diventate ingovernabili.
L'esempio americano dello stabilimento della GM (General Motors) di Lordstown, del 1972, è famoso.
Costruito nel 1966 in una regione alla periferia di Detroit, viene progettata con lo scopo di eliminare i compiti faticosi. L'azienda paga dei buoni salari, ma impone un ciclo di lavoro di soli 40 secondi, contro quello che di solito è circa di un minuto. Alla fine del 1971, dopo uno sciopero, nel tentativo di recuperare il ritardo, la direzione licenzia 800 operai (su 8.000), senza cambiare la velocità della catena di montaggio.
È a partire da questo momento che la qualità si deteriora. L'aumento dei ritmi, tuttavia, rimane relativo. Martin Glaberman [in False Promises, a review, in Liberation, février 1974] sottolinea il fatto che a Lordstown viene praticato il "doubling-up": due operai, consecutivamente, alla catena di montaggio, svolgono successivamente l'uno il lavoro dell'altro, oltre al proprio lavoro, di modo che ciascuno possa fare delle pause supplementari. Come viene spiegato assai chiaramente da Ben Hamper [in: Rivet Head, Tales from the Assembly Line, Fourth Estate, Londres, 1992], che lo ha praticato abbondantemente nella fabbrica di Flint in cui ha lavorato otto anni a partire dal 1978, il "doubling-up" è concepibile solo a partire da un tacito accordo con il caposquadra. E si suppone anche che i tempi individuali siano sufficientemente larghi.
Questo non vuol dire che i ritmi di Lordstown non si fossero fortemente degradati, rispetto alla media dell'epoca. Ma vuole semplicemente dire che c'era ancora una riserva di produttività. Il sabotaggio della qualità, si vede nelle vetture da revisionare che si accumulano in un parcheggio alla fine della catena di montaggio. A volte arrivano fino a duemila, al punto che bisogna fermare la produzione per poter disingorgare il parcheggio.
Di fronte alla crescente indisciplina, al sabotaggio e all'assenteismo, i sindacati sono impotenti. Corrono dietro al movimento senza riuscire ad inquadrarlo. Questo suscita l'interesse della sinistra, in Francia, negli Stati Uniti, in Italia. Non otterrà un successo duraturo, né riuscirà a formare dei "sindacati di sabotaggio", o altre organizzazioni stabili.
C'è un elemento essenziale che condanna la sinistra al fallimento: da un lato, i lavoratori sono (relativamente) ben pagati, e dall'altro non hanno alcun desiderio di riformare la loro fabbrica. A fronte del degrado delle condizioni di lavoro ed all'aumento dei ritmi, la loro esasperazione è reale. Ma essa si esprime più attraverso il sabotaggio e l'assenteismo che per la partecipazione ai comitati per la salute e per la sicurezza. In questo modo, la macchina sindacale finirà per respingere, o fagociterà, senza difficoltà i candidati "radicali" alla riforma del sindacato.

3.2.2 - Assenteismo
L'assenteismo é sempre stato un problema per i capitalisti. Non appena il proletariato può essere dispensato dal lavorare, si assenta. Lo può fare più o meno facilmente a seconda della situazione (piena occupazione o disoccupazione).
Si stima attualmente che l'assenteismo ha un costo che va dall'1% all'1,87% della massa salariale, nel settore privato (in quello pubblico, l'1%). In Italia, l'assenteismo è diventato un grosso problema nelle fabbriche italiane a partire dall'inizio degli anni '70. A tal punto che il presidente della Repubblica dovette allora parlarne nel discorso televisivo di fine anno 1972:
«GLI ITALIANI AMANO LAVORARE E TROVANO NELLA QUOTIDIANA FATICA L'EBBREZZA DI CONCORRERE AL PROGRESSO DEL PROPRIO PAESE.ED È PROPRIO PER RENDERE OMAGGIO A QUESTA GENERALE VOLONTÀ DI LAVORO DEL POPOLO ITALIANO CHE NOI DOBBIAMO RESPINGERE LE TENTAZIONI LASSISTICHE CHE SI SONO MANIFESTATE, AD ESEMPIO, IN QUESTO ANNO CON TALUNE INAMMISSIBILI PUNTE DI ASSENTEISMO DAL LAVORO.»
Alla Fiat, il tasso di assenteismo arrivò al 25%: ogni giorno, mancava un quarto del personale! Cosa facevano gli assenti? Lavoravano al nero? In tal caso, si può definire anti-lavoro il loro assenteismo? Oppure si riposavano? Indubbiamente, facevano un po' di entrambe le cose.
Ad ogni modo, la Fiat fece un accordo con i sindacati affinché lottassero contro l'assenteismo, in cambio del diritto ad essere informati sui progetti di investimento del gruppo. Ma i sindacati non sono riusciti a disciplinare i lavoratori. Negli anni del 1968, l'assenteismo si differenziava soprattutto dall'assenteismo in generale per il suo tasso assai elevato, così come per quello che ho definito assenteismo di sciopero.
Questo tipo di assenteismo appare con gli scioperi americani del 1936-1937 nel settore dell'automobile.
Per quel che riguarda le fabbriche della General Motors a Flint, le occupazioni avvengono secondo il modello militare. Disciplina, manutenzione delle attrezzature e dei locali, autodifesa, niente alcol, niente donne, niente distrazioni. La mensa di Flint è arrivata a servire un massimo di duemila pasti. Questo ci dà solo un'idea del numero di occupanti solo se teniamo conto dei numerosi scioperanti non occupanti che sono andati a mangiare lì. In realtà, gli occupanti alla Flint Fisher Body n°2 il 5 gennaio erano 450, ed il 26 gennaio erano 17.
«Il problema che dovevano affrontare gli organizzatori non era quello di convincere gli occupanti ad andarsene perché era difficile nutrirli o perché erano necessari altrove, quanto piuttosto quello di avere abbastanza uomini all'interno, in modo da essere in grado di tenere le fabbriche.» [Sidney Fine : Sit Down, Ann Arbor 1969. p. 168]. I permessi erano limitati ed un certo numero di occupanti venivano trattenuti contro la loro volontà. Alcuni membri dell'United Auto Workers che lavoravano in altre imprese erano venuti a partecipare all'occupazione. Sul quotidiano locale, venivano pubblicati degli articoli che spiegano alle donne che la presenza dei loro uomini nella fabbrica era assolutamente indispensabile.
Il messaggio è chiaro: gli operai sono d'accordo a scioperare, ma preferiscono non stare dentro la fabbrica. A loro non importa di occupare e controllare le macchine. Non si identificano con il loro lavoro. È una reazione che è stata osservata anche in Francia, nel maggio-giugno 1968. Le fabbriche occupate erano quasi deserte. E quando alla fine si dovette tornare a lavorare, ci furono delle battaglie durate più giorni come a Renault Flins (1 morto) o alla Peugeot Sochaux (2 morti).
Ma l'occupazione della Fiat Mirafiori del marzo 1973 contraddice questo punto di vista? Ricordiamo velocemente cosa è successo.
Siamo in un periodo di negoziati per il rinnovamento dei contratti collettivi. Da mesi, i sindacati organizzano a turno degli scioperi ed altri movimenti minori, sia per esercitare pressione sulla gestione che per contenere la pressione che proviene dai lavoratori.
Ma, riguardo a quest'ultima, perdono colpi, allorché nel corso di un'assemblea di operai senza sindacalisti, il 23 marzo 1973, viene presa la decisione di bloccare l'uscita delle merci dalla porta 11 di Mirafiori Nord. Il lunedì 26, il piano viene applicato nel giro di un'ora. Il 27, avviene il secondo tentativo. Si è diffusa la voce dell'iniziativa alla porta 11, ed altri operai entrano nel movimento. Man mano, il movimento si allarga. Il 29, il blocco delle porte di Mirafiori Nord e Sud è completo. Anche le strade vicine vengono bloccate, e gli operai istituiscono il pagamento di un pedaggio per finanziare la loro lotta. Dopo il week end, il blocco riprende il lunedì 2 aprile, ma i sindacati e la direzione negoziano un accordo urgente che possa disinnescare il conflitto. Gli operai ottengono un aumento salariale (+ 16 mila lire), ma nell'accordo non vengono nemmeno menzionati gli altri punti che li riguardano (durate del lavoro, categorie, reintegrazione degli operai licenziati). I sindacati hanno avuto un contentino, dal momento che gli operai hanno ottenuto il diritto ad un congedo di formazione di 150 ore che viene affidato ai sindacati.
Per tre giorni, quindi, Mirafiori sarebbe stata "occupata". È questa la parola che viene usata da molte parti. Ma non c'è alcuna rivendicazione auto-gestionale da parte degli operai.
La loro attività per lo più era quella di bloccare il flusso di merci e di lavoratori (poiché era necessario impedire di passare a coloro che volevano entrare a lavorare) piuttosto che considerare una ripresa della produzione, che non veniva messa in discussione, non più della manutenzione delle macchine. Questo episodio di lotta alla Fiat è stato considerevole, soprattutto per il fatto che gli operai circolavano nelle officine gridando degli slogan che non avevano alcun senso. Se è vero, si può gridare il proprio rifiuto di identificarsi con il lavoratore? Ecco perché non bisogna lasciarsi fuorviare parlando di occupazione. È più corretto parlare di blocco della fabbrica. Ed in questo caso, gli operai sono stati senza dubbio in anticipo sui tempi.
Detto ciò, occupata o bloccata, la fabbrica era in sciopero. C'è stato un assenteismo dello sciopero? Non ho trovato molti dati in proposito su questo episodio di Mirafiori. Tutte le fonti che ho utilizzato sottolineano che i gruppi della sinistra sono stati assai poco sull'iniziatica del movimento, ed i sindacati ancora meno. Sembra che si sia formato un corteo interno di diecimila lavoratori, quindi si è diviso per poter andare a bloccare (o a tentare di bloccare) dei portali di Mirafiori Nord. Quanti sono stati quelli che alla fine sono rimasti isolati in questo primo blocco che - ricordiamocelo - è durato un'ora? Impossibile saperlo. In ogni caso, allora la fabbrica aveva 60 mila dipendenti. Dov'erano durante il blocco?
- Conclusione provvisoria
L'indisciplina che regna nelle fabbriche fordizzate del '68, oggi è difficilmente immaginabile. Né i sindacati né la direzione potevano controllarle. Il capitale è stato in grado di farlo solamente procedendo ad attuare quegli investimenti e quelle delocalizzazioni davanti alle quali è dovuto arretrare fin dove si trova a causa del loro costo. Ma le fabbriche erano diventate ingovernabili, le concessioni troppo onerose che erano state accordate agli operai non erano bastate a farli rientrare nei ranghi.
Così, alla Fiat, a metà degli anni '70, i padroni avevano concesso:
- forti aumenti salariali
- ogni cambiamento del posto di lavoro doveva essere discusso dalla direzione e dal lavoratore
- diminuzione dell'orario di lavoro
- le ore per le riunioni sindacali e per la formazione venivano pagate
- 4 delegati ogni mille lavoratori
- ogni investimento destinato all'aumento della capacità doveva essere localizzato nel sud del paese
- il salario al Sud = al salario al Nord
Per quel che riguardava la Renault, nella medesima epoca, le concessioni erano le seguenti:
- forti aumenti salariali
- soppressione del salario secondo il turno
- creazione di una nuova categoria "professionale di fabbrica"
- pagamento mensile generale
- alcuni tentativi di riorganizzazione del lavoro in gruppi semi-autonomi, che non ha avuto seguito
Tutto questo finirà con la delocalizzazione. Combinata dovunque con la disoccupazione che si sviluppa rapidamente a partire dalla fine degli anni '70, imporrà la sottomissione agli operai.
I metodi tradizionali usati dai proletari per resistere alla pressione padronale in fabbrica, sono passati dall'essere pro-lavoro (Pouget), com'erano nel caso dei lavoratori qualificati, all'anti-lavoro, nel caso degli operai specializzati.
Il luddismo è stato uno delle basi della formazione del sindacalismo di mestiere. Le lotte degli operai qualificati contro l'introduzione dell'OST (organizzazione scientifica del lavoro) hanno contribuito alla trasformazione del sindacalismo di mestiere nel sindacalismo d'industria. Le lotte degli operai specializzati degli anni '60 non hanno prodotto alcuna nuova forma di organizzazione. Ma hanno modificato il contenuto del sabotaggio, eliminando qualsiasi forma di orgoglio operaio, attraverso la pratica di un sistematico menefreghismo, non rispettando né lo strumento di lavoro né la delega sindacale né la gerarchia.
Il sabotaggio, in particolare, ne è uscito trasformato, nella misura in cui il lavoro viene dequalificato e perde il controllo dei suoi ritmi e dei suoi gesti. Da pratica ragionata da parte di lavoratori assai spesso qualificati, sindacalmente inquadrati, che appoggiavano rivendicazioni principalmente salariali, è diventata protesta rabbiosa, distruttrice, da parte di operai non qualificati che protestano soprattutto contro le loro condizioni di lavoro. Questo sabotaggio degli operai specializzati si inscrive in un'indisciplina più generale che dimostra l'assenza di identificazione degli operai nel proprio lavoro. I sindacati non riescono ad inquadrare questo movimento indisciplinato, ed è l'assenteismo di sciopero a mostrarlo chiaramente.
Abbiamo definito queste pratiche come anti-lavoro tanto per esprimere il disgusto nei confronti di un lavoro noioso e che non richiede alcuna competenza, quanto per sottolineare il fatto che sulle basi di questo movimento di rabbia e di indisciplina non si è avuta nessuna organizzazione operaia. L'impossibilità. da parte delle vecchie organizzazioni del movimento operaio, di farsi carico delle pratiche dell'anti-lavoro non ha portato alla costruzione di nuove organizzazioni di massa, malgrado gli sforzi dell'estrema sinistra in tal senso. Il termine di anti-lavoro esprime quindi anche il fatto che il comunismo non può essere visto come una società di lavoratori associati in una "economia libera".

4 - Anti-lavoro nel post-fordismo?
Quello su cui ci si può interrogare attiene a se l'indisciplina degli anni '60 e '70 sia sopravvissuta alla grande ondata di ristrutturazione che è seguita. In un testo del 2010, avevo risposto in proposito, senza mezzi termini, sostenendo che, dopo un periodo di riflusso, l'anti-lavoro era tornato in forze. Forse è necessario tornarci sopra.
Dopo un periodo di arretramento, i padroni hanno risposto all'indisciplina del proletariato in vari modi: ristrutturazione del processo fordista del lavoro, automazione parziale, delocalizzazione del fordismo tradizionale verso dei paesi con manodopera a basso costo. La svolta avviene a metà degli anni '70.
4.1 - Anti-lavoro contro il fordismo esternalizzato
La delocalizzazione è stato uno dei modi attraverso cui il capitale ha rimesso in riga la forza lavoro indisciplinata degli anni '60 e '70. Le delocalizzazioni sono avvenute principalmente verso l'Asia.
Il capitale ha trovato lì una forza lavoro alla quale ha potuto imporre quei metodi di lavoro che gli operai rifiutavano in Occidente. Ma, nel giro di qualche anno, questi nuovi operai specializzati hanno reagito allo stesso modo in cui avevano reagito i loro predecessori. Salvo diversa indicazione, gli esempi che seguono si riferiscono alla Cina.
4.1.1 - Violenza, rabbia distruttiva: alcuni esempi
Foxconn Chengdu - Gennaio 2011: Una rivolta nel complesso fabbrica/dormitorio che conta 22 mila lavoratori. Le cause sono i salari insufficienti - soprattutto dopo che c'è stata una delocalizzazione a Shenzen, dove il salario minimo è di 1200 yuan, contro i 950 di Chengdu - e le cattive condizioni di vita nei dormitori. Il dormitorio dove avviene la rivolta è di 18 piani, 24 camere per piano, 8 lavoratori per camera. Non ci sono ascensori, né acqua calda, e l'elettricità è insufficiente, ecc.
Foxconn Taiyuan - Settembre 2012: I dormitori vengono saccheggiati, gli spacci interni saccheggiati, vengono incendiate delle autovetture come protesta contro la brutalità del personale di sicurezza. I salari di base erano appena stati aumentati da 1550 a 1800 yuan al mese.
Fugang Electronics (Dongguan) - Gennaio 2013: Le cucine e la mensa vengono saccheggiate dai mille operai che fanno il turno di notte. Perché i prodotti alimentari sono marci.
Va notato che tutti questi movimenti hanno luogo all'esterno delle fabbriche. Quello che segue è un esempio contrario, ma che avviene senza rabbia e senza distruzioni. Si tratta di sabotaggio? Nel senso di un rallentamento concertato?:
Denso (Guangdong) - Luglio 2010: Questa fabbrica in cui lavorano mille operai salariati (soprattutto donne) fabbrica parti per l'industria automobilistica. Per 3 giorni, i lavoratori sono entrati in fabbrica dopo aver timbrato, ma non sono andati al loro posto di lavoro.
Invece, hanno vagato per le officine, con calma, senza fare alcun danno, poi, alla fine del loro turno di lavoro, hanno timbrato e se ne sono andati. Il terzo giorno, la direzione ha concesso loro un importante aumento.
4.1.2 - Turnover in aumento (dal 10 al 25%)
4.1.3. - Assassinio dei capi (Thongua Steel, 2009)
Nel corso delle manifestazioni contro l'ingresso di un gruppo privato nel capitale di questa acciaieria, un gruppo di operai se la prende con il capo e lo bastona a morte. La privatizzazione di Thongua viene annullata.
4.1.4 - Sleep-in: Jalon Electronics - Giugno 2010
Ad un aumento dei salari, il 1° giugno, segue un innalzamento dei ritmi, il 3 giugno, quando già anche il vecchio ritmo era diventato impossibile da mantenere. La reazione dei lavoratori, che sono esausti, è quella mettersi collettivamente a dormire sul loro posto di lavoro.
4.1.5 - Indisciplina
Ondata di scioperi nella ZES (Zona Economica Speciale) di Dalian, nel 2005. Commento di un quotidiano economico:
«Sebbene i lavoratori non abbiano esplicitamente dei leader, hanno sviluppato una strategia di organizzazione senza capi. Dal momento che i lavoratori hanno degli interessi largamente condivisi e condividono il senso di sofferenza, essi reagiscono a dei segnali sottili. Alcuni lavoratori ci hanno spiegato che, quando sono scontenti, basta che qualcuno si alzi in piedi e gridi "Sciopero!" perché tutti gli operai della catena di montaggio di alzino in piedi, come per fare un'ovazione, e fermino il lavoro».
Siemens 2012: 4 operai licenziati per assenteismo. La fabbrica entra in sciopero. La direzione minaccia di conteggiare le ore di sciopero come assenza. Gli operai bloccano la fabbrica.
Tutto ciò fa un po' pensare all'Italia degli anni '70. L'aver trasferito in Cina le condizioni di lavoro prevalenti in Occidente negli anni '70, fa apparire delle reazioni simili a quelle che avevano avuto gli operai specializzati occidentali.
Ma siamo un po' lontani da un'atmosfera all'italiana. Le lotte che abbiamo citato, per lo più rimangono isolate, e non attaccano direttamente il sistema produttivo, e in generale non si svolgono nella fabbrica. In anni più recenti, le lotte si sono moltiplicate parecchio, ma per lo più rimangono a livello di rivendicazione e di negoziazione.
Questo va ricollegato alla recessione, che sta chiudendo molte fabbriche e che fa apparire lo spettro della disoccupazione. Senza dubbio, bisogna riferirsi anche alla domanda di rappresentanza sindacale, con l'ACFTU (centrale sindacale controllata dallo Stato) o senza di esso.
Tutto questo non va nella direzione dell'anti-lavoro. Un indice che misura fra i proletari cinesi il grado di accettazione o di disperazione, è quello del moltiplicarsi dei suicidi o della minaccia di suicidio al fine di ottenere soddisfazione (in particolare per il pagamento dei salari arretrati). Nel caso delle fabbriche cinesi, si può dire che l'anti-lavoro specifico degli operai specializzati del sistema fordista esiste, ma rimane limitato e frammentato.
4.1.6 - Nessuna autogestione nelle fabbriche abbandonate dai padroni,
che pure sono a debole composizione organica (tessile, giocattoli...)
4.1.7 - Il caso del Bangladesh
Nel 2010, ho citato il caso delle rivolte operaie in Bangladesh come di un caso di anti-lavoro. In realtà, in questo paese in cui la disoccupazione è elevata, si vedono degli operai che manifestano contro i loro padroni (il più delle volte per delle questioni di salario) e che bruciano o distruggono delle fabbriche. Concludevo, sottolineando «il carattere fortemente paradossale di questi movimenti che difendono la condizione salariale distruggendo i mezzi di produzione».
Questo punto di vista è stato criticato da Red Marriott in un commento su Libcom. Per lui, il termine anti-lavoro dev'essere riservato alle rivolte degli anni '60 e '70. Per di più, il contenuto rivendicativo delle lotte degli operai di Dacca vieterebbe di parlare di anti-lavoro.
Va innanzitutto notato che i metodi di lotta nel settore tessile del Bangladesh non sono cambiati. Alcuni esempi:
- Maggio 2010, avvengono numerosi blocchi stradali e manifestazioni per sostenere una rivendicazione salariale, Vengono vandalizzate almeno 8 fabbriche.
- Luglio 2010, viene vandalizzata una fabbrica dagli operai per ottenere il licenziamento di 7 dirigenti, fra cui il padrone, a causa del loro cattivo comportamento nei confronti degli operai, ed in particolare nei confronti delle operaie.
- Ottobre 2010, il governo crea una polizia industriale specializzata nel mantenere l'ordine nei quartieri operai e nelle Zone Economiche Speciali di Dacca, Chittatong, Gazipur, ecc. Sembra che questo spieghi il periodo di calma durato fino a maggio del 2012.
- Maggio 2012, in una fabbrica del gruppo Hameem, si espande la voce che un lavoratore è stato sanzionato per aver utilizzato il suo telefono durante il lavoro e che per questo è stato messo in prigione, torturato e ucciso. I lavoratori si riuniscono in assemblea in fabbrica. Interviene la polizia speciale e ne consegue una battaglia campale, barricate, blocchi stradali, viene dato fuoco alla fabbrica, indetti scioperi nelle fabbriche vicine, ecc.
- Giugno 2012, scioperi e proteste alla Narayanganj e all'Ashulia, per ottenere aumenti salariali. Vengono attaccate dieci fabbriche. C'è un blocco massiccio (che interessa 300 fabbriche). Ma il 17 giugno migliaia di lavoratori dell'Ashulia chiedono la riapertura delle fabbriche.
Novembre 2013, dopo diverse settimane di scioperi e manifestazioni per ottenere un aumento salariale, i lavoratori trovano una serrata. Deve intervenire la polizia per impedire che gli operai saccheggino le fabbriche.
Giugno 2014, Gli operai delle Dynamic Sweater Industries, a Savar, vengono malmenati per aver richiesto un aumento di salario. Saccheggiano due piani dello stabilimento, rubando mobili e telecamere di sorveglianza.
In tutte queste lotte, quello che sorprende è vedere la reattività dei lavoratori delle fabbriche non coinvolte nel conflitto iniziale. Questa solidarietà pressoché istantanea è anche il segno di una grande indisciplina della totalità della classe operaia.
D'altra parte, si vede l'importanza della questione salariale. Gli operai domandano costantemente degli aumenti salariali (e persino la riapertura delle fabbriche). Ma ciò non impedisce che i loro metodi di lotta arrivino a distruggere dei mezzi di produzione, cosa che la dice lunga circa l'idea che si son fatti del loro lavoro. Non hanno "rispetto per lo strumento di lavoro", né del discorso politico-rivoluzionario. Le lotte continuano ad essere la loro preoccupazione immediata. Ciò malgrado, i loro metodi, il loro contenuto concreto, mantengono il discorso dell'anti-lavoro.
Red Marriott si ferma al fatto che i lavoratori chiedono degli aumenti salariali per poi, probabilmente, considerare le loro lotte come non rivoluzionarie. Su questo punto non ha torto, ma il punto non è questo. L'anti-lavoro non è la rivoluzione, né il suo inizio, né il suo modello. È una forma di lotta che indica che la rivoluzione non avrà come contenuto quello di far accedere la classe lavoratrice ad una posizione egemonica nella quale sostituirà la classe borghese. E tutto questo lo indica nel quadro delle attuali forme della lotta dei lavoratori non qualificati.
Le pratiche anti-lavoro si inscrivono nel corso quotidiano della lotta di classe. E in quanto tali non hanno alcun potenziale rivoluzionario. Non sono altro che un'indicazione del contenuto della contraddizione proletariato/capitale. In un momento insurrezionale intenso e relativamente generalizzato, il sabotaggio della produzione, l'assenteismo di fabbrica o di sciopero, l'indisciplina nei confronti dei padroni e dei sindacati continueranno ancora ad essere all'ordine del giorno? Ne dubito.
Uno dei motivi per cui, secondo il mio interlocutore, non si può mettere nella stessa categoria la rivolta degli operai specializzati degli anni '60-'70 e le lotte del Bangladesh, è che gli operai specializzati avevano i salari più elevati dell'epoca, soprattutto nel settore dell'automobile, mentre i salari del Bangladesh sarebbero i più bassi del mondo (cosa indubbiamente vera).
Il confronto è traballante, Poiché, in Bangladesh, c'è un'offerta di posti di lavoro nel settore tessile, il che vuol dire, relativamente parlando, che i salari non sono poi così malvagi se paragonati ad altre possibili fonti di reddito. D'altra parte, Red Marriott mi rimprovera per non aver tenuto conto delle differenze fra le società (industriale sviluppata, o sottosviluppata), e del contesto (sottoccupazione di massa, povertà, ecc.)
Ma non è questo quello che qui ci interessa. Quando il capitale trasferisce in Asia il taylorismo ed il fordismo, lo fa per sfruttare questa differenza esistente fra le condizioni sociali di partenza e quelle di arrivo. Va dove può trovare una manodopera a buon mercato e in abbondanza.
Quello che qui ci interessa, sono solamente le modalità di sfruttamento del lavoro che viene proposto, e che viene imposto a questa nuova classe operaia. Questa classe operaia ha bisogno di lavorare, e accetta le condizioni del capitale. Viene perciò catturata in una forma della contraddizione proletariato/capitale che la porta necessariamente a riscoprire i metodi di lotta di coloro che li hanno preceduti in Occidente. Io non tengo conto delle differenze sociali fra l'Italia del 1970 ed il Bangladesh del 2010 perché voglio seguire gli effetti del taylorismo/fordismo nella sua traslazione geografica.
Ma se si volesse considerare nel loro insieme quelle che sono le società in cui si è installato il fordismo tradizionale, dopo il 1980, e lo si volesse soprattutto fare nella prospettiva di un processo rivoluzionario, allora ci sarebbe molto da dire. Ho provato a farlo, in maniera semplificata, nel mio studio sulla Cina.

4.1.8 - Trasporto pubblico
A partire da qualche anno, si assiste a delle rivolte di massa contro le cattive condizioni imposte ai proletari per quel che riguarda il trasporto pubblico che serve a collegare il loro luogo di residenza con il luogo di lavoro. Ecco alcuni esempi:
- Pretoria, Maggio 2005: Uno sciopero degli autisti impedisce ai lavoratori di tornare a casa alla fine della giornata di lavoro. Vengono bruciati 6 autobus. Nell'arco di 21 ore, viene firmato un accordo per la ripresa parziale del servizio.
- Buenos Aire, Maggio 2007: I continui ritardi dei treni suburbani causano una rivolta nella stazione di Constitución, che viene saccheggiata e parzialmente incendiata. I negozi all'interno della stazione vengono depredati.
- Bogotà, Marzo 2012: La città è stata dotata di una rete modello di autobus, strutturata in azienda. Una modesta protesta contro le tariffe troppo alte, da parte di studenti, ai quali ben presto si uniscono dei teppisti, insieme all'affollamento di passeggeri a causa di ritardi, si trasforma in una rivolta. Cinque stazioni vengono saccheggiate, le casse rapinate, i vetri infranti, le video camere di sorveglianza rubate.
- Mumbai, Gennaio 2015: I continui ritardi scatenano una protesta da parte dei passeggeri. Vengono saccheggiate le casse, i bancomat e le macchine per i biglietti (vengono rubati denaro e ticket). I veicoli vengono bruciati, dieci treni danneggiati. Sono almeno 12.000 le persone coinvolte negli incidenti che riguardano almeno due stazioni.
- Johannesburg, Luglio 2015: I ritardi dei treni provocano una rivolta. Due treni ed un stazione, vengono incendiati.
In un mio testo del 2010, ho considerato il fatto queste rivolte facevano parte dell'anti-lavoro. Infatti, in realtà il tempo di trasporto è tempo di lavoro non pagato. D'altra parte, i trasporti pubblici sono il collegamento fra i sobborghi e le fabbriche, o gli uffici, e non si vede il motivo per cui dovrebbero essere risparmiati dalla rabbia dei proletari quando i sobborghi ed i luoghi di lavoro non lo sono. E infine, anche perché stipare i proletari nei mezzi pubblici è un momento di umiliazione quotidiano che si ripete due volte al giorno.
Tali erano i miei argomenti a favore delle rivolte contro i trasporti pubblici viste come una forma di anti-lavoro. Sarebbe stato più logico collegarle a quelle pratiche anti-proletariato di cui ho parlato prima nel testo. Dal momento che queste rivolte avvengono fuori dalla fabbrica.
Ma come avviene nell'anti-lavoro vero e proprio, distruggono un elemento necessario alla riproduzione del proletariato. Nelle loro stazioni periferiche, i proletari chiedono dei trasporti che funzionino in maniera appropriata, però distruggono strutture e treni. Si tratta del medesimo paradosso che abbiamo rilevato, ad esempio, rispetto al Bangladesh, ma che qui riguardano un momento extra-lavorativo della riproduzione del proletariato. Attaccando la navetta che copre il tragitto fra lavoro e casa, il proletariato attacca quello di cui ha bisogno per vivere come proletario. Al di là dell'esasperazione del tutto comprensibile, bisogna vedere in queste pratiche, che finiscono solo per aggravare la situazione dei proletari, la medesima cosa che viene indicata dall'anti-lavoro propriamente detto, vale a dire la prova della possibilità e della necessità dell'auto-negazione del proletariato per superare la contraddizione sociale del capitalismo.
Allo stesso modo in cui l'anti-lavoro annuncia che il proletariato non farà la rivoluzione operaia che era stata prevista dal programma proletario, a loro volta, le pratiche anti-proletarie annunciano che questa rivoluzione non verrà fatta come affermazione della cultura proletaria, ma come la sua distruzione. Per cultura proletaria, intendo tutte le forme di vita e di pensiero che costituiscono la riproduzione del proletariato nella società capitalista. Le rivolte del 2005 nelle banlieue francesi sono una pratica anti-proletaria, così come lo sono le distruzioni da parte dei proletari dei loro propri quartieri, così come avviene nelle rivolte nel ghetto.
4.2 - Anti-lavoro nei paesi industrializzati
Nei paesi industrializzati, la messa in riga del proletariato è avvenuta per mezzo della disoccupazione e della trasformazione post-fordista del processo lavorativo immediato. Riguardo quest'ultimo, il modello produttivo della Toyota è stato considerato come un modello perfetto che riunisce una spietata ricerca del guadagno di produttività con il coinvolgimento dei lavoratori nel continuo miglioramento dei metodi di produzione (gruppi di qualità). In realtà si tratta del modo in cui il padrone riesce a catturare e a recuperare l'ultima astuzia personale che avevano gli operai specializzati per riuscire a recuperare qualche secondo su un ciclo di lavoro già molto breve. Siamo in presenza di un nuovo livello di spossessamento dei lavoratori. Pur essendo assai poco qualificati, essi avevano, nel fordismo classico, delle astuzie per poter guadagnare tempo e potersi riposare. L'immissione degli operai nei team incaricati di un compito collettivo più grande di quello del vecchio operaio specializzato, la polivalenza che ciò presuppone ci sia fra gli operai della squadra (cosa diversa dalla cosiddetta ricomposizione del lavoro), la costrizione al continuo miglioramento del processo lavorativo, la rigida sorveglianza degli operai, dell'uno nei confronti dell'altro e da parte del capo team, ecc., fa sì che, non appena individuate, quelle astuzie vengano subito integrate nella definizione della postazione di lavoro, e che nel giro di qualche secondo vengano recuperate dal padrone.
Tommaso Pardi descrive il modo in cui il management attraverso lo stress consista nel dare degli ordini contraddittori e lasciare che se la sbrighi il lavoratore. Ad esempio, se c'è un problema nella sua postazione di lavoro, il lavoratore può ignorarlo e può permettere che passi un pezzo di cattiva qualità. Questo è contrario all'esigenza della qualità costante ed il difetto verrà ricondotto alla sua postazione. Ragion per cui verrà quindi sanzionato. Certo, il lavoratore può anche tirare una leva e fermare la catena per chiedere che il suo problema venga risolto. Ma verrà malvisto. Il livello di funzionamento della catena viene visualizzato continuamente, e tutti possono vederlo. Non appena scende al di sotto del 95 o del 90%, tutti sanno che ci saranno delle ore supplementari obbligatorie. Perciò, fermare la catena non è un buon modo per farsi degli amici. Conclusione: sbrigatevela da soli per non avere problemi...
In sostanza, il post-fordismo è un fordismo che corregge le sue imperfezioni al fine di lottare contro le ultime tracce di questo bighellonare che all'inizio aveva provocato quel che era stato l'approccio di Taylor. Non sono a conoscenza di esempi di lotta di fabbrica che si opponga specificamente a queste forme di subordinazione. Probabilmente ce ne sarà qualcuna, e senza dubbio rimangono ad un livello assai limitato, dal momento che i progressi dell'informatica rendono continuamente sempre più stretta la sorveglianza dei lavoratori.
Uno studio fatto su Angry Workers of the World su Amazon in Polonia ed in Germania, racconta di alcune lotte per il rinnovo dei contratti temporanei. I lavoratori erano riuscisti a rallentare per due volte il lavoro, nonostante lo stretto controllo digitale dell'attività. Questo rimane assai limitato. Il problema di aziende come Amazon è sempre più quello di aumentare la velocità. Secondo Angry Workers of the World , i robot sono ancora troppo cari. Cosa che ci pone in una situazione come quella verificatasi all'epoca del fordismo della fine degli anni '60: gli investimenti in capitale fisso sono troppo onerosi, perciò i guadagni di produttività vanno fatti attraverso l'aumento dei ritmi - Con l'importante differenza che la disoccupazione viene mantenuta a livelli di massa, e fa così in modo da rimandare il momento in cui la situazione esploderà. Visto che per il momento, il modello tiene grazie al vasto esercito lavorativo di riserva disponibile. Al momento di picco della sua attività, Amazon Polonia e Germania cercherà lavoratori fino in Spagna ed in Portogallo.

Conclusione
Ho detto precedentemente che dovevo chiarire la mia posizione espressa nel 2010, e mi sembra che ci siano almeno tre elementi da sottolineare:
Da un lato, l'anti-lavoro dev'essere distinto dall'ordinario rifiuto del lavoro. Quest'ultimo si inscrive nella resistenza quotidiana del proletariato in tutte le epoche. Fa parte di quelli che sono i mezzi della sua sopravvivenza rispetto alla spossatezza e allo sfinimento a causa di un padrone. Il proletariato preferisce lavorare meno, se non punto, ogni volta che sia possibile. Questo è l'effetto dell'esteriorità del lavoro salariato rispetto al lavoratore. Oggi, il rifiuto del lavoro esiste a livelli di massa e, nei paesi centrali, il welfare arriva in suo aiuto. Dato il carattere di massa della disoccupazione e delle condizioni assai dure del lavoro post-fordista, il turnover dei proletari fra disoccupazione (indennità, anche cattiva) e lavoro (insostenibile a lungo termine) è una cosa buona per il capitale. Inoltre, anche i capitalisti più conservatori hanno cominciato a riflettere sull'istituzione di un salario universale. Senza dubbio gli economisti si domandano a che livello di miseria bisognerà collocare questo salario universale per fare in modo che la pressione della disoccupazione continui a costringere i proletari a lavorare da Amazon e da altri sfruttatori post-fordisti. Nel frattempo, non voler lavorare e preferire vivere ai margini quando si può è un comportamento normale del proletario, ma che non è particolarmente critico della società attuale.
- D'altra parte, mettere in una prospettiva storica alcune pratiche di lotta nella fabbrica, come il sabotaggio, l'assenteismo e l'indisciplina in generale, rivela una trasformazione del contenuto di queste pratiche dal pro all'anti-lavoro.
Bisogna periodizzare la storia del sabotaggio, che non sempre è stato anti-lavoro. Quando ha raggiunto un certo grado di dequalificazione, il lavoro ha finito per trovarsi in opposizione a sé stesso nella misura in cui si oppone al capitale, ivi compreso anche nelle sue lotte quotidiane.
Il sabotaggio diventa irrispettoso dei mezzi di produzione, e distrugge ciò che consentiva ai sabotatori di lavorare. Pugeot non è arrivato fino a quel punto. Era immerso in una cultura operaia che l'anti-lavoro, allargandosi fino all'anti-proletariato, rifiuta tanto quanto rifiuta il lavoro. Vanno riconsiderate le vecchie pratiche, in apparenza molto radicali, dal punto di vista del superamento del movimento operaio tradizionale. Pouget e Lafargue sono degli esempi di autori ancora frequentemente citati da dei commentatori che, d'altro canto, rivendicano l'auto-negazione del proletariato ed il superamento del lavoro. Questo non è coerente.
- Infine, l'anti-lavoro è tornato in forze negli anni recenti?
Le osservazioni fin qui mostrano che, con alcune eccezioni, le lotte che possono essere definite come anti-lavoro, nel periodo recente avvengono al di fuori della fabbrica propriamente detta. Nel caso del fordismo tradizionale che si è trasferito nei paesi in via di sviluppo, o nei paesi emergenti, quando le lotte attaccano i mezzi di lavoro, lo fanno all'esterno, come avviene in Bangladesh. In Cina, le distruzioni colpiscono più frequentemente le mense ed i dormitori, piuttosto che le officine.
Occorre quindi constatare che le lotte anti-lavoro non si sono sviluppate nelle fabbriche, con un'ondata comparabile a quella che c'è stata in Occidente negli anni '60-'70. Nei paesi industrializzati, le fabbriche sono tranquille. Il rigido controllo sui lavoratori per mezzo della digitalizzazione e della disoccupazione ha finora impedito che qualsiasi vertenza lavorativa. In queste condizioni, si può azzardare che un movimento proletario che rimettesse seriamente in discussione le condizioni attuali della riproduzione del rapporto proletariato/capitale sarebbe allo stesso tempo anti-lavoro e anti-disoccupazione.
Per attaccare il lavoro cui è costretto, il proletariato dovrà contemporaneaente negare che il fatto che la disoccupazione sia un ostacolo insormontabile. E Soprattutto, questo movimento ingloberà nel suo Maelstrom anche il cuore dello sfruttamento capitalistico, vale a dire le fabbriche e gli uffici dei paesi centrali. L'ingresso dei lavoratori produttivi in una fase di lotte generalizzate, se non (addirittura) insurrezionali, mostrerà con ogni probabilità che l'anti-lavoro degli operai specializzati degli anni del '68 è stata solamente una prima bozza.
- Bruno Astarian - Dicembre 2016 - Pubblicato su Paris-luttes.info -
Testo originale qui<