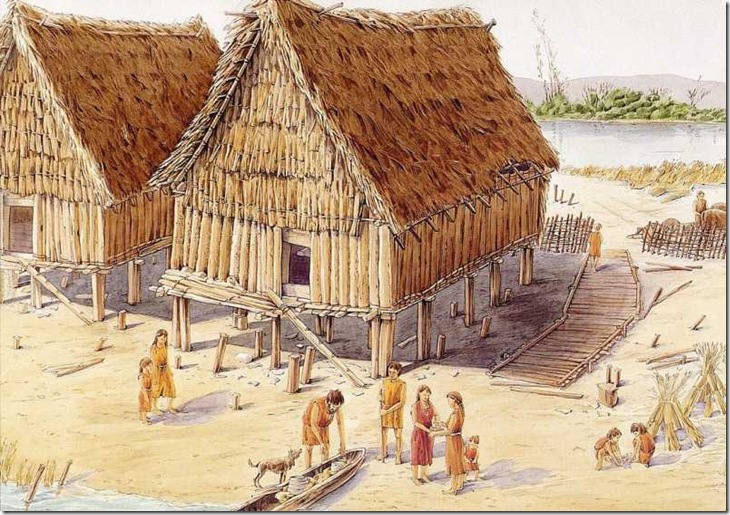L'antiterrorismo viene spesso compreso in termini di emergenza e di sospensione dello Stato di diritto. Contro questa lettura eccezionalista sviluppata soprattutto da Giorgio Agamben, Christos Boukalas sostiene un approccio strategico-relazionale delle mutazioni degli Stati capitalisti e degli apparati securitari, rispetto a cui lo statalismo autoritario appare come una forma normale di potere politico nella società capitalista. In questa prospettiva, i potenziali di resistenza alle strategie del potere non devono essere trovati nella "nuda vita" ma nelle forze sociali e nelle lotte concrete che caratterizzano la situazione attuale.
Il contributo di questo articolo alle analisi critiche del terrorismo consiste nel presentare e confrontare i due approcci alla sicurezza interna agli Stati Uniti [*1]: in primo luogo, l'approccio in termini di stato di emergenza, derivato da Carl Schmitt ed introdotto nei dibattiti contemporanei attraverso la sua riconcettualizzazione da Giorgio Agamben, e in secondo luogo, un approccio strategico-relazionale elaborato a partire dalla teoria dello Stato di Nicos Poulantzas e Bob Jessop.
Stato d'eccezione o statalismo autoritario: Agamben, Poulantzas e la critica dell'antiterrorismo
- di Christos Boukalas -
Nelle due prime sezioni, ho descritto a grandi linee l'approccio in termini di stato di emergenza ed ho mostrato rispetto a cosa gli sviluppi recenti della sicurezza interna riecheggiano tutto questo e per certi aspetti arrivano anche a contraddirlo. In seguito, ho proceduto ad una valutazione critica dell'approccio di Agamben che ritengo sia concettualmente fragile ed analiticamente limitato per poter comprendere l'antiterrorismo. Nelle rimanenti tre sezioni, ho presentato alcuni aspetti chiave di un approccio strategico-relazionale alternativo e ho suggerito un quadro più pertinente alla comprensione dell'antiterrorismo. Ma prima riassumiamo la mia tesi.
In "Stato di eccezione" (2003), Giorgio Agamben procede ad un fondamentale riesame di un dibattito degli anni 1920 - in parte implicito, in parte esplicito - fra Walter Benjamin e Carl Schmitt, al fine di difendere la propria tesi sul potere politico come era stata formulata in "Homo Sacer" (1998). In tal modo, costruisce un quadro concettuale in cui riecheggia potentemente l'ondata di misure antiterroriste successive all'11 settembre. Per Agamben, in Occidente la politica è diventata uno stato di emergenza permanente che ha avuto l'effetto di ridurci (a cominciare dai detenuti di Guantanamo) alla nuda vita. Quest'analisi è stata ampiamente mobilitata, in una miriade di varianti, per dar conto del potere politico sotto l'antiterrorismo. Così, ad esempio, il rapporto fra nuda vita e sovrano viene utilizzato per riconcettualizzare le politiche dei confini (Vaughan-Williams, 2009) e per comprendere le soggettività derivanti dalla gestione della crisi finanziaria (Brassett e Vaughan-Williams, 2010). Il campo - l'interfaccia privilegiata dal potere sovrano e dalla nuda vita - diviene il paradigma della vita sociale e delle cultura (Diken et Lausten, 2005). Lo stato di emergenza permanente costituisce la nuova configurazione del potere globale (Hardt e Negri, 2004, p. 7), il risultato della ristrutturazione del mondo (Callinicos, 2003, p. 6), la matrice di un "contro-diritto" (Ericson, 2007, p. 26-35) oppure un termine sinonimo del declino della democrazia liberale e dello Stato di diritto così come dell'avvento di poteri arbitrari coercitivi (Schurman, 2002 ; Bunyan, 2005 ; Michael-Matsas, 2005, p. 222–248 ; Whyte, 2005 ; Paye 2007) [*2].
In quest'articolo, sostengo che, malgrado forti corrispondenze fra l'ipotesi di Agamben ed alcuni aspetti chiave della politica antiterrorista, la tesi dello Stato di emergenza non riesce a fornire un'interpretazione adeguata della politica contemporanea. « L'eccezione permanente » ha come premessa una comprensione della politica vista come effetto strutturale delle interazioni fra il potere sovrano e la nuda vita. Tale effetto è sostanzialmente inalienabile nel corso della storia (occidentale). Esso rimane sempre lo stesso, quale che sia l'identità di chi occupa ciascuna posizione strutturale (nuda vita, sovrano), quale sia il contesto nel quale si gioca la loro relazione e quali che siano gli scopi ed i significati che lo sottendono e lo orientano. Questa riduzione della politica ad una condizione eterna e singolare la svuota del suo contenuto, ne rimuove le sue forme socio-storiche specifiche e, pertanto, la rende impossibile. L'analisi di Agamben occulta le questioni chiave che attengono alle pratiche, ai processi, alle ragioni ed agli obiettivi che caratterizzano la sicurezza interna.
Al fine di rimettere la politica al centro dell'analisi e fornire un quadro per trattare (o quanto meno porre) tali questioni, propongo un approccio strategico-relazionale alla sicurezza interna. Avanzo l'argomento secondo il quale quest'ultima costituisce una riconfigurazione dello statalismo autoritario, una forma statale costituita per gestire lo stato di crisi permanente che caratterizza le società capitaliste. «L'eccezione permanente» contro « la crisi permanente »: le due formulazioni appaiono simili. Ma questo leggero cambiamento del vocabolario indica un ribaltamento concettuale più ampio. L'analisi si disloca dalla pura essenza alle congiunture socio-storiche specifiche, le considerazioni teoriche passano dalle strutture ai rapporti sociali e la base metodologica viene trasferita dal diritto e dal linguaggio alle dinamiche sociali. In sintesi, il nostro approccio considera l'antiterrorismo nella sua specificità sociale e storica, e permette così un comprensione più ricca della riconfigurazione del potere politico che tale antiterrorismo genera.
La tesi dell'eccezione
L'eccezione, così come viene esposta in maniera paradigmatica da Schmitt (1985), si materializza in una situazione di urgenza esistenziale e costituisce il momento in cui la politica normale cessa di avere corso. L'ordine legale e costituzionale che regola quotidianamente la politica non è più conveniente per poter far fronte ai problemi che si presentano. Quindi viene sospeso a favore di un attore più potente e più risoluto - il sovrano - che può decidere ed agire come meglio crede.
Il sovrano è quell'attore la cui prerogativa consiste nel decidere dell'esistenza effettiva dell'eccezione. Non si tratta (necessariamente) dell'entità che crea la legge, bensì di quella che dispone del potere di sospendere il diritto. Il sovrano è un attore singolare ed unitario che, nell'emergenza, concentra tutto il potere. Così facendo, annulla la pluralità dei poteri in seno allo Stato liberale e fa riemergere la singolarità inerente alla logica stessa del potere (Kondylis, 1994, p. 128-131). L'azione del sovrano non si basa più sul diritto ma sulla forza. Nella misura in cui gli avvenimenti e le dinamiche sociali non sono più mediati dall'ordine legale, l'eccezione costituisce un momento di guerra aperta nel corso della quale l'antagonismo forza/contro-forza diviene l'unica determinazione dell'azione. L'intervento violento del sovrano nel quadro dell'eccezione prepara il terreno - o crea un precedente - perché emerga una nuova normalità giuridico-politica. Di conseguenza, l'eccezione non è soltanto un momento di autentica creazione legale e politica ma costituisce l'atto costitutivo stesso della normalità, e di conseguenza prevale su di esso (Kondylis, 1994, 126 ; Mills, 2008, 61-62).
Schmitt ha ben presto ristretto il potenziale radicale della sua analisi dell'eccezione reintroducendola nell'ordine legale. Anche se sospende il diritto, lo stato d'eccezione non significa l'anomia o il caos. La decisione che travolge l'ordine legale rimane contenuta all'interno di un quadro giuridico. Perfino la sua imprevedibilità viene prevista da quest'ultimo ed esso, in cambio, genera la normalità che conferisce alla legge la sua validità (Schmitt, 1985, p. 12-13 ; Agamben, 1998, p. 17-9, 2005, p. 36). Analogamente, il sovrano che sospende e reinizializza l'ordine legale rimane una creatura di quest'ultimo. L'ordine giuridico determina quale persona o quale istituzione assumerà la decisione ed agirà dentro l'eccezione. Il sovrano è un potere giuridicamente stabilito. Nel corso dell'eccezione, egli può sospendere totalmente l'ordine giuridico ma non le regole fondamentali dell'ordine sociale (Kondylis, 1994, p. 156-157 ; Norris, 2005, p. 58). Lo statalismo di Schmitt e la sua identificazione esclusiva della politica con lo Stato, almeno nei suoi scritti precedenti alla seconda guerra mondiale, gli fanno localizzare il sovrano simultaneamente sia all'interno che all'esterno dell'ordine giuridico. Nel mentre che il diritto viene sospeso da parte dello Stato, quest'ultimo sussiste e cerca di salvaguardarsi. Lo Stato viene così a costituire l'elemento che rende l'eccezione differente dal caos (Kondylis, 1994, p. 162).
Su questa base, Agamben compie un doppio movimento. Dapprima, in linea con Schmitt, interpreta l'eccezione ed il sovrano come dei concetti-limite che appartengono all'ordine giuridico ma che allo stesso tempo si situano al di là di quest'ultimo. Questi due concetti sono mutualmente costitutivi. L'eccezione ed il sovrano emergono insieme: la prima designa - o rivela - il secondo in quanto forza suprema in grado di decidere e di agire al di là dei confini dell'ordine giuridico, mentre il sovrano non solo può intervenire senza restrizioni nell'eccezione ma dispone della capacità stessa di farla scattare.
Agamben completa questo accoppiamento concettuale fra un soggetto (il sovrano) ed una situazione (lo stato di emergenza) introducendo un altro concetto: homo sacer, l'individuo ridotto alla nuda vita. Agamben recupera questa figura che stava ai margini del diritto romano originale in seno al quale rimanda ad un tipo particolare di criminale esiliato. L'homo sacer non può essere sacrificato. In compenso qualsiasi membro della comunità ha il diritto di ucciderlo senza essere per questo perseguito per omicidio. Questa figura di colui che non può essere ucciso dalla forza politica organizzata della società ma la cui vita viene lasciata alla discrezione dei membri della società, costituisce un altro concetto-limite che si situa sia nel seno che al di là della legge. Non protetto dal diritto, l'homo sacer è l'oggetto di potere la cui capacità di agire al di là di ogni costrizione legale è consentita dal diritto. C'è una stretta analogia fra le due entità: il potere sovrano, togliendo la sue mediazioni giuridiche, mette in lui la vita a nudo e, simultaneamente, la nuda vita fonda il potere sovrano nella misura in cui essa ne è l'oggetto. Il potere sovrano e la nuda vita si costituiscono mutualmente in un medesimo movimento. Il sovrano e l'homo sacer sono dei concetti opposti ma omogenei (Agamben, 1998 ; Mills, 2008, p. 72 ; Murray, 2010, p. 64-65). Agamben stabilisce così il rapporto mutualmente costitutivo fra le due soggettività (homo sacer e sovrano) e vede in questo il cuore di tutti i rapporti di potere della civiltà occidentale (Agamben, 1998, p. 8-9 ; Mills, p. 64-65). Lo stato d'eccezione forma quindi il contesto situazionale che viene prodotto da questo rapporto di potere e che simultaneamente lo realizza. L'argomento chiave di Agamben è che questo rapporto costituisce il «centro» nascosto del «potere», la «struttura politica fondamentale» segreta (Agamben, 1998, p. 20, 2005, p. 86).
Fin qui, Agamben riproduce lo schema schmittiano dell'interrelazione fra concetti-limite che permette di cogliere il vero senso del potere. L'introduzione della nuda vita in quanto oggetto costitutivo di tale potere complementa ma non rimette in discussione questa costruzione. In effetti, il Nemico di Schmitt, in particolare nelle sembianze del Partigiano, che «conosce ed accetta la sua condizione di nemico che esiste al di fuori della proprietà, del diritto e dell'onore», può essere considerato, facendo uso del prima agambeniano, come una creatura della nuda vita (Schmitt, 2007, p. 11, p. 30).
Tuttavia, Agamben supera l'universo schmittiano affermano la possibilità dello stato di emergenza "reale" che esiste del tutto al di là dell'ordine giuridico. Ponendosi sulla linea di Benjamin, recupera il potenziale radicale della violenza ("divina") dell'eccezione in quanto creazione ex-nihilo di un nuovo ordine sociale (Benjamin, 1986, p. 52-64 ; Agamben, 2005). Riprende in altri termini quelle implicazioni radicali dell'eccezione che Schmitt aveva cercato di sopprimere, ponendole come concetto-limite (Kondylis, 1994, p. 156-162).
Tuttavia, malgrado l'affermazione della possibilità di un'eccezione rivoluzionaria che distruggerebbe il sovrano, vista come possibilità politica ultima, l'analisi della politica contemporanea fatta da Agamben rimane confinata in uno schema schmittiano. L'eccezione prolifera in tutti gli spazi della vita sociale e quest'espansione (topologica) costituisce l'eccezione stessa come (cronologicamente) permanente: l'eccezione è diventata la regola. Il fondamentare la politica sull'opposizione fra il diritto e la violenza pura viene superato. Il diritto viene drenato del suo contenuto e del suo significato e, nel mentre che si ritirano le mediazioni legali, si rivela la vera essenza del potere in quanto potenza sovrana. Privati delle nostre mediazioni giuridico-politiche, siamo tutti ridotti alla nuda vita. Pur costituendo una tendenza sempre presente, questo stato di eccezione raggiunge una nuova fase di concretizzazione sotto forma di politica antiterrorista (in particolare americana) dopo l'11 settembre (Agamben, 2005). Nella sezione successiva, tratto a grandi linee la pertinenza della tesi dell'eccezione permanente riguardo al pensare le realtà della politica antiterrorista americana.
La sicurezza interna come stato d'eccezione
Le misure antiterroristiche, così come quelle volte a gestire la crisi economica in corso, si caratterizzano per un'abbondanza di elementi eccezionali. Per cominciare, la legislazione antiterrorista ha espulso l'aspetto giudiziario dalle inchieste "terroristiche". Ha trasformato il mantenimento dell'ordine in un'attività di prevenzione basata sull'informazione, ha dissociato la sorveglianza dal sospetto di reato, ha separato la sentenza punitiva dall'aver effettivamente commesso l'atto illegale ed ha portato alla proliferazione di leggi vaghe, elastiche e soggettive soprattutto riguardo al crimine che si trova al centro dell'antiterrorismo, "il terrorismo interno", come ha fatto con la categoria chiave della politica economica, "le attività finanziarie". Queste tendenze combinate riducono la legge ad un semplice strumento per la realizzazione di obiettivi politici (vedi Paye, 2007, ch. 5-6 ; Donohue, 2008, p. 233-272 ; Boukalas, 13-40, p. 222).
Di questo strumento si appropria il sovrano, in questo caso l'esecutivo federale e la Casa Bianca in particolare. Una volta che è stato emarginato il giudiziario, l'esecutivo si ritrova da solo responsabile di un vasto apparato centralizzato per il mantenimento dell'ordine e l'apparato di informazione, diventato sempre più onnisciente, viene riportato sotto il controllo diretto del presidente. Le clausole legali, vaghe e mal definite, conferiscono all'esecutivo un potere discrezionale totale di selezionare gli obiettivi ed agire come intende fare il suo personale dirigente. In tal modo l'esecutivo ha ottenuto: a) i poteri per legiferare (legge di stabilità economica d'urgenza del 2008, EESA), b) il proprio sistema giuridico parallelo basato sulla categoria speciale di "nemico combattente" con la quale designa il criminale e pone in atto un regime di detenzione, di giudizio e di punizione che non si basa su alcuna legge e c) la capacità di assassinare gli individui selezionati dall'esecutivo (Samples, 2010 ; Roach, 2011, p. 208-210, p. 229-231). In effetti, parrebbe che il ritiro del diritto riveli la potenza del sovrano.
Questa potenza viene esercitata intensamente su tutta la popolazione. La legislazione antiterrorista si dimostra estremamente innovativa nella sua capacità di estendere la colpevolezza per associazione. Oltre alla dissociazione fra pena ed atto criminale, un vasto insieme di "associati" può essere sottoposto a delle misure penali nel momento in cui il segretario di Stato o il procuratore generale lo decidono. Nella misura in cui il potere poliziesco cerca di sanzionare il crimine prima che si produca, l'intera popolazione viene compresa, per il fatto che in essa si trovano asserragliati dei criminali potenziali, in una gigantesca rete di informazione. Ciò implica che la presunzione di colpevolezza diviene di fatto valida per tutti. Inoltre, il trattamento legale riservato alle categorie criminali speciali esemplificate da Guantanamo viene rimodellato per poter essere applicato a tutti (a partire dal National Defense Authorization Act del 2012). È a partire da tale categoria chiave dell'antiterrorismo che il sovrano afferma il suo monopolio sulla politica, criminalizzando "l'influenza" politica eccessiva della popolazione sul governo. In breve, il ritiro del diritto significa non solo l'avvento di una potenza sovrana senza limiti ma anche quello di una soggettività che non è più protetta dalla mediazione della legge (vedi ACLU, 2012 ; Belandis, 2004, p. 279-281 ; Boukalas, ch.5-6 ; Mattelart, 2010).
Sembrerebbe che l'antiterrorismo scateni la triade stato d'eccezione/potere sovrano/nuda vita alla sua massima intensità. Quattordici anni dopo l'11 settembre e cinque anni dopo lo scatenarsi di una crisi economica, si può chiaramente affermare che i poteri di "emergenza" sono diventati permanenti. Si trovano sul punto di estendersi, di intensificarsi e di metastatizzarsi dalla politica securitaria alla politica economica. Nel corso di questo breve inizio di secolo, le maggiori situazioni di "emergenza" dell'uno e dell'altro tipo appaiono precipitare ed intensificarsi. La tesi dell'eccezione permanente che si estende a tutte le sfere della vita sociale e che crea la nuova norma sociale, appare del tutto confermata.
Tuttavia, permangono aspetti della sicurezza interna che non rientrano facilmente nello schema dell'eccezione. Per cominciare, la maggior parte delle modalità del potere "sovrano" e non-regolato sull'individuo erano già presenti ed inscritti nell'ordine giuridico ben prima dell'attuale ondata antiterrorista. Ad esempio, il principio della "colpevolezza per associazione" venne inserito nel diritto attraverso la legge sull'antiterrorismo e sulla pena di morte del 1996. La dissociazione della sorveglianza dal sospetto criminale venne introdotta dalla legge sulla sorveglianza dei servizi segreti stranieri del 1978 (FISA) che mirava a regolare delle pratiche messe in atto da decenni. Questi due principi hanno cominciato a colpire la presunzione di innocenza e la loro attuazione è stata lasciata alla discrezione del personale a capo dell'esecutivo.
L'antiterrorismo sistematizza ed intensifica queste modalità e, fatto decisivo, le estende. Inizialmente, tali modalità definivano le relazioni fra lo Stato ed alcune categorie "speciali" della popolazione (la spia, lo straniero ed il "terrorista internazionale"). Il primo poteva negoziare, o perfino rifiutare alle seconde le protezioni legali normalmente accordate alla comunità dei cittadini. L'antiterrorismo estende l'applicazione di queste modalità a tutto l'insieme della popolazione. Con Agamben, possiamo affermare che la regola della categoria eccezionale - la nuda vita - diviene la regola di tutti.
Tuttavia, quest'espansione si sviluppa in maniera incrementale ed organica. Si accompagna a delle revisioni, delle resistenze, delle ritirate e degli affinamenti. Questo procedere si accompagna inoltre ad una tovaglia giuridica che viene stesa per coprire delle nuove parti o tutto l'insieme del corpo sociale, o che ha l'effetto di sbarramento della direttiva. In questo modo vengono introdotti dei poteri coercitivi immensi da applicare a delle frazioni giuridicamente e politicamente marginali della popolazione, per poi essere estesi a tutti, mentre vengono elaborati nuovi poteri ancora più intensi per la categoria speciale, prima che vengono anch'essi estesi a tutta la popolazione, e così via. In ogni caso, siamo ben lontani dal dover affrontare la forza fantasmagorica della decisione sovrana che agita e rifonda l'ordine giuridico esistente.
In realtà, anche se abbiamo conosciuto delle riconfigurazioni maggiori, che sono andate principalmente nella direzione esposta sopra, l'ordine giuridico non è stato mai sospeso. Anche se l'amministrazione Bush ha effettivamente presentato gli avvenimenti dell'11 settembre come un momento di emergenza esistenziale, essa si è mostrata reticente ad essere percepita nei fatti come un governo "che agisce con risoluzione e fermezza". Nessuna sezione della costituzione è stata sospesa o aggirata. Immediatamente mobilitato per conferire all'esecutivo dei poteri schiaccianti ed arbitrari, il Congresso lo ha fatto prontamente. Da questo punto di vista, l'insieme del corpo legislativo antiterrorista prodotto nella foga dell'11 settembre smentisce giuridicamente e politicamente la tesi del decisionismo e della concentrazione di tutti i poteri in un'unica entità che avrebbe preso il comando nell'eccezione. Il "sovrano" mira piuttosto a concedersi un potere discrezionale a partire dal diritto e ad inscriversi in tale potere attraverso la mobilitazione intensa del legislativo e, occasionalmente, del giudiziario.
Anche le pratiche più eccessive intraprese dalle amministrazioni Bush ed Obama (ad esempio, gli omicidi extra-giuridici) vengono difesi in termini legali come poteri concessi dal Congresso (nella legge relativa all'autorizzazione dell'uso della forza militare del 2001). La sorveglianza delle comunicazioni da parte della National Security Agency (NSA) del Pentagono è autorizzata da un mandato della corte segreta FISA. Anche in un caso emblematico di pratica eccezionale come Guantanamo, l'assenza del diritto viene compensata per mezzo di un labirinto di regolamenti extra, quasi e pseudo legali (Johns, 2005). Questi regolamenti sono stati inizialmente elaborati dalla Casa Bianca e dal Pentagono, ma sul filo di ripetute triangolazioni fra i tre rami hanno finito per entrare nel corpo principale del codice giuridico (Roach, 2011, p. 200-211). In sintesi, l'invocazione dell'emergenza non porta ad un'impennata decisionista ma ad un "obbligazionismo" particolare, in virtù del quale l'esecutivo afferma di essere costretto ad agire. La sua azione viene allora immediatamente codificata, messa in procedura e legalizzata. La decisione viene negata, insieme alla responsabilità che essa comporta (Johns, 2005).
Struttura nuda
Nell'analisi della politica antiterrorista e, più in generale, nell'analisi delle modalità contemporanee del potere, più che le contraddizioni fattuali summenzionate, è la debolezza teorica della tesi dell'eccezione che bisogna sottolineare.
Affermando potenzialmente il primato della politica sul diritto e riconoscendo la politica come la fonte della legge, la tesi dell'eccezione dirige la nostra attenzione verso la violenza che sottende l'ordine giuridico e suggerisce un certo arbitrio per quel che riguarda le basi della vita sociale. Di conseguenza, costituisce un contrappunto alla negazione, da parte della giurisprudenza anglosassone, dell'arbitrarietà del diritto, del suo carattere politico e della sua fondazione ultima sulla forza, così come alla sua dipendenza da quest'ultima. A partire da questo, i problemi proliferano e si accumulano per quel che concerne la sua comprensione della politica e del diritto, la sua utilità analitica e la sua validità teorica.
In primo luogo, per quel che concerne la politica, la costruzione schmittiana del sovrano come corpo singolare che incorpora organicamente e che esprime l'integralità di un "popolo" pre-politico è altamente idealista e, di fatto, mitologico. Inoltre, la politica viene ridotta alla controversia, ossia alla distinzione amico/nemico (Schmitt, 1988, 1923, p. 38-44, p. 49, 1996, p. 16-32, 2004 ; Papacharalambous, 2009, p. 21, p. 27-29). Se per Schmitt la politica viene ad essere impoverita dall'assorbimento del sociale nello Stato, cosa che genera "il Politico", in Agamben il sociale è semplicemente del tutto assente. Per Agamben, la politica consiste nella gestione da parte del sovrano della nuda vita, una vita privata di ogni rapporto sociale. Similmente, ogni politica significativa (il Politico?) consiste nell'affermazione anomica della vita in quanto fatto radicale, contro e al di là delle mediazioni, dei rapporti e dei significati sociali. Mettere al centro della politica una vita desocializzata rende la politica del tutto autonoma nei confronti della società e la riduce alla semplice esistenza (Huysmans, 2008, p. 174-180 ; Seymour, 2013). Il suo carattere di processo antagonista avente come sfida l'istituzione della vita collettiva viene negato, non solo perché in assenza del sociale la politica non ha oggetto, ma anche perché la nuda vita annulla la possibilità stessa dell'antagonismo e della lotta. Quest'ultima è concepibile solamente nel contesto di rapporti, significati, forme e mediazioni socio-storiche specifiche. La nuda vita non può lottare. Vedere una simile lotta nella resistenza di persone che "vivono nude", concentrate nei campi, le labbra e le palpebre cucite, torna ad occultare il senso dato a questo atto, quello che gli altri gli assegnano ed il fatto che è questa dinamica di significati sociali che trasforma questo atto, come tutti gli altri, in un gesto politico (Huysmans, 2008, p. 177). In sintesi, svuotare la politica del suo carattere sociale ne nega la sua possibilità stessa.
In secondo luogo, la distinzione normalità-eccezione appare meno chiara di quanto possa sembrare. Il sovrano - il concetto-limite che porta dalla normalità all'eccezione - appare essere più ben inserito nella legge di quanto suppongano Schmitt ed Agambem. Non solo il sovrano si vede conferire dal diritto la capacità di agire nell'eccezione, nella misura in cui la sua condotta è strettamente orientata verso la preservazione dell'ordine sociale e normativo, ma le sue esigenze, poteri ed azioni devono inoltre essere radicati nel diritto per non rimanere sospesi e senza conseguenze. Questo non ha niente di particolarmente eccezionale. Il diritto non è un testo finito e congelato ma piuttosto costituisce un processo dinamico di determinazione e di decisione. Si elabora continuamente nel rapporto con quello che è esterno al suo contenuto, attraverso l'incorporazione del suo infinito esterno (Fitzpatrick, 2005, p. 61-63).
Ciò che caratterizza l'antiterrorismo è non solo il bisogno insopprimibile dell'esecutivo federale americano di legiferare perfino sui suoi più arbitrari poteri, ma anche la reazione dei più grandi costituzionalisti americani rispetto alla politica antiterrorista. Sia che propongano una drastica separazione dei poteri di emergenza di ordine costituzionale al fine di mantenere l'integrità di quest'ultimo (Gross, 2003), difendendo l'incorporazione di procedure d'urgenza dettagliate nella costituzione al fine di evitare degli abusi (Ackerman, 2006), o che suggeriscano di ripensare in maniera radicale l'integrità della struttura istituzionale in carica della gestione delle situazioni d'emergenza (Scheuerman, 2002), questi giuristi dimostrano che la legge si (ri)crea costantemente ispirandosi alle sue esternalità. Nel caso presente, l'esternalità cui la legge si ispira è la sua sospensione stessa nell'eccezione.
In terzo luogo, gli argomenti precedenti rimettono in discussione l'utilità concettuale stessa dell'eccezione. Qui, l'espansione incessante dei poteri eccezionali al fine di coprire una gamma ancora più ampia di fenomeni sociali (dalla guerra e dall'insurrezione popolare ai conflitti lavorativi, ai crimini politici, alle crisi economiche e nuovamente all'insurrezione popolare) e la loro reintroduzione nel corpo principale del diritto ha offuscato in maniera significativa la distinzione fra la regola e l'eccezione (Scheurman, 2000 ; Neocleous, 2006).
Da qui emerge un paradosso concettuale. Se la sospensione della norma è inclusa nel diritto ed autorizza un agente politico consacrato ad agire in un quadro di eccezione, ne consegue che la sospensione dell'ordine giuridico stabilito è inscritta in questo stesso ordine giuridico. Pertanto, quest'ultimo rimane valido nel mentre che viene sospeso: sospendendo l'ordine giuridico, l'eccezione lo mantiene. Viceversa, è solo nella misura in cui l'ordine giuridico stabilito si mantiene nell'eccezione che quest'ultima può essere concepita giuridicamente. Quindi, il concetto di stato d'eccezione permanente diventa assurdo: implicherebbe la costruzione di un ordine giuridico e di una giurisprudenza (accompagnata da un sistema legale, da una costituzione, ecc.) sulla base dell'eccezione. Un simile ordine giuridico non consisterebbe in nient'altro che nell'affermazione che può essere sospeso in qualsiasi momento. Allo stesso modo, la sua giurisprudenza concluderebbe che non c'è affatto bisogno di distinguere rigorosamente la regola dall'eccezione e che i concetti legali come la giurisprudenza sono di conseguenza superflui (Kondylis, 1994, p. 138-141).
In quarto luogo, conviene attardarsi sul concetto di "nuda vita". Nell'estrarre l'homo sacer come forma di vita archetipica che per il diritto è esclusa dal diritto, Agamben sembra non essersi accorto del suo significato nel diritto romano originale, L'homo sacer è già sacrificato. Di conseguenza, Il suo destino si trova pienamente inscritto e regolato dal diritto (Fitzpatrick, 2005, p. 51-52). Facendo della nuda vita dell'homo sacer «il primo paradigma della sfera politica occidentale», Agamben ignora la sua scomparsa dal diritto a far tempo dalla fine dell'Impero romano. Stabilisce dei tenui legami con la condizione di figlio, rispetto al padre, nel diritto romano tardivo, o con il principe dell'habeas corpus nell'Inghilterra medievale e trascura così il fatto che queste forme erano pienamente e totalmente integrate al diritto (Agamben, 1998, p. 87-89, p. 123 ; Fitzpatrick, 2005, p. 54-56).
Oltre ad essere mal costruita sul piano concettuale, il concetto di nuda vita è difficile da cogliere nella misura in cui si tratta di un'essenza estensiva ed indifferente alle forme, cosa che rende improbabile la sua demarcazione (Fitzpatrick, 2005, p. 65). Se essa appare precaria nei confini del diritto, diventa impossibile al di fuori dello stesso. Il solo modo di fondare la nuda vita in quanto non soggettività, del tutto passiva di fronte al potere sovrano e spogliata di ogni rapporto, mediazione ed appartenenza politica e sociale, è quello di negare il politico ed il sociale (Laclau, 2007, p. 14-16 ; Negri, 2007, p. 75 ; Mills, 2008, p. 90-92 ; Neal, 2010, p. 123). La messa in discussione del concetto di nuda vita destabilizza anche il concetto di potere sovrano nella misura in cui la prima costituisce l'oggetto del secondo. Infatti, tenuto conto del carattere reciprocamente costitutivo della nuda vita, del potere sovrano e dello stato di eccezione, la costellazione politica di Agamben appare dubbia.
In quinto luogo, in Agamben, la norma rimane non teorizzata. Contrariamente a Schmitt che porta avanti la sua analisi dell'eccezione in tandem con un'analisi dello Stato capitalista e del diritto liberale, Agamben non si interessa quasi alla norma. Quest'ultima è deprivata di ogni contenuto, essa costituisce una stampella per far stare in piedi la tesi dell'eccezione. L'assenza di teorizzazione per quel che riguarda la norma influenza il concetto di eccezione: non sappiamo mai a cosa l'eccezione fa eccezione. Assume un significato fluttuante capace di adottare qualsiasi contenuto sostanziale. Ad esempio vediamo che in epoca romana l'eccezione (iustititum) significava che il Senati autorizzava i cittadini a fare tutto ciò che loro consideravano necessario per salvare la Repubblica (Agamben, 2005, p. 41). Nell'America post-11 settembre, l'eccezione significa la messa in quarantena e l'occupazione dello spazio pubblico da parte delle forze armate dello Stato. Il medesimo concetto di eccezione si applica così a due realtà opposte. Queste due situazioni eccezionali sono diametralmente opposte l'una all'altra in quanto costituiscono delle eccezioni a delle norme giuridico-politiche differenti. L'eccezione definisce forse la regola ma è vero anche il contrario. Si pone la questione di sapere in quale misura un concetto può essere credibile quando non esiste che un opposizione ad un altro concetto che non viene mai definito o descritto.
In sesto luogo, il vuoto sostanziale di questo concetto chiave è la ripercussione a livello concettuale del fondamentalismo strutturale di Agamben, un contraccolpo epistemologico. Il suo metodo consiste in un lavoro di scavo ricostruttivo all'interno delle strutture (la legge, il linguaggio) volto a localizzare i momenti originari di concetti che, in maniera assai lasca e semicosciente, determinano la vita sociale attraverso la storia (Agamben, 2009). Egli svuota sistematicamente le sue categorie e concetti del loro contenuto socio-storico, cercando così di renderli eterni, sempre e per sempre validi (Papachalalambous, 2009, p. 105). La sua "correzione" del trattamento foucaultiano della biopolitica ne è un buon esempio: un'analisi socio-storica non è sufficiente, essendo il potere "sempre" biopolitico (Agamben, 1998, p. 11). Il trittico nuda vita/potere sovrano/stato di eccezione non si riferisce ad alcun rapporto o processo sociale. Si tratta di un effetto strutturale, di un gioco logico in seno a delle strutture nude (vedi Rasch, 2007, p. 92-94). Scoprendo (o costruendo) l'origine di un concetto, Agamben lo pone come valido trans-storicamente (Laclau, 2007, p. 11) - in particolare, se l'origine del concetto si situa nella "vita pre-sociale" (sic!) come è il caso della nuda vita (Agamben, 1998, p. 104).
Malgrado ciò, la specificità storica non solo rischia di divergere dal concetto ma anche di indebolirlo. È il caso del "sovrano" nel contesto giuridico-politico feudale, che, nonostante l'appellativo di "sovrano assoluto", rimanda ad una figura dalle competenze estremamente limitate e strettamente definite e che non poteva assolutamente fondare il diritto, ed ancor meno i principi fondamentali dell'ordine sociale (Kondylis, 1994, p. 171-172).
Ancora più importante, quando il concetto di norma si trova vuoto del suo contenuto sociale, il gioco delle omologie strutturali non funziona più. Poiché la norma non è altro che contenuto socio-storico specifico, essa non può esistere come nuda struttura. Senza il contenuto, la norma non esiste che in quanto corollario dell'eccezione. Ma quest'ultimo status presume di trarre il suo contenuto dal suo essere in rapporto alla norma. Se la norma è vuota allora lo è anche l'eccezione. Come distinguere le due cose? Guardando ad alcune strutture, come il linguaggio ed il diritto. Ma queste non vengono trattate come se fossero delle pratiche sociali dinamiche e dei campi di antagonismo contestati (alla maniera di Gramsci, per esempio) bensì come strutture fossilizzate. Ci si ritrova con una norma intonacata in un concetto giuridico continuo ed astratto con il quale l'eccezione rompe giuridicamente. La teorizzazione dell'eccezione ha come premessa la feticizzazione dell'ordine giuridico.
In settimo luogo, il concetto di eccezione considerato come una rottura con l'ordine giuridico e combinato ad una concezione di politica come violenza sovrana rischia di ri-istituire l'illusione liberale di un diritto (la norma) che esisterebbe separatamente dalla politica e sarebbe libero dalla violenza. In questo modo si oscura l'esistenza concreta del diritto: un'organizzazione particolare (e politica) del territorio, degli oggetti e delle modalità della violenza (Poulantzas, l1978 ; Neocleous, 2006, p. 76-77, p. 91-92). In altri termini, la visione agambeniana dell'eccezione rischia di disfare ciò che il concetto di "stato di eccezione" cerca di cucire.
Questo pericolo è soprattutto presente in Schmitt, in quanto per Agamben lo stato di eccezione costituisce assai più di una piattaforma per criticare il liberalismo. Egli suppone che riveli l'essenza del potere, la sua forma originaria e la sua struttura nascosta, incapsulata nei rapporti fra il potere sovrano e la nuda vita (Agamben, 1998, p. 9, p. 26, p. 84, 2005, p. 86, 2011, p. 245 ; Norris, 2005, p. 59-61, p. 64, p. 72 ; Mills, 2008, p. 65 ; Murray, 2010, p. 262). Quest'essenza è impermeabile al tempo e alla società. Agamben ignora l'esistenza del diritto e della politica in quanto fenomeni sociali, al fine di produrre un'analisi del puro potere. L'errore costitutivo della tesi dell'eccezione consiste nella giustapposizione di un "sovrano" antropomorfico che agisce di sua propria volontà e di sua propria iniziativa e di un "individuo" atomizzato e strappato dagli insiemi di significati, legami e rapporti sociali nei quali egli esiste (Whyte et al., 2010, p. 148). Una volta estratti dalle loro dinamiche, strutture e pratiche sociali, il diritto, lo Stato e l'individuo formano delle pseudo-entità, e le analisi delle loro interrelazioni "normali" o "eccezionali" diventano delle caricature.
In ottavo luogo, la pertinenza analitica dell'analisi agambeniana del potere al fine di pensare la politica moderna è incerta. La tesi di Agamben non ci permette ma ci costringe ad esaminare la repubblica romana, la Germania nazista e la sicurezza interna americana (e letteralmente tutto ciò che si situa fra questi periodi) con gli stessi strumenti analitici. In effetti, a rigor di termini, questi differenti periodi rilevano la medesima cosa e non possono essere differenziati se non per il grado di rivelazione della vera natura del potere in ciascun caso (vedi Scheuerman, 2006, p. 69). Sganciando la sua argomentazione da un ancoraggio alla specificità storica, Agamben ci priva della capacità di guardare alle ragioni per le quali e alle modalità attraverso le quali lo stato di eccezione viene attivato. In ogni caso, il bios viene ridotto alla nuda vita su cui il sovrano esercita la sua violenza.
Il risultato è una profonda aporia nel momento in cui la tesi dell'eccezione si confronta con l'attualità, ivi compresa quella della sicurezza interna. Per esempio, allorché la decisione del sovrano è presa, noi ignoriamo chi sia il sovrano. Quando perfino la sua identità verrebbe specificata dalla legge, non esiste garanzia che l'entità in questione determini effettivamente l'azione. Cosa succede, ad esempio, se la mobilitazione dell'eccezione da parte del sovrano genera un colpo di Stato dell'esercito contro il suo capo supremo? Si tratta di un'eccezione in seno all'eccezione o di un dislocamento del luogo di potere del sovrano? In questo secondo caso, in quale momento cessa questo dislocamento e come possiamo determinato che esso abbia effettivamente avuto fine? Ancora più importante, il presidente degli Stati Uniti è il "sovrano"? Il ramo esecutivo (o le sue forze armate) che egli presiede costituisce un'entità singolare, unitaria? Il presidente deve superare, reprimere e riconciliare le divisioni e gli antagonismi interni all'esecutivo? Qual è la portata della decisione del sovrano? Sono tutti influenzati in egual modo da questi? Inoltre, il sovrano è un soggetto dotato di una volontà e di interessi propri oppure si trova legato agli antagonismi ed agli interessi che caratterizzano in maniera più ampia la società? Nel primo caso che cos'è che motiva il sovrano? Questa motivazione è sempre la stessa per tutti i sovrani di tutti i tempi? Nel secondo caso, sarebbe possibile che il sovrano agisca per conto dei "potenti" che operano all'ombra delle istituzioni? Il carattere dei loro interessi influenzerebbe le modalità, l'intensità, l'estensività, la durata ed il fine dell'eccezione ed il suo stesso innescarsi? Un'eccezione dichiarata da un sovrano "catturato" da delle grandi compagnie petrolifere sarebbe la stessa che un'eccezione "catturata" da degli insegnanti di scuola? (E perché il primo scenario appare più plausibile del secondo?). Inoltre, anche se fosse concepibile, la riduzione alla nuda vita (lo strappare l'individuo alle sue mediazioni legali ed alla sua capacità politica) costituisce il momento in cui il potere sovrano si forma, o quello dove quest'ultimo collassa (Boukalas, 2012a, p. 292-293) ? Infine, perché la normalità esiste tout court? Perché il portatore di un potere enorme lo utilizza solo occasionalmente? (Colatrella, 2011).
La capacità da parte della tesi dell'eccezione di fornire una risposta a questi interrogativi appare incerta. Sembrerebbe che facendo astrazione del contenuto sociale e storico dei suoi concetti, Agamben non sia in grado di fornire delle strutture che lo potrebbero alimentare per mezzo di una realtà socio-storica specifica. Al contrario, il contenuto socio-storico mina queste strutture vuote: il prezzo dell'essenzialismo è l'impermeabilità ad ogni realtà storica.
Lo Stato ed il diritto della società - un approccio strategico-relazionale
Un tentativo di pensare le modalità contemporanee del potere politico, in particolare relativamente a come sono riconfigurate dalla politica antiterrorista, potrebbe indubbiamente avere come fondamento delle posizioni epistemologiche opposte all'essenzialismo. Si tratterebbe di concettualizzare il diritto, la politica e la loro interrelazione in quanto fenomeni sociali dinamici determinati da, e condizionanti, i rapporti di antagonismo sociale in delle congiunture storiche specifiche. Ne risulterebbe una concezione del potere in termini di articolazioni storicamente variabili dei rapporti sociali, piuttosto che come un effetto strutturale antistorico. Una simile posizione concettualizzerebbe la norma e l'eccezione relativamente a delle configurazioni differenti del potere sociale. A tal fine, propongo un approccio "strategico relazionale" (ASR) dello Stato e del diritto. Lo spostamento concettuale implica che l'ASR generi una mutazione terminologica: si passa dal sovrano alla forma-Stato, dalla nuda vita alle dinamiche sociali, dall'eccezione alla crisi e dallo stato di eccezione allo statalismo autoritario.
L'ASR concettualizza lo Stato, non come una soggettività sovrana dotata di una volontà e di un potere proprio ma come un rapporto sociale. Lo Stato è il risultato di dinamiche sociali, esso costituisce il terreno su cui queste si giocano così come un'importante forma di agenzia in seno a tale spazio. Lo Stato è creato dall'antagonismo sociale. Le sue istituzioni permettono la riproduzione del dominio di certe forze sociali su altre. Esso non possiede il potere. Il potere dello Stato è piuttosto una condensazione di dinamiche sociali mediate da delle istituzioni statali. Così, lo Stato forma un terreno ineguale di antagonismo sociale. Le forze sociali lottano per la definizione del potere dello Stato catturando, aggiustando, influenzando, abolendo e creando delle istituzioni statali. Inoltre, lo Stato costituisce un agente chiave nell'antagonismo sociale. Seleziona, combina ed appoggia le strategie di certe forze sociali in seno al potere dello Stato (e ne esclude e disorganizza altre). Il suo essere agenzia non è affatto volto a garantire i suoi propri interessi o a promuovere la sua propria potenza ma a sostenere le forze sociali che sono rappresentate in maniera predominante in seno alle istituzioni (per delle trattazioni più dettagliate dell'ASR dello Stato, vedi Poulantzas, 1978, p. 191-367 ; Jessop, 1990, 2008).
Similmente, un approccio strategico-relazionale considera il diritto come un rapporto sociale. Il sistema giuridico assicura la riproduzione durevole e relativamente pacifica del dominio di alcune forze su altre. Il contenuto del diritto è una doppia codifica delle dinamiche sociali: quest'ultime sono mediate soprattutto attraverso la materialità istituzionale dello Stato e in seconda battuta per mezzo del sistema giuridico. Ciò fa del diritto un terreno e un obiettivo dell'antagonismo sociale oltre che un vettore chiave dell'intervento statale sullo stesso. Inoltre, il diritto viene creato dallo Stato e rappresenta il quadro fondatore della sua istituzionalità, del suo potere (così come dei limiti di questo) e dei suoi rapporti con la società, al di là del suo quadro istituzionale. Quindi, il diritto costituisce una codifica particolare delle dinamiche non solo sociali ma anche statali (Boukalas, 2014, ch. 2).
Anche una presentazione così ellittica dell'ASR, destinata soprattutto a marcare la nostra distanza rispetto alla prospettiva di Agamben, ci può aiutare a porre di nuovo la questione dell'eccezione. La capacità dello Stato di allargare i limiti del sistema giuridico, avverando così la questione dell'eccezione, deriva dal suo rapporto con il diritto nella misura in cui ne costituisce il suo produttore ed il suo esecutore principale. Può negoziare, modificare, emendare, sospendere o abolire il diritto in quanto lo produce e lo implementa. Così facendo, lo Stato non è una cosa (un effetto strutturale come per Agamben) né un soggetto (il sovrano, come in Schmitt) ma una particolare articolazione ed essere agenzia nelle dinamiche sociali. La dichiarazione o meno, da parte del sovrano, dello stato di eccezione, il contesto, il contenuto, l'intensità, la durata e gli obiettivi del momento eccezionale così come il sostegno, la tolleranza e la resistenza da parte delle diverse forze sociali che determinano il successo delle misure eccezionali: tutto ciò dipende dalle configurazioni socio-storiche fra forze sociali e dal modo in cui esse sono rappresentate in seno allo Stato.
Allo stesso modo, piuttosto che apparire come controparte sotto-teorizzata dell'eccezione, la normalità costituisce una configurazione stabile delle forze sociali oltre che il quadro della riproduzione e dell'evoluzione ordinata di tale configurazione. Sotto quest'angolatura, l'eccezione costituisce precisamente il momento in cui l'antagonismo sociale non può più essere contenuto dentro le sue espressione istituzionalizzate, che sono lo Stato ed il diritto, sia perché la conflittualità è troppo acuta sia perché le istituzioni politiche sono troppo rigide. Quindi, piuttosto che costituire un momento di ri-creazione dell'ordine sociale, l'eccezione significa al contrario la difesa ostinata da parte dello Stato di tale ordine di fronte alla minaccia rappresentata dalla popolazione (vedi Kondylis, 1994, p. 16 ; Laclau, 2007, p. 157-158, p. 175).
La natura della minaccia e quella dell'ordine, la soglia a partire dalla quale l'ordine di trova ad essere "minacciato", tutto questo è socio-storicamente specifico. Il concetto di crisi potrebbe qui fornire un correttivo al concetto apertamente astratto e strutturalista dell'eccezione. Innanzitutto, la crisi può essere specificata a partire da quel che attiene alle sue forma. La crisi politica, in particolare, può prendere (e combinare) la forma di una crisi dello Stato, della legittimità, della rappresentanza, della legalità, ecc. Tener conto di questo, ci permette di meglio situare la discussione attorno alla «eccezione». In secondo luogo e soprattutto, la crisi è l'opera delle forze sociali. Anche se ogni organizzazione sociale, economica e politica contiene le sue tendenze alla crisi, quest'ultima non esplode a meno che l'antagonismo sociale non trasformi tale tendenze in attualità (Poulantzas, 1976a). In questo contesto, il problema del rapporta fra la regola e l'eccezione si trasforma in interrogativo sulle forme normali o eccezionali dello Stato e sulle forme giuridiche associate.
Le forme dello Stato - normali ed eccezionali
La statualità, ossia il concetto ed il processo di costituzione di uno Stato, implica una divisione radicale del lavoro politico: la capacità formale, frutto di un accordo collettivo oppure imposto, di istituire, organizzare, dirigere ed amministrare la vita sociale viene estratta dalla società e viene monopolizzata da un sistema istituzionale particolare, lo Stato (Castoriadis, 1983).
Al di là di questa caratteristica specificante, una discussione intorno allo (o una teoria dello) Stato "in generale" avrebbe poco senso, tenuto contro del fatto che si riferirebbe simultaneamente all'impero persiano, alla Spagna del 14° secolo o alla Svezia del 20°... Questi ultimi costituiscono in effetti tutti degli Stati. Una tipologia degli Stati in funzione del rapporto sociale principale su cui si basano e che hanno come funzione quella di riprodurre, ci aiuterebbe a mettere in evidenza la loro rispettiva peculiarità. La discussione ci porterebbe allora su dei tipi di Stato, lo Stato feudale, il dispotismo orientale, la teocrazia, l'impero, la monarchia assoluta, ecc. (Poulantzas, 1973, p. 142-167). Qui, tratto degli Stati Uniti contemporanei in quanto Stato capitalista, un tipo specifico per la sua istituzione sulla base della separazione di politica ed economia ed orientato verso l'organizzazione di forme sociali e politiche che garantiscano l'accumulazione del capitale (Poulantzas, 1973, p. 355-358, 1978, p. 37-42 ; Jessop, 1990, 2002, p. 187-152 ; Neocleous, 2000, p. 190-194).
Tuttavia, l'identificazione di un tipo di Stato non permette del tutto di trattare lo Stato dato in un momento storico specifico. Le tipologie si espandono nel tempo e nello spazio (in una prospettiva centrata unicamente sul tipo, l'Olanda del 18° secolo e la Malesia del 21° verrebbero trattati come degli equivalenti in quanto appartengono entrambi al tipo capitalista) e non si presentano mai in forma pura. Residui di tipi storici precedenti possono essere preservati e dimostrarsi necessari per la costituzione del tipo presente di Stato. Inoltre, degli Stati specifici possono appartenere a più tipi: uno Stato patriarcale può essere anche capitalista (ad esempio, l'Arabia Saudita), uno Stato capitalista può anche essere razziale (ad esempio, l'apartheid in Sud Africa), ecc. (Poulantzas, 1973, p. 108-109 ; Koch et al., 2011, p. 70-73).
Così, quando si guarda a degli Stati specifici, la questione del loro tipo passa in secondo piano e quella della loro forma diventa centrale. Qui il termine di forma-Stato si riferisce all'articolazione storica specifica del rapporto fra l'apparato dello Stato ed il potere statale, fra la struttura e la strategia statale, e fra lo Stato e la società situata "al di fuori" delle sue istituzioni (Jessop, 1990, ch. 2 ; Boukalas, 2014, p. 252-261).
Per quel che attiene allo Stato di tipo capitalista, si possono distinguere due forme: normale (ad esempio, la forma liberale-parlamentare o amministrativo-sociale) ed eccezionale (ad esempio, il fascismo o le dittature militari). Le forme normali si caratterizzano per la separazione dello Stato dalla società civile da una parte e la separazione dei poteri in seno allo Stato dall'altra. I rapporti fra i diversi rami dello Stato da un lato e fra lo Stato e la società civile dall'altro, sono regolati dalla legge. La società civile interviene (le forze sociali canalizzano le loro richieste) nello Stato attraverso dei vettori istituzionali come i partiti, ii sindacati, le lobby, le ONG ed altri. Questa soluzione rende le forme normali stabili, elastiche e in grado di accogliere cambiamenti delle configurazioni in senso alle forze sociali (Poulantzas, 1973, p. 229-252, p. 296-303).
Viceversa, le forme eccezionali rompono, secondo gradi differenti, la separazione dei poteri e concentrano il potere dello Stato nelle mani dell'esecutivo - militare, poliziesco e/o i vertici dell'amministrazione. Esse perturbano la separazione fra Stato e società civile e (attraverso l'incorporazione e la repressione) sottomettono quest'ultima al controllo statale. Così, le forme eccezionali tendono ad esercitare il potere non solo attraverso il diritto ma anche per mezzo di decreti esecutivi. Le forme eccezionali scattano quando l'intensità dell'antagonismo sociale non può più essere contenuto nei canali istituzionali esistenti, cosa che minaccia il proseguimento dell'ordine capitalistico. Esse sopprimono l'antagonismo sociale e di conseguenza non possono accogliere dei cambiamenti in seno alla configurazione delle forze fra le frazioni del capitale, o fra quest'ultime e le classi subalterne. Ciò rende le forme eccezionali instabili ed inclini alla crisi. Quando avvengono dei cambiamenti significativi nella configurazione delle forze al di fuori (necessariamente) dello Stato, quest'ultimo, una volta che la sua capacità coercitiva viene superata dalla situazione, crolla. Questo genere un momento di indeterminatezza radicale che può minacciare il proseguimento del dominio capitalista e, di conseguenza, il carattere capitalista dello Stato (Poulantzas, 1974, p. 313-329, 1976a).
Anche ad un livello così generale, la discussione intorno ai tipi e alle forme di Stato porta a riconfigurare il dibattito intorno all'eccezione, soprattutto orientandoci verso l'analisi della norma, cioè di quello cui l'eccezione fa eccezione. Una tale prospettiva mette in evidenza la pluralità dei modi di organizzazione del potere politico, essendo ciascuno caratterizzato dalle sue proprie configurazioni eccezionali. Ne consegue che l'eccezione di un modo di organizzazione politica (ad esempio, la repubblica romana) ha poco in comune con l'eccezione di un altro modo (ad esempio, la sicurezza interna agli Stati Uniti). Inoltre, l'insistenza su questa pluralità di costellazioni di potere che risultano da una combinazione di forme (normali ed eccezionali) di diversi tipi di Stato si oppone alla riduzione delle modalità di potere ad una dicotomia unica e trans-storica norma/eccezione.
La questione è ora quella di sapere se gli Stati Uniti contemporanei costituiscono una forma-Stato eccezionale-dittatoriale oppure normale-democratica. È difficile sostenere che attualmente gli Stati Uniti siano una dittatura. Le istituzioni della democrazia politica mantengono la loro forma e continuano a funzionare normalmente. Non vi sono tentativi di annullare la democrazia, ma piuttosto di trasformarla portandola cerso delle forme più oligarchiche. Questo progetto è stato intrapreso dai due partiti dominanti ed è il risultato di un consenso politico e non di un acuto antagonismo. Inoltre, non c'è alcun fallimento dei partiti e delle reti politiche esistente per quel che riguarda il loro lavoro di rappresentanza della classe dominante (Poulantzas, 1974, p. 122-123 ; Belandis, 2004, p. 71-88).
Tuttavia, sembra comunque difficile negare l'indurimento autoritario dello Stato in tutte le sfere di attività, dai poteri giuridici alle rappresentanze politiche, dalle modalità di mantenimento dell'ordine alla costruzione di piattaforme di cittadini e dalla ristrutturazione istituzionale allo schiacciamento dell'opposizione sociale. Queste tendenze antidemocratiche sono persistenti e sistematiche.
Sembrerebbe che ci troviamo di fronte ad una forma-Stato ibrida. Questo ci porta ad affrontare lo statalismo autoritario.
Lo statalismo autoritario - I e II fase
Il termine statalismo autoritario (SA) venne elaborato da Nicos Poulantzas alla fine degli anni 1970, per dar conto dei cambiamenti in seno allo Stato provvidenza keynesiano che mirava a contrastava la crisi. La tendenza generale di questa mutazione - e le caratteristiche che specificano la forma SA - consiste in un controllo statale esteso ed intensificato della vita sociale, combinato ad una restrizione delle libertà democratiche e, in maniera più generale, della capacità della popolazione di influenzare il potere statale. Lo statalismo autoritario è una forma normale dello Stato capitalista, che, tuttavia, incorpora, combina e rende permanenti molteplici elementi autoritari (Poulantzas, 1978, p. 203-204, p. 209).
Nella prima fase (inizio degli anni 1970), lo SA è caratterizzato da un trasferimento di potere dal legislativo verso l'esecutivo e dalla sua concentrazione nei vertici più altri di quest'ultimo di modo che le funzioni di governo si trovano ad essere monopolizzate dal presidente o dal gabinetto. Il declino del legislativo è in parte responsabile dell'erosione di un quadro giuridico stabile, astratto ed universale cosi come della proliferazione di leggi ad hoc e post hoc e delle prerogative esecutive. Col declino dei parlamenti, l'elaborazione della strategia e la decisione politica avviene sempre più in seno ad una rete di potere parallela e nascosta, formata da più forum che trascendono i diversi rami statali ed aggirano i canali formali della rappresentanza in seno allo Stato. Inoltre, il ruolo dei partiti politici viene invertito: le piattaforme in cui i membri della società potevano suggerire e perfino imporre alle istanze dirigenti delle politiche, si trasformano in cinghie di trasmissione che trasmettono le decisioni dei dirigenti ai membri della società. Questa inversione si combina con l'avvento dei media di massa che diventano il meccanismo ideologico predominante. Nella misura in cui avviene il declino di parlamenti e partiti, si assiste ad un'inflazione dell'amministrazione che si impone come il luogo chiave dell'elaborazione delle politiche e dell'antagonismo sociale. La burocratizzazione della politica implica un cambiamento della legittimità statale che ora si fonda su una base burocratico, a detrimento del concetto "d'interesse generale". Infine, la coercizione si indurisce. Il potere poliziesco ha ora per oggetto innanzitutto la "mentalità" dell'individuo e "l'obiettivo del controllo che oscilla dall'atto criminale alla situazione criminogena, dal caso patologico all'ambiente patogeno". La prevenzione diventa così una strategia di mantenimento dell'ordine. Inoltre, viene costituito un arsenale giuridico, marziale ed amministrativo al fine di impedire le lotte popolari. Rimane "nascosto" e "in attesa" e viene mobilitato solo contro le manifestazioni di acuto antagonismo (Poulantzas 1976b, p. 321-322, 1978, p. 186, p. 210, p. 217-241 ; vedi anche Jessop 1985, p. 285-287, 2011, p. 48-51).
Il periodo degli anni 1980 e 1990 è segnato da un contrattacco capitalista continuo, guidato dalla finanza e che viene esercitato sulla base di una piattaforma ideologico-politica neoliberista. L'autoritarismo statale rimane la piattaforma dominante ma viene regolato in maniera significativa al fine di accogliere e promuovere l'equilibrio delle forze sociale in via di mutamento: entra nella seconda fase. La strategia principale dello Stato si costruisce ora intorno all'idea del "Workfare" [*3]. Sulla base di una concettualizzazione del lavoratore inteso come costo di produzione (anziché come una fonte di rivendicazioni), viene posta in essere una drastica concentrazione di ricchezza sociale attraverso la stagnazione dei salari e delle pensioni, lo smantellamento della protezione giuridica degli occupati, la flessibilità temporanea e part-time, la tassazione regressiva e la restrizione della protezione sociale. I sindacati vengono esclusi dai forum politici, e come unico interlocutore dello Stato rimane il capitale. In tale contesto, da garante dell'aiuto sociale e come istigatore della domanda generale, lo Stato si trasforma in coordinatore di un'economia privatizzata ed in un esecutore della deregolamentazione.
Inoltre, la scala nazionale cessa di costituire l'ambito predominante della strategia politica ed economica. Di conseguenza, lo Stato deve iniziare, orchestrare, legittimare e rispondere agli sviluppi in seno ed al di là dei diversi livelli di attività socio-politica (locale, regionale, nazionale ed internazionale). Il coordinamento della politica a livello ed entro le sue sfere viene assunto da dei meccanismi di governance pubblici-privati (la "rete parallela") a scapito delle catene di comando gerarchico (Jessop, 2002). In tal modo si modifica il mantenimento dell'ordine. Sempre più determinato da degli organi di governance, la sua missione diventa quella di salvaguardare il capitale presente nello spazio pubblico (Garland, 2002). Infine, questa fase è caratterizzata dal ritiro del "diritto di Stato". Ciò significa la rimozione delle protezioni legali per i cittadini e per i lavoratori a fronte del "workfarismo" galoppante (Handler, 2004, p. 48-54, p. 58-59, p. 76-78 ; Sommerlad, 2004, 2008) e si esprime nell'accresciuta capacità del grande capitale transnazionale di produrre la sua propria legge, ed a instituire ed a regolare i suoi affari (Teubner, 1997 ; Scheurman, 1999, 2001 ; Likosky 2003).
La sicurezza interna - lo statalismo atutoriario, III fase
Al volgere del secolo, questo accordo entra in crisi. Nei paesi del centro capitalista, la strategia neoliberista è stata sottoposta ad una severa pressione popolare (Kelin, 2002, p. 3-40) in quanto il modo di accumulazione basato sugli investimenti diretti all'estero e le fusioni che sono stati il motore dell'economia per tutto il corso degli anni 1990 avevano raggiunto il punto di esaurimento. Il mercato azionario fa un tonfo ed un mercato crivellato di debiti si dirige verso un collasso globale (Panitch, 2000, p. 27-30 ; Brenner, 2009).
Nel corso di questa sequenza, negli Stati Uniti, i settori dell'armamento e dell'energia si impadroniscono della Casa Bianca e cercano di evitare il crollo attuando un modo alternativo di accumulazione basato sulla stagflazione. Questo modo, al di là della dissolutezza intracapitalista che lo caratterizza, implicava un attacco frontale agli interessi materiali della popolazione (Nitzan & Bichler, 2009, p. 362-397). L'11 settembre venne utilizzato per galvanizzare il sostegno sia della popolazione che delle frazioni capitaliste rivali a favore di un insieme di politiche alla base della nuova strategia di accumulazione. Per attenuare gli effetti negativi di questo modo di accumulazione sulla popolazione, quest'ultima venne spinta verso un'accresciuta dipendenza dal consumo a credito.
Questo riallineamento è il risultato delle mutazioni della forma-Stato e segnala un terza fase dello SA. Questo nuovo momento consiste in una radicale intensificazione dell'esclusione politica della popolazione, combinata ad una drastica espansione del controllo coercitivo statale sulla società. Esso si cristallizza attorno a diverse grandi tendenze. Il ritmo deliberativo e la logica del potere legislativo viene severamente interrotta (in particolare, col voto di leggi fondamentali come il Patriot Act del 2001 o l'EESA del 2008), funzionando spesso come un comitato speciale dell'esecutivo. Ne risultano delle leggi vaghe, flessibili e mal definite che innalzano sistematicamente i limiti del potere esecutivo sia nel contesto delle investigazioni criminali che in quello della politica economica. La magistratura perde il controllo sulla polizia e smette di supervisionare le inchieste. Il rispetto delle procedure viene compromesso e l'onere della prova si inverte a favore della colpevolezza per associazione. La categoria criminale al centro dell'antiterrorismo (il "terrorismo interno"), soggettiva e determinata dalla motivazione politica dell'attore, costituisce un elemento cruciale di questo sconvolgimento. Inoltre, nel diritto criminale si assiste alla svolta preventiva che cerca di perseguire il crimine che non ha avuto luogo.
Quest'evoluzione non solo fa a brandelli lo stato di diritto ma conferma anche la fine della logica e della funzione specifica del sistema giuridico. Il diritto diventa un semplice strumento utilizzato dall'amministrazione nel perseguimento di questi obiettivi politici. In tal senso, il regime pseudo-legale e dominato dall'esecutivo di Guantanamo costituisce il culmine del deragliamento sistematico del sistema legale. Questo regime sembra estendersi all'insieme della comunità cittadina (Paye, 2007, ch. 5-6 ; Buckel et al., 2011, p. 164-165 ; Boukalas, 2014, p. 54-57). La svolta preventiva, combinata ad un disaccoppiamento dell'indagine criminale dal sospetto, significa che tutti possono essere sospettati di crimini non commessi.
L'esercizio del potere poliziesco si basa sempre più sull'intelligence che diviene totale e che cerca di coprire tutte le interazioni fra gli individui (Donohue, 2008, p. 285 ; Treverton, 2011, p. 233-266 ; Boukalas, 2012a, p. 134-167). La sorveglianza generalizzata delle comunicazioni e dell'utilizzo di Internet da parte di tutta la popolazione non è un "abuso" ma un'occorrenza sistemica. Inoltre, il meccanismo di potere poliziesco si ristruttura. L'FBI si trasforma da agenzia poliziesca in agenzia di intelligence, mentre l'apparato di intelligence, sempre più nevralgico, viene centralizzato e passa sotto il controllo diretto del presidente. Similmente, attraverso l'istituzione del dipartimento della sicurezza interna, il vasto apparato di polizia sub-nazionale (a livello di Stati e a livello locale) viene inserito nella rete di intelligence e viene posto sotto il controllo federale (Boukalas, 2014, ch. 8-9).
La natura politica del terrorismo fa dell'attività politica popolare un obiettivo primario sia per l'apparato di polizia nazionale che per quello sub-nazionale. Tale attività viene pesantemente sorvegliata, sottoposta a molestie senza fine, infiltrata e repressa. La sua penalizzazione si intensifica costantemente e vengono estesi i poteri polizieschi volti al suo controllo. Dopo i partiti ed i sindacati, per la politica popolare viene chiusa anche la strada.
Inoltre, si assiste ad un cambiamento nel modo di legittimare il potere dello Stato, che ora si basa sulle competenze (supposte) in materia di sicurezza. Contrariamente alle competenze economiche, condivise in una certa qual misura dal pubblico e che possono di conseguenza essere oggetto di dibattito, le competenze in materia di sicurezza sono segrete, e fanno della legittimità una questione di fede (Boukalas, 2012a, p. 291-292). In questo quadro, il rapporto sicurezza-popolazione viene ad essere rimodellato. Ora diventa soprattutto coercitivo. La concettualizzazione di ogni cittadino in quanto sospetto di crimini non commessi iscrive l'insieme del rapporti Stato/popolazione in un meta-rapporto di polizia. Questo significa un'importanza crescente della polizia in seno ai meccanismi statali nel momento in cui la sua politicizzazione aumenta: prende di mira la mobilitazione politica popolare, è controllata dai vertici dell'esecutivo e definisce i rapporti Stato/popolazione. Inoltre, lo Stato attua delle piattaforme di partecipazione dei cittadini alla sicurezza interna (il programma Citizen Corps) all'interno delle quali il partecipante è condizionato a lavorare all'interno di rigide gerarchie (dove si trova sempre al gradino più basso della scala), senza salario, senza assicurazione o protezione e senza diritti sociali (Boukalas, 2012b).
In questo Stato di sicurezza interna, il workfarismo - l'attacco agli interessi materiali della popolazione - non accenna a diminuire. Il volontario della sicurezza interna è condizionato in quanto soggetto del workfare ed il lavoratore viene concettualizzato come una minaccia potenziale, cosa che permette di svalutarlo ulteriormente. In effetti, il periodo dell'emergere della sicurezza interna coincide con un'ondata di attacchi agli interessi materiali della popolazione. Viceversa, la rete di potere parallela Stato-capitale (ad esempio, "i comitati consultivi") viene legalizzata e riconosciuta come struttura di elaborazione politica principale. È protetta dal controllo popolare (e perfino parlamentare). Tuttavia, la creazione di tali reti rimane prerogativa dell'esecutivo. Un margine di azione più grande viene concesso per proteggere alcuni capitali dai procedimenti penali, designandoli come "infrastrutture critiche", e per distribuire contratti e fondi di salvataggio, come meglio preferiscono, ai soggetti privati da loro selezionati (Legge sulla sicurezza interna del 2003; 2008 EESA).
Sembra che la nuda vita sia meravigliosa per il capitale.
Non solo assistiamo ad una recrudescenza di statalismo alla vecchia maniera che assorbe la macchina del governo ma avviene anche che torna ad essere predominante la scala nazionale. Le strategie securitarie ed economiche vengono attuate avendo come orizzonte ultimo la scala nazionale, anche se implicano un'attività che la supera. Presa nel suo insieme, la sicurezza interna costituisce una riconfigurazione della forma-Stato che autorizza un'azione esecutiva ultra rapida ed arbitraria sia in materia economica che securitaria e che istituisce una mega macchina per prevenire, reprimere e schiacciare l'antagonismo sociale. La sicurezza interna è la blindatura dello Stato capitalista di fronte alla crisi attuale e quella a venire. Essa garantisce una gestione sotto sicurezza della crisi esacerbandone le condizioni che la causano: l'esclusione politica e lo spossessamento materiale della società.
Viceversa, il capitale dominante fa dello Stato quasi un suo affare privato. Inoltre, la presente configurazione del meccanismo statale sembra perfettamente in grado di regolare l'antagonismo intracapitalista. Questo si manifesta nel transfert fluido del dominio dal settore degli armamenti e dell'energia verso quello della finanza a partire dal 2008. Questo spostamento implica un cambiamento nella predominanza dei meccanismi statali che passano dal dipartimento della Giustizia e dal Pentagono al Tesoro e alla FED. Di conseguenza, sembrerebbe che la natura ibrida dello SA prenda ora la forma di un doppio edificio politico: uno Stato democratico normale per il capitale dominante, e uno Stato eccezionale-dittatoriale per tutto il resto. Prendendo in considerazione il significato sociale delle forme eccezionali, vediamo che il dilagare del "potere sovrano" è anche il segno del carattere limitato ed instabile dell'egemonia sociale.
Conclusione
A partire da due diverse traiettorie, la nostra percezione della sicurezza interna sembra arrivare a due conclusioni simili: uno stato di eccezione permanente per Agamben ed un doppio edificio politico che gestisce la crisi permanente (quella attuale e quella attesa) dal punto di vista dell'ASR (Approccio Strategico Relazionale). Questa convergenza è impressionante ed implica una comprensione simile dell'attualità del potere politico. Tuttavia, a parte il fatto di condividere un interesse comune e segnato dall'attuale configurazione del potere, questa similarità è fuorviante. Per cominciare, in Agamben non esiste alcuna nozione di potere "contemporaneo". Essenzialmente il potere è sempre lo stesso - un effetto del rapporto strutturale fra la nuda vita ed il sovrano. Quel che varia è il grado con cui il potere si rivela, e questo d'ora in poi raggiungerà proporzioni apocalittiche. Al contrario l'ASR è attento a distinguere le forme di potere nella loro rispettiva temporalità, come abbiamo visto attraverso il nostro esame dei tipi, forme e fasi dello Stato. Agamben cerca di definire la natura eterna del potere mentre l'ASR cerca di comprendere le congiunture storiche. Qui sta la differenza fra le due prospettive.
La reintroduzione della storia significa anche il ritorno del sociale come campo analitico. Mentre in Agamben il concetto di sociale brilla in maniera spettacolare per la sua assenza, per l'ASR costituisce il fondamento epistemologico. Così il sovrano qui si è dissolto nello Stato e nel diritto concepiti come dei rapporti sociali creati da delle dinamiche sociali. Inoltre, re-istituire la storia e la società come oggetto di analisi implica il ritorno della politica e dell'antagonismo sociale. Dimenticato nella struttura del potere sovrano e della nuda vita, l'antagonismo sociale costituisce la dinamica chiave che l'ASR cerca di catturare. Questo si manifesta nello spostamento analitico della "eccezione" verso la crisi affrontata in quanto dinamica sociale e nell'esposizione delle forze sociali (il capitale dominante ed i suoi settori, i movimenti popolari) visti come attori chiave nella riconfigurazione del "potere". Ne viene fuori che lo Stato Autoritario costituisce un segno di debolezza del presente ordine sociale.
Infine, mentre l'approccio agambeniano sembra condannato a rimbalzare da un livello di astrazione assai elevato al particolarismo, liberando delle corrispondenze sparse fra l'essenza eterna del potere ed alcune micro-pratiche ed alcuni artefatti, l'ASR ci invita ad esplorare lo spazio che si trova fra l'elevata astrazione e la particolarità. Concentrandosi sul contesto delle dinamiche socio-storiche, si mostra capace di decifrare le convergenze delle "linee generali di forza" espresse (nella misura in cui sono distinguibili) negli orientamenti strategici del potere dello Stato. Ci permette così una ricca comprensione dei modi le cui motivazioni, le cui pratiche, le cui strategie e significati si combinano al fine di produrre delle congiunture specifiche.
Si potrebbe certamente difendere l'argomento secondo il quale lo statalismo autoritario è un'esemplificazione dello stato di eccezione cui non si oppone, ma che piuttosto lo afferma. Ma, nella misura in cui ci confrontiamo con dei fenomeni sociali attuali e non con le rivelazioni degli arcani della divinità del potere, questo è davvero importante? L'approccio strategico relazionale pone la società ed i suoi rapporti dinamici al centro dell'analisi anziché nel non-luogo situato fra la nuda vita e Behemot. Questo dovrebbe bastare a distinguere la teoria sociale dalla teologia politica.
- Christos Boukalas - Articolo apparso inizialmente col titolo « No exceptions: authoritarian statism. Agamben, Poulantzas and homeland security », in Critical Studies on Terrorism, 7 ; 1, p. 112-130. - Pubblicato su Periode il 27 giugno 2016 -
fonte: Periode
NOTE:
[*1] - Creato il 27 novembre 2001 dal Homeland Security Act (Legge sulla sicurezza interna), il Dipartimento degli Stati Uniti per la Sicurezza Interna ha 8 funzioni principali fra cui la prevenzione degli atti di terrorismo appare al primo posto. Esso raggruppa sotto una medesima tutela amministrativa 22 agenzie federali fino ad allora distribuite nei vari dipartimenti ed agenzie dell'Amministrazione. La "sicurezza interna" qui si riferisce al dipartimento della Sicurezza interna ed all'insieme di dispositivi, conoscenze e processi di controllo ad essa collegati.
[*2] - Per una rassegna critica di queste posizioni, vedi Neocleous (2006).
[*3] - Il termine difficilmente traducibile di "workfare" designa sia un insieme di programmi sociali che l'ideologia che li legittima. Kinsky definisce il workfare nella seguente maniera: "I programmi di workrare pongono come principio che i beneficiari dell'aiuto sociale devono lavorare per ricevere un'indennità mensile". Il workfare "mira a limitare il numero di destinatari dell'aiuto sociale o al più a condizionarne accesso con un lavoro svalorizzato, rendendolo più un programma anti-assistenza che una struttura di assistenza. Inoltre, il ricorso al lavoro dei destinatari del workfare ha contribuito notevolmente alle imprese di flessibilità e di degradazione delle condizioni di lavoro del salariato americano. Lungi dal gettare un ponte fra il welfare ed il lavoratore salariato, il workfare attacca simultaneamente entrambe le istituzioni dello stao sociale" (Kinsky, 2009, p.1) (N.D.T).
Bibliografia
Ackerman B., Before the Next Attack, New Haven, CT, Yale University Press, 2006.
ACLU (American Civil Liberties Union), « Indefinite Detention, Endless Worldwide War and the 2012 National Defense Authorisation Act », 2012.
Agamben G., Homo Sacer : Sovereign Power and Bare Life, Stanford, CA, Stanford University Press, 1998.
Agamben G., State of Exception, Chicago, IL, Chicago University Press, 2005.
Agamben G., « Philosophical Archaeology », Law Critique 20, 2009, p. 211–231.
Agamben G., The Kingdom and the Glory : For a Theological Genealogy of Economy and Government, Stanford, CA, Stanford University Press, 2011.
Belandis D., In Search of the Internal Enemy [en grec ], Athènes, Proskinio, 2004.
Benjamin W., « Critique of Violence » in Reflections : Essays, Aphorisms, Autobiographical Writings, édité par P. Demetz, New York, Random House. [1921] 1986.
Boukalas C., « Government by Experts : Counterterrorism Intelligence and Democratic Retreat », Critical Studies on Terrorism 5 (2), 2012a, p. 277–296.
Boukalas C., Homeland Security, Its Law and Its State – A Design of Power for the 21st Century, Abingdon, Routledge, 2012.
Boukalas C., « US Citizen Corps : Pastoral Citizenship and Authoritarian Statism » Situations, 4 (2), 2012b, p.117–140.
Brassett, V. & N. Vaughan-Williams, « Crisis in Governance : Sub-Prime, the Traumatic Event, and Bare Life », Centre for the Study of Globalisation and Regionalisation, University of Warwick (Working Papers No. 268), 2012a.
Brenner R., « What Is Good for Goldman Sachs Is Good for America – The Origins of the Current Crisis », prologue de la traduction espagnole de R. Brenner, Economic of Global Turbulence. Londres, Verso, 2006.
Buckel S., « The Juridical Condensation of Relations of Forces : Nicos Poulantzas and Law » in Reading Poulantzas, édité par A. Gallas, L. Bretthauer, J. Kannankulam, et I. Stutzle, Pontypool, Merlin Press, 2011.
Bunyan T., « The Exceptional and the Draconian Become the Norm » Statewatch Report, mars 2005.
Callinicos, A., The New Mandarins of American Power : The Bush Administration’s Plans for the World, Cambridge, Polity Press, 2003.
Castoriadis C., « The Greek Polis and the Creation of Democracy » in The Castoriadis Reader, édité par D. A. Curtis. Oxford, Blackwell, 1983.
Colatrella S., « Nothing Exceptional : Against Agamben », Journal for Critical Education Policy Studies 9 (1), 2011, p. 97–125.
Diken B. et C. B. Lausten, The Culture of Exception : Sociology Facing the Camp, Abington, Routledge, 2005.
Donohue L. K., The Cost of Counterterrorism, Cambridge, Cambridge University Press, 2008.
Ericson R.V., Crime in an Insecure World. Cambridge, Polity Press, 2007.
Fitzpatrick P., « Bare Sovereignty : Homo Sacer and the Insistence of Law » in Politics, Metaphysics and Death – Essays on Agamben’s Homo Sacer, édité par A. Norris. Durham, NC, Duke University Press, 2005.
Garland D., The Culture of Control, Oxford, Oxford University Press, 2002.
Gross O., « Chaos and Rules : Should Responses to Violent Crises Always Be Constitutional ? », The Yale Law Journal 112, 2003, p. 1011-1134.
Handler J. F., Social Citizenship and Workfare in the United States and Western Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 2004.
Hardt M. & A. Negri, Multitude : War and Democracy in the Age of Empire, New York, Penguin, 2004.
Huysmans, J., « The Jargon of Exception – On Schmitt, Agamben and the Absence of Political Society », International Political Sociology 2, 2008.
Jessop B., Nicos Poulantzas : Marxist Theory and Political Strategy, Londres, Macmillan, 1985.
Jessop B, State Theory, Cambridge, Polity Press, 1990.
Jessop B., The Future of the Capitalist State, Cambridge, Polity Press, 2002.
Jessop B., State Power : A Strategic-Relational Approach, Cambridge, Polity Press, 2008.
Jessop B., « Poulantzas’s State, Power, Socialism as a Modern Classic » in Reading Poulantzas, édité par A. Gallas, L. Bretthauer, J. Kannankulam et I. Stutzle, Pontypool, Merlin Press, 2011.
Johns F., « Guantanamo Bay and the Annihilation of the Exception », European Journal of International Law, 16 (4), 2005, p. 613–635.
Kelin N., Fences and Windows, Londres, HarperCollins, 2002.
Koch M., « Poulantzas’s Class Analysis » in Reading Poulantzas, édité par A. Gallas, L. Bretthauer, J. Kannankulam et I. Stutzle, Pontypool, Merlin Press, 2011.
Kondylis P., « Épilogue » [en grec] in Political Theology, édité par C. Schmitt, Athènes, Leviathan, 1994.
Krinsky John, « Le workfare. Néolibéralisme et contrats de travail dans le secteur public aux États-Unis », Les notes de l’Institut Européen du Salariat, n°8, 2009.
Laclau E., « Bare Life or Social Indeterminacy ? » in Giorgio Agamben : Sovereignty and Life, édité par M. Calarco et S. DeCaroli, Stanford, CA, Stanford University Press, 2007.
Likosky M. B., « Compound Corporations : The Public Law Foundations of Lex Mercatoria », Non-State Actors and International Law 3, p. 251–281, 2003.
Mattelart A., The Globalisation of Surveillance, Cambridge, Polity Press, 2010.
Michael-Matsas S., « Capitalist Decline, Nation State, and State of Emergency », Critique 33, (1), 2005, p. 49–59.
Mills C., The Philosophy of Agamben, Stocksfield, Acumen, 2008.
Murray A., Giorgio Agamben. Abington, Routledge, 2010.
Neal A. W, Exceptionalism and the Politics of Counter-Terrorism, Abington, Routledge, 2010.
Negri, A., « Giorgio Agamben : The Discreet Taste of the Dialectic », in Giorgio Agamben : Sovereignty and Life, édité par M. Calarco and S. DeCaroli, Stanford, CA, Stanford University Press, 2007.
Neocleous M., The Fabrication of Social Order : A Critical Theory of Police Power, Londres, Pluto Press, 2010.
Neocleous M., « The Problem with Normality : Taking Exception to “Permanent Emergency” » Alternatives : Global, Local, Political 31, 2006, p. 191–213.
Nitzan J. & S. Bichler, Capital as Power, Abington, Routledge, 2009.
Norris A. 2005, « The Exemplary Exception : Philosophical and Political Decisions in Giorgio Agamben’s Homo Sacer » in Politics, Metaphysics and Death – Essays on Agamben’s Homo Sacer édité par A. Norris, Durham, NC, Duke University Press, 2005.
Panitch L., « The New Imperial State », New Left Review 2, 2000, p. 5–20.
Papacharalambous C., « God, the Sovereign, and the Law : The Resurgence of Carl Schmitt » [en grec] in On the Three Kinds of Legal Thought, édité par C. Schmitt. Athènes, Papazisis, 2009.
Paye J.-C., Global War on Liberty, New York, Telos, 2007.
Poulantzas N., Political Power and Social Classes, Londres, NLB, 1973.
Poulantzas N., Fascism and Dictatorship, Londres, NLB, 1974.
Poulantzas N. 1976a. « The Political Crisis and the Crisis of the State », in The Poulantzas Reader, édité par J. Martin. Londres, Verso , 2008.
Poulantzas N., The Crisis of Dictatorships, Londres, NLB, 1976b.
Poulantzas N., State, Power, Socialism, Londres, NLB, 1978.
Rasch W., « From Sovereign Ban to Banning Sovereignty », in Giorgio Agamben : Sovereignty and Life, édité par M. Calarco et S. DeCaroli, Stanford, CA, Stanford University Press, 2007.
Roach K, The 9/11 Effect, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.
Samples J, « Lawless Policy – TARP as Congressional Failure », Policy Analysis No. 660. Washington, DC, CATO Institute, 2010.
Scheuerman W. E, éEconomic Globalization and the Rule of Law », Constellations 6 (1), 1999, p. 3–25.
Scheuerman W. E., « The Economic State of Emergency », Cardozo Law Review 21, 2000, p. 1890.
Scheuerman W. E., « Reflexive Law and the Challenges of Globalization », Journal of Political Philosophy, 9 (1), 2001, p.81–102.
Scheuerman W. E., « Rethinking Crisis Government », Constellations 9 (4), 2002, p. 492–505.
Scheuerman W. E., « Survey Article : Emergency Powers and the Rule of Law After 9/11 », Journal of Political Philosophy 14 (1), 2006, p. 61–84.
Schmitt C., Political Theology : Four Chapters on the Concept of Sovereignty, Cambridge, MA, MIT Press, [1985] 1922.
Schmitt C., The Crisis of Parliamentary Democracy, Cambridge, MA, MIT Press, [1923] 1988.
Schmitt C., The Concept of the Political, Chicago, IL, Chicago University Press, [1932] 1996.
Schmitt C., Legality and Legitimacy, Durham, NC, Duke University Press, [1932] 2004.
Schmitt C., Theory of the Partisan, New York, Telos, [1963] 2007.
Schurman F. « Emergency Powers – The New Paradigm in Democratic America », New California Media, 2002.
Seymour D., « The Purgatory of the Camp : Political Emancipation and the Emancipation of the Political », in Giorgio Agamben : Legal, Political, and Philosophical Perspectives, édité par T. Frost, Abington, Routledge, 2013.
Sommerlad H., « Some Reflections on the Relationship between Citizenship, Access to Justice, and the Reform of Legal Aid », Journal of Law and Society 31 (3), 2004, p.345–368.
Sommerlad H., « Reflections on the Reconfiguration of Access to Justice », International Journal of the Legal Profession, 13 (3), 2008.
Teubner G., « Global Bukowina : Legal Pluralism in the World Society » in Global Law Without a State, édité par G. Teubner, Aldershot, Dartmouth, 1997.
Treverton G., Intelligence for an Age of Terror, Cambridge, Cambridge University Press, 2011.
Vaughan-Williams N., « The Generalised Bio-Political Border ? Re-Conceptualising the Limits of Sovereign Power », Review of International Studies 35, 2009.
Whyte D., « The Neoliberal State of Exception in Occupied Iraq » in State Crime in the Global Age, édité par W. L. Chambliss, R. Michalowski et R.C. Kramer, Portland, Willan, 2010.
Whyte, J.N., « The New Normal », Signature, 2005.