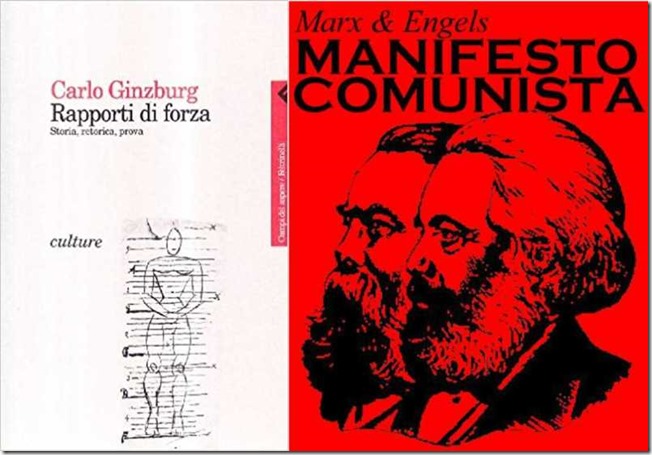Capitalismo senza capitale - O Capitale senza capitalismo?
- di Michael Roberts -
È uscito un nuovo libro dal titolo "Capitalism without capital – the rise of the intangible economy" [Capitalismo senza capitale - l'ascesa dell'economia intangibile]. Gli autori, Jonathan Haskel dell'Imperial College e Stian Westlake del Nesta, intendono sottolineare un grande cambiamento nella natura della moderna accumulazione di capitale - ossia che gli investimenti sempre più crescenti da parte di grandi e piccole aziende non consistono più in ciò che una volta erano beni tangibili, macchinari, fabbriche, uffici, ecc., ma di beni "immateriali", di ricerca e sviluppo, di software, di database, di "branding & design". E su questo terreno che gli investimenti stanno crescendo rapidamente rispetto agli investimenti in oggetti materiali.
Gli autori chiamano tutto questo "capitalismo senza capitale". Ma ovviamente, stanno usando "capitale" nel suo senso fisico, non in quanto modo di produzione e come relazione sociale; che è il modo in cui la teoria marxista utilizza la parola "capitale". Per la teoria marxista, ciò che conta è la relazione di sfruttamento che esiste fra i possessori dei mezzi di produzione (tangibili ed intangibili) ed i produttori di valore, a prescindere dal fatto che essi siano lavoratori manuali o "mentali".
Come ha spiegato G. Carchedi, non c'è alcuna differenza fondamentale fra lavoro manuale e lavoro mentale quando si parla dello sfruttamento sotto il capitalismo. In questo senso, il capitalismo senza capitale non può esistere.
La conoscenza viene prodotta per mezzo del lavoro mentale, ma in definitiva questo non è diverso dal lavoro manuale. Entrambi richiedono dispendio di energia umana. Il cervello umano - ci viene detto - consuma il 20% di tutta l'energia che traiamo dal nutrimento, e lo sviluppo della conoscenza nel cervello produce cambiamenti materiali nel sistema nervoso insieme a cambiamenti sinaptici che possono essere misurati. Una volta che abbiamo stabilito la natura materiale della conoscenza, ne consegue la natura materiale del lavoro mentale. Il lavoro produttivo (manuale o mentale che sia) trasforma il valore d'uso esistente in nuovo valore d'uso (realizzato come valore di scambio). Il lavoro mentale è lavoro che trasforma il valore d'uso mentale in nuovo valore d'uso mentale. Il lavoro manuale consiste nella trasformazione oggettiva del mondo esterno rispetto a noi; il lavoro mentale consiste nella trasformazione della nostra percezione e della nostra conoscenza di quel mondo. Ma entrambi sono lavori materiali.
Il punto è che le scoperte - che ora vengono fatte generalmente da team di lavoratori mentali - vengono appropriate dal capitale e sono controllate attraverso i brevetti, per mezzo della proprietà intellettuale di tali mezzi. La produzione della conoscenza è rivolta al profitto. La ricerca medica, ad esempio, è diretta a sviluppare medicine per curare le malattie, non per prevenirle, la ricerca agricola è diretta a sviluppare piante che il capitale possa possedere e controllare, e non a debellare la fame.
Ciò di cui Haskell e Westlake si sono resi conto, è che gli investimenti in attività intangibili ora eccedono gli investimenti in attività tangibili.
E pensano che questo stia cambiando la natura del capitalismo moderno. In effetti, questo potrebbe rendere evidente l'inutilità della cosiddetta economia di mercato. L'argomento è quello secondo cui un bene intangibile (come un software) può essere utilizzato più e più volte a basso costo, permettendo ad un'azienda di crescere molto rapidamente. Ovviamente, si tratta di un'esagerazione in quanto anche i beni tangibili come i macchinari possono essere usati più e più volte, ma è anche vero che sono soggetti ad "usura e logorio" [wear and tear] e a deprezzamento. Ma poi anche il software diventa obsoleto e "stanco" a causa dei continui cambiamenti di scopo che gli vengono richiesti.
In effetti, il "deprezzamento morale" degli oggetti intangibili è con ogni probabilità anche più grande di quello relativo agli oggetti tangibili, ed in questo modo incrementa ulteriormente le contraddizioni dell'accumulazione capitalista. Per un singolo capitalista, proteggere il profitto ottenuto grazie ad una nuova ricerca o ad un nuovo software, o proteggere il marchio dell'azienda, diventa molto più difficoltoso quando il software può essere facilmente replicato ed il marchio può essere copiato.
Brett Christophers ha mostrato nel suo libro, "The Great Leveller", che il capitalismo si confronta continuamente con una tensione dinamica fra le soggiacenti forze della concorrenza ed il monopolio. «Il monopolio produce la concorrenza, la concorrenza produce monopolio» (Marx).
È questo il motivo per cui le aziende sono così entusiaste riguardo ai Diritti sulla Proprietà Intellettuale. Ma i DPI in realtà sono attualmente inefficienti nello sviluppare produzione. "Spillover" [straripamento], come lo chiamano gli autori, laddove il beneficio derivante da qualsiasi nuova scoperta condivisa dalla comunità, è più produttivo, ma quasi per definizione lo è possibilmente solo al di fuori del capitalismo e del profitto privato - in altre parole, piuttosto che di capitalismo senza capitale, si tratta di capitale senza capitalismo!
Come sostiene Martin Woll, del Financial Time, nella sua analisi dell'ascesa degli "intangibili", «i beni intangibili mostrano delle sinergie. Questo va contro gli "spillover". Le sinergie incoraggiano la collaborazione e la cooperazione fra imprese (o le fusioni definitive), mentre è probabile che gli "spillover" le scoraggino. Chi è che vuole davvero offrire un pranzo gratis alla concorrenza?» Quindi «Prese tutte insieme, queste caratteristiche spiegano altre due cose che si trovano alla base dell'economia intangibile: l'incertezza e l'assenza di controversie. L'economia di mercato smette di funzionare in maniera familiare.»
Sotto il capitalismo, l'ascesa degli investimenti intangibili sta portando ad sempre maggior disuguaglianza fra i capitalisti. Le aziende leader controllano lo sviluppo delle idee, della ricerca e del design e bloccano lo "spillover" verso gli altri. Come risultato le "aziende squalo" stanno guadagnando rendite da monopolio, ma lo stanno facendo a spese della redditività degli altri, riducendoli allo status di zombi (limitandosi solo a coprire i loro debiti, senza essere in grado di espandersi o di investire).
Infatti, il controllo dei beni intangibili da parte di un piccolo numero di mega aziende potrebbe indebolire la capacità di trovare nuove idee e svilupparle. Nel settore dei semiconduttori, la produttività della ricerca è in calo al tasso di circa il 6,8% l'anno. In altri termini, siamo a corto di idee. Sono queste le conclusioni cui sono arrivati i ricercatori economici della Stanford University e del Massachusetts Institute of Technology Innovation [MIT]. A loro avviso, per continuare a mantenere in funzione la Legge di Moore - secondo la quale il numero di componenti elettronici (ad esempio i transistor) che formano un chip raddoppia circa ogni due anni - ora ci vogliono 18 volte più scienziati di quanti ce ne volevano negli anni 1970. Ciò significa che oggi la produzione di ogni ricercatore è 18 volte meno efficace in termini di generazione di valore economico di quanto lo fosse diversi decenni fa.
Così ci troviamo nella situazione in cui i nuovi settori guida stanno incrementando gli investimenti intangibili mentre gli investimenti complessivi crollano insieme alla produttività e alla redditività. La legge della redditività di Marx non si è modificata, ma si è intensificata.
L'ascesa dei beni intangibili significa un incremento nella concentrazione e nella centralizzazione del capitale. Il capitale senza capitalismo diventa un imperativo socialista!
- Michael Roberts - Pubblicato il 10/12/2017 su Michael Roberts Blog -