A seguire, la prefazione al libro "Mafia" di Henner Hess, scritta da Leonardo Sciascia. Una lettura interessante. Ieri come oggi.
Questo libro è stato scritto da un giovane tedesco dopo un lungo e attento soggiorno in Sicilia e attraverso una ricerca, archivistica e bibliografica, tanto minuziosa quanto precisa (mentre di solito la minuziosità è nemica della precisione, quando viene esercitata su una materia traboccante, sfuggente, contraddittoria e controversa). Credo sia una tesi di dottorato, come si dice oltralpe di quegli studi per cui si accede alla docenza e se si paragona (questa tesi, ma anche altre, di francesi e tedeschi, in cui ci siamo imbattuti in questi ultimi anni) a quel che da noi si produce per arrivare alla libera docenza (che in effetti è libera solo se non la si esercita) o alla cattedra, si è assaliti dalla malinconia, se non addirittura dalla disperazione. Ma lasciamo perdere.
A parte la mole della ricerca, quel che immediatamente colpisce il lettore di questo saggio è il buon senso, e cioè una specie di condizione a tabula rasa, senza pregiudizio, con cui l’autore ha voluto e saputo mettersi di fronte al fenomeno mafioso e sì che sarà stato difficile per lui, straniero, che prima di arrivare in Sicilia e agli archivi siciliani soltanto disponeva di tesi e schemi altrui, di teorie più o meno addentellate alla realtà, di impressioni più o meno false (i viaggiatori, gli “inviati”) e quasi sempre improntate ai romantici effetti che dà il vagheggiamento della “pianta uomo” di classificazione stendhaliana il brigante italiano nel secolo scorso, il mafioso siciliano nel nostro.
Già alla prima pagina, il buonsenso con cui il lavoro è stato condotto e il buonsenso della tesi cui è pervenuto appare evidente: “Contrariamente all’imputato Mini (Mini non è un famoso mafioso di cui ci si è dimenticati, ma sta per Tizio un tizio medio o grosso mafioso), la maggior parte della gente, in particolare fuori d’Italia (ma anche in Sicilia), si fa un’impressione abbastanza precisa della mafia un’associazione a delinquere centralizzata, retta duramente, con riti di iniziazione e statuti. Il pubblico è stato ampiamente informato sia dalla letteratura specializzata sia attraverso la stampa quotidiana, i romanzi polizieschi e del brivido e i gialli della televisione. Ma chi cerca di approfondire i fatti e di risalire lungo la catena delle fonti, ottiene un quadro completamente diverso e, come è accaduto a me nello svolgere questo lavoro, approderà alla convinzione che l’imputato Mini non mente affatto quando, alla domanda se fa parte della mafia, risponde ‘non so che significa’. In realtà egli conosce individui detti mafiosi non perché siano membri di una setta segreta ma perché si comportano in un determinato modo e cioè in maniera mafiosa”. A riscontro di questa affermazione, che il saggio svolge e dimostra, varrebbe la pena riportare per intero una intervista ai “presunti” (la sostantivazione dell’aggettivo ormai si impone mai l’opinione pubblica italiana è stata così convinta della colpevolezza di una persona o di un gruppo di persone come da quando sono state escogitate le espressioni “indiziato di reato” o “presunto colpevole” – e in quanto al “presunto mafioso”, la presunzione non resta tale ma si materializza in una limitazione della libertà personale abbastanza somigliante al carcere) pubblicata nel 1971 dal settimanale “L’europeo”. Ai “presunti” confinati nell’isola di Linosa.
Per cominciare, nessuno di loro ha mai sentito parlare di mafia se non dagli inquirenti e dai giornalisti. Ed ecco le sette risposte che il giornalista Magrì riscuote alle domande “cos’è la mafia, cosa vuol dire essere mafioso”: “Prima che i giornali sventolassero ai quattro canti questa parola mafia, nessuno ne sapeva niente”; “Secondo me è un tipico modo di vivere dei siciliani che non viene compreso in continente”; “E’ una gentilezza che si fa alla gente che merita rispetto; “Per loro, la mafia è la deformazione del prestigio” (e si sente l’eco della definizione del giurista Giuseppe Maggiore “una ipertrofia dell'io”); “Mafia è una parola antica che significa cava di pietra. Cava di pietra dove si riunivano le persone perseguitate dai dominatori della Sicilia; persone che si costruivano una loro giustizia. Ora, invece, i politicanti la tirano fuori per inserirla nella delinquenza”; “Ormai la mettono dovunque. Ma dei costruttori che si mettono insieme per costruire, o dei carrettieri che si mettono assieme per sfruttare la sabbia, che sono mafiosi? Sono industriali”. “Io, sul mio onore, non riesco a capire né il significato di mafia né quello di mafioso”.
Per coloro che credono di avere un’idea precisa della mafia, ma maturata sull’informazione della cronaca quotidiana e di qualche saggio tra i più inattendibili (pochissimi, per esempio, conoscono le illuminanti pagine di Hobsbawm), queste risposte suscitano ironica incredulità e danno addirittura nel comico. Invece esse sono, alla lettera, vere e il “presunto” che impegna il suo onore sulla dichiarazione che non riesce a capire che cosa significhi mafia, che cosa mafioso, non rischia poi molto – e non soltanto nel senso di una nozione dell’onore che più ha a che fare con l’omertà che con la verità. Per lui i termini mafia, mafioso non hanno senso indicano quel che per lui sono parentela, comparatico, amicizia, rapporti di affari; il saper tenere fede a questi rapporti e il rivolgerli a un fine di reciproco profitto, di miglioramento economico e sociale; un giudizio sulle cose del mondo, sulla necessità della forza, della legge e dell’ordine non dissimile da quello che vede realizzato nello Stato o nel sistema da cui emana lo Stato. Non hanno cioè, questi termini, quel senso di cui noi li carichiamo.
E ne abbiamo la controprova in questa dichiarazione che viene fuori dalla stessa intervista: “Io non sono ricco e non ho soldi. Anzi non so neppure come vivere. E anch’io sono mafioso. Io facevo il tosatore di cani insieme con mio padre. Avevamo una bella clientela, a Palermo. La migliore gente baroni, principi, avvocati, ingegneri. A ventotto anni entrai nei cantieri navali. Anzi, in una ditta appaltatrice dei cantieri navali. Prima che entrassi io c’era sempre disordini, scioperi, caos insomma. Ci sono andato io e ho sistemato tutto. Certo, uno si domanda ma com’è che ho potuto sistemare tutto? Bisogna vedere come l’ho sistemato. L’ho sistemato in maniera che gli operai avessero tutti i diritti. Ero, insomma, una specie di commissione interna, il tramite tra gli operai e il padrone. Poi successe che litigai con un operaio, la polizia lo fece suo…”. Ignorando la definizione - questa sì, a tutti gli effetti, precisa – che è stata data della mafia (“un’associazione per delinquere, con fini di illecito arricchimento per i propri associati, che si pone come intermediazione parassitaria, e imposta con mezzi di violenza, tra la proprietà e il lavoro, tra la produzione e il consumo, tra il cittadino e lo Stato”), il “presunto” candidamente ne offre la puntuale verifica meravigliato che si possa chiamare mafiosa un’idea e realizzazione dell’ordine, della pace sociale, del diritto tanto ovvia e per tutti soddisfacente.
Per tutti, tranne uno quell’uno che la polizia intrusa ha fatto suo. Ma davvero si deve far conto di uno, se tutti gli altri sono d’accordo? E quando mai si è vista rispettata l’opinione del singolo a Palermo, in Sicilia, in Italia? La polizia, si sa, è pagata per tenere l’ordine e quando c’è chi mette l’ordine senza scomodarla, spesso se ne appaga ma qualche volta, per dimostrare che non mangia a ufo, o per favorire qualche politicante, fa suo qualche scontento e comincia allora il disordine. Colui che diciamo mafioso si ritiene insomma delegato all’ordine più e meglio della polizia e per la semplice ragione che il sistema, nella versione siciliana, non consente alla polizia efficace penetrazione e controllo. In un certo senso, del sistema ci sono soltanto alcuni effetti e si conoscono soltanto due modi di controllo, due alternative. E valga come parabola questo episodio. Un commerciante subisce un furto, capisce da chi gli viene il colpo, gli si presenta, discorre del più e del meno, poi, entrato in confidenza, con non coperta allusione, gli dice “ma se avevi bisogno di soldi non potevi dirmelo? Che bisogno c’era di farmi uno sgarbo?”. Lo sgarbo sarebbe il furto il commerciante non ignora gli eufemismi e le metafore che si debbono usare, ma evidentemente sbaglia i tempi, se l’altro duramente gli risponde che questo non è il modo di parlare: “e quand’anche fossi stato io, a farle lo sgarbo, lei si presenta male”. La punizione piomba quasi immediata altro furto, questa volta in casa. Il commerciante ci si rode, soffre. Non sa che fare; e anzi sa di non poter fare proprio niente.
Ed ecco che gli si presenta un tale, che gli propone, senza mai spiegarsi nettamente, “di far finire la cosa”. Il prezzo sarebbe, per il commerciante, l’avallo di cambiali per due milioni. Il commerciante pensa mi faranno pagare le cambiali, ma mi restituiranno la roba. Firma. Paga. Ma la roba non gli ritorna. Dimagrisce, si ammala e quando racconta la ragione del suo male, come l’ha raccontata a noi, finisce così: “I casi sono due o mandano Mori o mettono in libertà quelli; qui non si ragiona più, non si vive più…”. “Quelli” cioè i “presunti” che stanno al confino. E in quanto alla polizia, niente da fare se non c’è uno come Mori i pieni poteri, gli arresti indiscriminati, le carceri piene di “quelli” e di “questi altri”. L’alternativa è netta, assoluta le infinite risorse dell’uomo d’ordine nell’Italia miracolosa miracolata miracolistica, in Sicilia si riducono a due.
- Leonardo Sciascia -
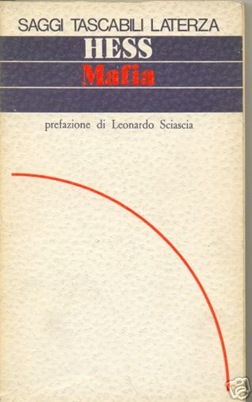
Nessun commento:
Posta un commento