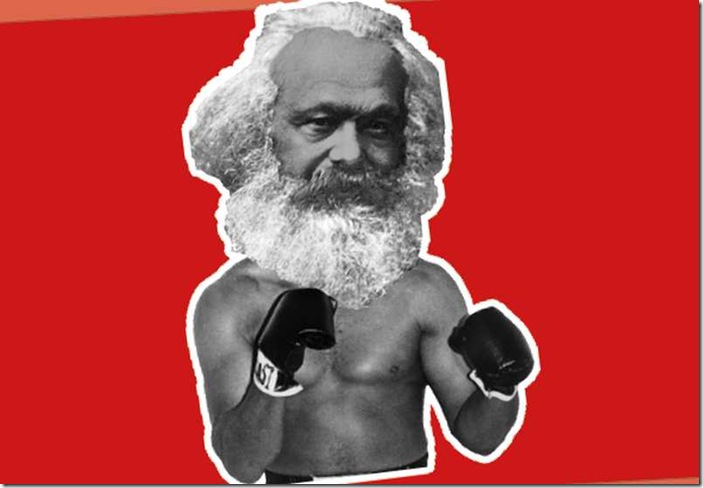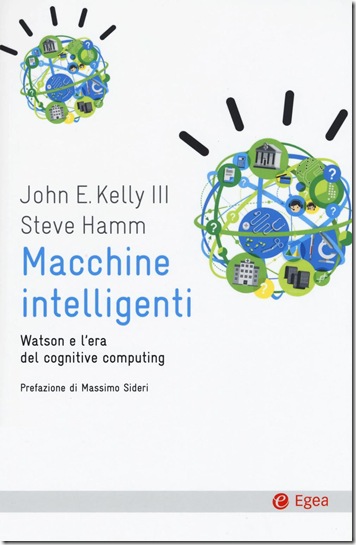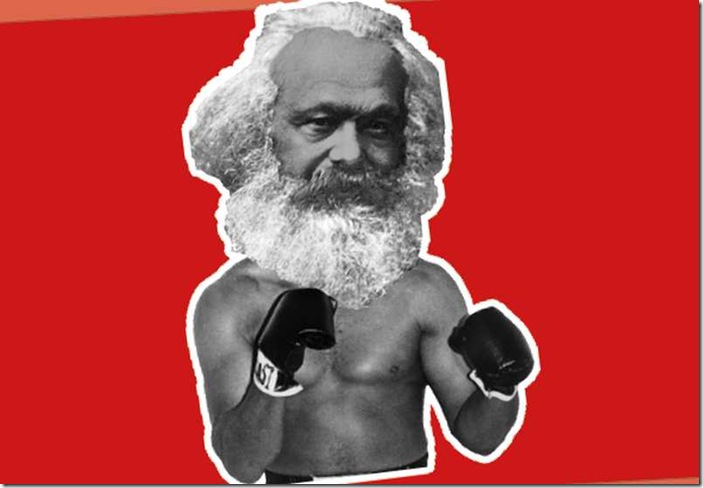
Due libri - due punti di vista
- Per una discussione su "La grande svalorizzazione" e "Denaro senza valore" -
di Ernst Lohoff
Nota preliminare sul carattere di questo testo.
Lo scorso anno, è apparso sul sito web del gruppo "Exit" un testo do Bernd Czorny, dal titolo "Ernst Lohoff e l'individualismo metodologico", che intende realizzare una critica della teoria della formazione del capitale fittizio che ho descritto nel libro "La grande svalorizzazione" e che rappresenta un cambiamento fondamentale di prospettiva nei confronti della precedente teoria della crisi della critica del valore. Czorny parte dalla mia analisi, e facendo uso delle linee guida metodologiche tracciate da Robert Kurz in "Denaro senza valore", e arriva alla conclusione originale secondo cui la mia analisi categoriale porterebbe ad un nudo empirismo, e sarebbe in gran parte inutile in termini teorici. Quest'affermazione si riflette prontamente in un gruppo della critica del valore della regione di Karlsruhe, che ha valutato diversamente il nostro libro ed ha scritto una risposta a Czorny, nella quale veniva difesa "La grande svalorizzazione". Per quanto gratificante fosse quest'intervento, aveva anche un inconveniente: a suo dire, la valutazione fatta da Czorny era falsa, mentre la teoria del capitale fittizio rappresentata nel nostro libro coincide in gran parte con la posizione di Robert Kurz; ci sono alcune differenze di contenuto relativamente a "Denaro senza valore", ma sarebbero di natura secondaria.
Questo, tuttavia, non coincide con il mio punto di vista. Al contrario, ritengo che il modello che Bernd Czorny applica, per mezzo di "Denaro senza valore", alla nostra teoria sia il problema principale - e non che egli applichi in maniera erronea questo modello. Con il suo ultimo libro, Robert Kurz ha lasciato un'eredità teorica altamente discutibile, che non solo si trova in netta opposizione alla nuova teoria della crisi, nel campo della critica dell'economia politica in generale e della teoria della crisi in particolare, ma, in'ultima analisi, invalida le basi delle elaborazioni congiunte della critica del valore. La discussione fra Bernd Czorny ed il gruppo di Karlsruhe ha evidenziato ancora una volta che questo è tutt'altro che trasparente per quanto riguarda il nostro ambito più ristretto e più ampio. Il presente testo nasce per fare più luce su tale aspetto.
1. Una biforcazione teorica.
Nel 2012, sono stati pubblicati due libri, uno subito dopo l'altro, che pretendono di innalzare ad un nuovo livello la teoria della critica del valore nel campo della critica dell'economia politica. "Denaro senza valore", di Robert Kurz, e "La grande svalorizzazione", di Norbert Trenkle ed io, segnano una sorta di biforcazione nel processo di formazione della teoria della critica del valore. Naturalmente, entrambi i libri condividono un punto di partenza simile, nella misura in cui vogliono superare le carenze delle argomentazioni precedenti della critica del valore e vogliono chiarire qual è il fulcro della teoria, ma le direzioni verso cui marciano sono diametralmente opposte. Senza indicarlo esplicitamente, entrambi i libri mettono in atto riformulazioni di grande respiro della costruzione teorica della critica del valore: la seconda parte de "La grande svalorizzazione" riformula la comprensione della categoria del capitale fittizio presente nella precedente discussione della critica del valore e, con la teoria delle merci di second'ordine, stabilisce una nuova base teorica per la vecchia idea della critica del valore, secondo cui il capitalismo si basa sulla produzione di valore futuro. Robert Kurz fa una revisione molto più ampia. In "Denaro senza valore", egli abbandona un principio teorico di base, fino a quel momento considerato ovvio dai rappresentanti dell'approccio della critica del valore nel campo della critica dell'economia politica. Fin dai primordi del gruppo Krisis, siamo sempre stati guidati dal metodo del passaggio successivo dall'astratto al concreto, proveniente dagli scritti della critica economica di Marx (Vedi MEW 42, pag. 34 e segg.).
2. L'importanza del capitale fittizio nella teoria della crisi agli inizi della critica del valore.
Inizialmente, teniamoci sul problema del capitale fittizio. Diventa più chiaro il modo in cui la teoria delle merci di second'ordine si inserisce nella teoria dell'accumulazione e della crisi della critica del valore, se in primo luogo ricordiamo la situazione precedente della teoria. Ecco qui allora una breve esposizione della storia dello sviluppo dell'approccio della critica del valore che ripercorre la funzione del riferimento alla dinamica della formazione del capitale fittizio nella nostra argomentazione teorico-critica iniziale, ed il modo in cui è stato compreso il concetto di capitale fittizio.
Fin dal suo inizio, l'approccio della critica del valore si è sforzato di comprendere le categorie fondamentali della società capitalista in quanto storicamente transitorie ed autodistruttive. Di conseguenza, anche la nostra teoria della crisi e dell'accumulazione si focalizzava sul suo basarsi in maniera analitica e categoriale sulla tesi di una crisi fondamentale della valorizzazione del valore. Secondo il nucleo della teoria della crisi di Krisis, con la Terza Rivoluzione Industriale il capitalismo in quanto sistema di valorizzazione del valore aveva raggiunto la sua barriera storica ed entrava in una crisi fondamentale. Tuttavia, questa tesi sollevava un problema centrale: chi afferma che la base della valorizzazione, la massa del valore e del plusvalore prodotto, si è ridotta a causa del dislocamento del lavoro vivo nel processo di produzione, deve avere una spiegazione plausibile del perché questo processo non ha portato alla morte dell'accumulazione capitalista. Questo divario fra il dato empirico (il proseguimento dell'accumulazione capitalista nei decenni 1980 e 1990) e la tesi centrale della teoria della critica del valore (crisi fondamentale della valorizzazione del valore) è stato colmato con la teoria addizionale secondo cui, in questo periodo, l'aumento del capitale sociale totale sarebbe stato mantenuto non sulla base della valorizzazione reale, ma soprattutto grazie all'anticipazione di valore futuro nella forma di capitale fittizio. Soltanto graie all'esplosiva espansione della sovrastruttura finanziaria, il processo di accumulazione può continuare il suo corso, nonostante la perdita della base della valorizzazione.
Quest'argomento deve perciò avere un'evidenza empirica molto forte. Da un lato, il gonfiarsi della sfera finanziaria è probabilmente la caratteristica del capitalismo contemporaneo che richiama maggiormente l'attenzione. Per dare un sostegno alla tesi centrale della sua teoria della crisi, la critica del valore non potrebbe, pertanto, rifugiarsi in un aspetto secondario dello sviluppo reale, ma deve riferirsi direttamente alla caratteristica principale di quest'epoca. Dall'altro lato, tale crescita è stata troppo drammatica perché si possa attribuire tale sviluppo ad una mera distribuzione e mobilitazione del plusvalore già accumulato. È evidente che la sfera finanziaria possiede la capacità di produrre, in qualche modo, una forma peculiare di moltiplicazione del capitale che permette di sostituire, transitoriamente, l'accumulazione di plusvalore.
3. Un concetto ristretto di capitale fittizio.
Constatare l'esistenza di una tale forma di crescita del capitale, scollato dall'accumulazione di plusvalore, ed essere in grado di spiegare in maniera coerente il suo funzionamento, sono due cose diverse. Il riferimento al gonfiarsi della sovrastruttura finanziaria, è stato usato classicamente come unico argomento ausiliario di supporto. Tenendo in considerazione la nostra pretesa di lasciarci alle spalle il carattere ristretto del marxismo del movimento operaio, così come la chiarezza categoriale con cui la crisi della valorizzazione del valore è già stata analizzata da parte della critica del valore, le spiegazioni della categoria "capitale fittizio" rimangono deficitarie. Abbiamo affrontato questo concetto, finora estremamente trascurato nella discussione marxista, ma lo abbiamo fatto in un'interpretazione ambivalente relativamente all'essenza della tradizionale teoria marxista dell'accumulazione. Essenzialmente, il marxismo obsoleto conosce solamente l'accumulazione del capitale basata sull'accumulazione del valore, e in ultima analisi considera gli eventi del mercato finanziario come un gioco a somma zero che ha come risultato la mera ridistribuzione della ricchezza capitalistica già esistente. Insistendo sull'approccio della critica del valore, secondo il quale il capitale fittizio negli anni ha sostituito la valorizzazione del valore come forza motrice dell'accumulazione del capitale, è stata data un'importanza intrinseca agli sviluppi del mercato finanziario nel processo di accumulazione; cosa difficilmente compatibile con la comprensione marxista tradizionale. Tuttavia, la differenza essenziale fra la formazione del capitale fittizio e l'accumulazione di capitale basata sulla valorizzazione del valore è stata analizzata in maniera tale che questa rottura è rimasta a metà strada. Per chiarire il carattere precario del capitale fittizio, sono state usate espressioni come "accumulazione apparente" che, anziché chiarire alcunché, facevano appello ad un pregiudizio di "autenticità metafisica" secondo la quale soltanto l'economia reale conta veramente, mentre la sfera finanziaria maschera semplicemente i legami economici reali.
Faceva parte di questa spiegazione, un'interpretazione del termine "capitale fittizio" che si discosta decisamente dalla comprensione di Marx di tale categoria, e che oscura la sua posizione nel sistema della critica dell'economia politica. Sebbene l'esposizione di Marx sulla questione del capitale fittizio sia frammentaria, non lasciano alcun dubbio che vada compreso tramite questa categoria. Nella voce di capitale fittizio rientrano tutte le somme monetarie risultanti dalla vendita di capitale-denaro che si trovano nelle mani dei creditori. Ad esempio, rientrano in questo le richieste di una banca per gli ammortamenti e gli interessi, così come anche le azioni rappresentano capitale fittizio. Cosa che avviene anche con il capitale-denaro concesso nelle mani di chi lo compra, cioè, se viene speso in maniera produttiva oppure nel consumo, laddove è irrilevante ai fini della distinzione concettuale fra capitale funzionante e capitale fittizio. Quel che è decisivo è che la vendita della merce capitale-denaro permetta una "doppia esistenza della stessa somma di denaro come capitale per due persone" (MEW 25, p.366 [1988a, p.251]).
Tuttavia, questo fenomeno della duplicazione del capitale iniziale, costitutivo della nozione marxiana del capitale fittizio, è rimasto nascosto nell'interpretazione della critica del valore. Al contrario, il livello dell'economia reale è stato incluso nella determinazione categoriale da parte di quelli che allora erano gli autori del gruppo Krisis. Secondo quest'argomentazione, soltanto un consumo "scorretto" del capitale prestato produrrà capitale fittizio. Così, il testo "Capitale fittizio", elaborato in maniera congiunta da Norbert Trenkle e Robert Kurz alla fine degli anni 1990, spiega con l'esempio del credito l'origine del capitale fittizio nel modo seguente: «[...] un credito non è niente di più che l'anticipo sul valore prodotto. In quanto viene utilizzato per finanziare investimenti nei settori della produzione che promuove l'utilizzo della forza lavoro vivente, e, pertanto, la produzione di plusvalore, viene utilizzato "correttamente" nel senso della valorizzazione. Se un credito viene utilizzato solo come mero consumo oppure viene speso in infrastrutture, quindi utilizzato improduttivamente in termini di valore, o sei i suoi investimenti già realizzati si dimostrano improduttivi dal punto di vista del mercato mondiale, perché la produzione non è capace di concorrere, allora i valori che sono stati anticipati per mezzo del credito vengono sprecati. Come conseguenza, il pagamento degli interessi e dei rimborsi non può essere effettuato per mezzo dei rendimenti generati dagli investimenti realizzati, ma dev'essere coperto per mezzo di altre fonti. Il credito diventa "capitale fittizio"» (Trenkle / Kurz 1998). Tuttavia, la critica dell'economia politica di Marx colloca la formazione del capitale fittizio inequivocabilmente all'interno della sfera finanziaria. Il capitale fittizio nasce dal rapporto fra i venditori e gli acquirenti della merce capitale-denaro ed ha la sua nascita nel momento in cui viene concesso un credito, viene emessa un'azione o un titolo di debito (Cf. MEW 25, p. 494 [1988b, p 13]).
Nell'identificarlo con le spese di consumo "scorrette", l'interpretazione classica della critica del valore ha rimandato l'emergere del capitale fittizio ad un momento successivo, ed allo stesso tempo ha dislocato il suo luogo di nascita dalla sfera finanziaria all'economia reale. In questa maniera, la produzione di capitale fittizio viene logicamente ridotta a qualcosa come l'apparire o l'accumulo di obbligazioni di pagamento da parte dei debitori. È stato soprattutto per questa riduzione che la mancanza di precisione concettuale ha avuto conseguenze anche per quel che riguarda la valutazione dello sviluppo reale. Non è un caso che autori della critica del valore abbiano ripetutamente preso grandi granchi riguardi l'accumulazione del capitale come occasione per proclamare il collasso finale del capitalismo basato sulla creazione di capitale fittizio. Tuttavia, quelli che operano con una nozione ristretta di capitale fittizio finiscono per sottovalutare la capacità di accumulazione del nuovo tipo di capitalismo. Per avere un'immagine realistica del potere di anticipazione da parte del sistema capitalista, ed un'analisi categorialmente fondata della storia interna del capitalismo attuale caricato dalla dinamica del mercato finanziario, è necessaria un'altra base teorica. Questa viene fornita dalla teoria delle merci di second'ordine, che mette al centro il problema della duplicazione del capitale-denari nelle relazioni del mercato finanziario.
4. I cambiamenti nel panorama del dibattito.
Naturalmente, ci sono ragioni per cui l'approccio critico del valore sia rimasto per molto tempo bloccato nell'analisi del capitale fittizio della visione marxista tradizionale. Questo include - come già accennato - la logica interna dello sviluppo del nostro processo di costruzione teorica. Dal momento che gli autori della critica del valore dovevano ancora concentrarsi sulla formulazione del nucleo della teoria dell'accumulazione e della crisi, avevano poco margine per un'elaborazione categorialmente fondata dell'intricata economia politica del capitale fittizio. Almeno altrettanto importante era, tuttavia, l'ambiente discorsivo in cui doveva inizialmente affermarsi la teoria della crisi della critica del valore. Almeno fino al collasso della nuova economia, ci trovavamo del tutto soli nella nostra visione secondo la quale il modo di produzione capitalista camminava direttamente verso una crisi fondamentale. Considerata l'altezza dell'economia mondiale dei decenni 1980 e 1990, la diagnosi di crisi appariva in gran parte assurda ed empiricamente confutata; venendo dato continuamente per scontato che gli impulsi della crescita avevano un solido "fondamento economico reale". Vent'anni fa, quasi nessuno avrebbe pensato che la dinamica del mercato finanziario, da sola, avrebbe portato al boom, per non parlare delle conseguenze di questo per la prospettiva dello sviluppo futuro del sistema capitalista. In un simile ambiente discorsivo, i rappresentanti della critica del valore, nell'enfatizzare la dipendenza dell'accumulazione in relazione alla dinamica del capitale fittizio, dovevano insistere sul carattere precario di questo tipo di accumulazione. Ma questa era la cosa più facile, in quanto faceva ricorso ad un "preconcetto di autenticità metafisica", rimasto fino a quel momento in ombra, secondo il quale il capitale "reale" era "più reale": la ricchezza capitalistica avrebbe potuto sorgere soltanto dalla produzione di beni.
Le circostanze storiche che sembravano permettere agli autori della critica del valore un'approssimazione superficiale ed abbastanza associativa alla categoria del capitale fittizio, però sparivano. A fronte delle gravi crisi economiche globali degli ultimi anni, la negazione della crisi stava andando di moda. Gli autori della critica del valore, oggi non dovevano faticare per rendere plausibile, contro l'apparenza empirica, il fatto che il capitalismo si trovava in una grave crisi fondamentale. Ed anche il vecchio ceterum censeo della critica del valore, secondo cui l'accumulazione sostenuta dai mercati di capitali e denaro sarebbe precaria, non porta più la critica sociale svolta dalla critica del valore a differenziarsi fondamentalmente dallo spirito apologetico del tempo. Questo, chiaramente, inverte la relazione in maniera feticista classica. Le ideologie di elaborazione della crisi, che sono diventate egemoniche tutt'al più dopo il collasso del 2008, giocano il "buon capitale reale" contro il "cattivo capitale finanziario" e perseguono l'illusione del ritorno alla società della merce orientata dal primato dell'economia reale. L'idea regressiva che la presunta causa della crisi sarebbe l'orientamento presumibilmente unilaterale dell'economia ai mercati del denaro e del capitale ed al dilatamento di questi, oggi ostacola l'idea che la società della merce abbia raggiunto un limite storico e che sia condannata.
In termini di analisi reale, la situazione storica modificata obbliga i rappresentanti dell'approccio della critica del valore a cambiare il pronostico della crisi in una diagnosi della crisi. Al giorno d'oggi, uno dei nostri compiti principali è quello di analizzare da vicino la forma dello sviluppo del processo di crisi e spiegare come si intreccino la crisi dell'anticipazione del valore e la crisi della valorizzazione del valore.
Anche con una comprensione limitata del capitale fittizio, la critica del valore è riuscita a rendere plausibile il fatto che un processo di accumulazione basata sull'anticipazione senza copertura della produzione del valore futuro, deve portare, più presto o più tardi, ad un gigantesco empito di svalorizzazione. Tuttavia, lo sviluppo interno del sistema di anticipazione di valore, può essere implementato sistematicamente solo sulla base di una critica dell'economia politica del capitale fittizio che prenda sul serio il fenomeno della duplicazione del capitale denaro nelle relazioni con i mercati finanziari. Alla luce della teoria del capitalismo inverso, emerge un'immagine molto più chiara e sfaccettata dei mutamenti subiti dal sistema capitalista mondiale negli ultimi trent'anni, rispetto alle pubblicazioni precedenti provenienti dalla critica del valore.
Inoltre, il nuovo approccio è molto più adeguato alle nuove necessità insorte nel campo della critica ideologica rispetto a vecchi argomenti. Oggi, la critica del valore deve prendere posizione soprattutto contro i diversi di tipi di sogno anacronistico di ritorno ad un capitalismo "solido" basato sul lavoro onesto. Chi insiste sul gergo della metafisica dell'autenticità e continua a parlare di mera "accumulazione apparente" nella sovrastruttura finanziaria è, pertanto, messo davanti ad un problema di delimitazione alla luce del cambiamento del paesaggio ideologico. Non può assicurare la posizione frontale contro lo spirito del tempo in maniera consistente come può fare una critica del valore che, sulla base della teoria delle merci di second'ordine, non fa alcun riferimento a quelle ideologie di "autenticità.
5. Come Robert Kurz perpetua l'interpretazione erronea della categoria del capitale fittizio.
Si stanno già delineando i vecchi errori di base nel trattamento della categoria del capitale fittizio: gli autori della critica del valore non hanno analizzato separatamente il movimento del capitale-denaro puro; la questione dell'utilizzo del capitale-denaro trasferito dall'economia reale ha avuto luogo nella determinazione concettuale del capitale fittizio. Questa confusione fra la sfera finanziaria e l'economia reale non è in nessun modo una cattiva interpretazione esclusiva della formazione teorica della critica del valore. Si tratta, innanzitutto, dell'adozione involontaria delle riduzioni provenienti dal marxismo del movimento operaio. La stessa interpretazione erronea si trova, per esempio, in Rudolf Hilferding, nella cui opera principale il capitale bancario si mescola, in una massa uniforme, con la forma-denaro del capitale produttivo. "Al contrario, il capitale bancario, il proprio e quello altrui, non è nient'altro che capitale in prestito, e questo capitale in prestito non è cosa diversa dalla forma-denaro del capitale produttivo, essendo importante che sia, per la sua maggior parte, semplice forma, vale a dire, che esista solo contabilmente" (Hilferding, 1968, p. 235). Sebbene Hilferding sia stato uno dei pochi teorici del marxismo tradizionale che abbia parlato dettagliatamente riguardo il capitale fittizio, egli spiega quest'ultimo come un capitale che esiste meramente nell'immaginario degli attori economici coinvolti. In questo contesto, arriva a fare riferimento anche al fenomeno della duplicazione del capitale originario, ma considera questo come un fenomeno meramente giuridico. Che la pretesa meramente giuridica del denaro, di modo che essa assuma la forma di una merce negoziabile, smetta di rappresentare capitale soltanto nella testa e nei bilanci di coloro che sono coinvolti, e guadagni realtà economica come capitale considerato come un tutto, si trovava del tutto al di là dell'immaginazione di Hilferding e del marxismo tradizionale.
Sulla questione del capitale fittizio, Robert Kurz riproduce in tutti i suoi scritti successivi alla fine del secolo la fondamentale debolezza dell'originale argomentazione della critica del valore, e mescola categorialmente il movimento del capitale fittizio ed il movimento del capitale funzionale. Robert Kurz ha affermato di aver svolto una critica radicale del marxismo del movimento operaio - e con ragione, se consideriamo tutto. Tuttavia, per quanto riguarda il capitale fittizio, è rimasto intrappolato nell'orizzonte del marxismo del movimento operaio. La cosa è particolarmente evidente nel libro "Il Capitale mondiale", pubblicato nel 2005. Nel capitolo del libro in cui egli avrebbe dovuto di fatto delineare il modo in cui l'anticipazione della produzione di valore futuro poteva essere pensata a partire dalla critica dell'economia politica, tuttavia, Robert Kurz rappresenta nel dettaglio la supposta "esposizione insuperabile [...] del Capitale Finanziario" (Kurz, 2005, p.248), dopo quasi un secolo, di Rudolf Hilferding. In tal modo, fa un elogio esagerato in quanto rappresenta una comprensione del capitalismo che è incompatibile con l'approccio della critica del valore. Hilferding non solo comprende il "dominio del capitale finanziario" i maniera sociologistica, e lo identifica con la successiva soppressione della concorrenza e della legge del valore, che si suppone verrebbe sostituita da un cartello generale capitalista controllato dalle banche. Per quanto riguarda il significato dei mercati finanziari, Hilferding riproduce passo dopo passo il punto di vista dell'economia, in essendo i mercati del capitale e del denaro una mera collezione di capitale la cui funzione si limita a "trasformare denaro improduttivo in capitale funzionale" ( Hilferding, 1968, p.108).
Nel dibattito interno di Krisis, fra noi e Robert Kurz, durante gli anni 1980 e 1990, era indiscutibile che la posizione di Hilferding fosse incompatibile con l'approccio della critica del valore. È per questo che l'amore tardivo sviluppato da Robert Kurz per questo rappresentante del marxismo tradizionale, in "Das Weltkapital", e prima ancora nel testo "Le Perfidie del Capitale Finanziario" (2003), è stato un po' sconcertante. In effetti, non sembra che Robert Kurz si sentisse a proprio agio nel fare apertamente ricorso ad uno dei più importanti pensatori del marxismo del movimento operaio. Ad ogni modo, in "Denaro senza valore" prende un'altra strada, pià adeguata alla sua mentalità in quanto teorico della Tabula rasa: qui non si appoggia ad Hilferding, ma si volge contro Marx, e lo fa in maniera estremamente curiosa. Attacca l'individualismo metodologico generalizzato nelle scienze sociali ed economiche, ed afferma che la forma di esposizione su cui si basa Il Capitale sarebbe rimasta intrappolata in questo concetto teorico, ed avrebbe pertanto bisogno di una correzione. In opposizione a questo, fornisce, come contro-programma, una minacciosa "comprensione dialettica della totalità" (Kurz, 2012, p.63) che, contrariamente al metodo di Marx, argomenta coerentemente al processo capitalista globale e determina le categorie a partire da esso. Osservando più in dettaglio il punto di vista di Kurz, vediamo che presenta dei difetti fatali. Da un lato, l'accusa di individualismo metodologico rivolta a Marx è inconsistente. Dall'altro lato, è proprio sotto il nome di "comprensione dialettica della totalità" che si nasconde fatalmente il procedimento con cui il dibattito della critica del valore comprendeva precedentemente in maniera inadeguata il concetto di capitale fittizio. Visto in questo modo, "Denaro senza valore" trasforma un errore parziale che abbiamo fatto nel trattare la categoria del capitale fittizio in una sapienza metodologica di rango superiore e in un paradigma teorico generale.
6. Individualismo metodologico e storicità.
Il concetto di individualismo metodologico proviene dal dibattito delle scienze sociali e dall'economia, dove viene usato comunemente con il seguente significato: "punto di vista metodologico che assume che le istituzioni e i processi sociali devono essere spiegati per mezzo di ipotesi sui comportamenti individuali. Secondo questa tesi, i componenti fondamentali del mondo sociale (la società) sono individui le cui azioni sono determinate dalle loro inclinazioni e dalla comprensione della loro situazione" (Enciclopédia econômica). Per rendere questo concetto utilizzabile per i suoi obiettivi, Robert Kurz ne trasforma sostanzialmente la comprensione. La prima ridefinizione mi sembra accettabile: la dislocazione del concetto, che di fatto è stato elaborato per la teoria dell'azione, per i contesti dell'analisi strutturale. In Robert Kurz gli elementi strutturali isolati prendono il posto occupato, nella comprensione comune, dagli individui superati. Egli scrive: "L'individualismo metodologico consiste, essenzialmente, nel pretendere di esporre e spiegare una logica generale e determinante per la totalità sulla base di un caso individuale ed isolato, che perciò appare come modello" (Kurz, 2012, p.60). Ma questo non è tutto. Robert Kurz generalizza il concetto a cinque "complessi"(vedi p.28 e segg.) i quali, a partire dal caso individuale, non sono mediati a sufficienza, o non lo sono affatto. Egli trasforma il concetto di "individualismo metodologico" in una specie di controparte negativa universale della sua propria comprensione della critica del valore). Per cui, quasi ogni deviazione dalla comprensione teorica di Kurz può essere sottomessa al concetto esageratamente esteso di "individualismo metodologico". Ai fini della critica che Kurz fa di Marx, è cruciale un allungamento. Di modo che su un approccio teorico che non prenda in considerazione la "storicità delle categorie", e veda le categorie soggiacenti al modo di produzione capitalista come già operanti, in una forma impura, nelle società precapitalistiche, egli emette il verdetto di "individualismo metodologico". Senza dubbio è possibile trovare, nella storia della teoria, posizioni che combinano una visione trans-storica con l' "individualismo metodologico".
In questo senso Adam Smith è uno dei classici assoluti. Nella sua derivazione dalla necessità di denaro, ad esempio, il nonno dell'economia non solo parte logicamente dai produttori privati isolati, ma allo stesso tempo proietta sul passato la dissoluzione della società in produttori privati e conseguentemente tratta il lavoro, il valore e lo scambio come necessità sociali naturali eterne. Tuttavia, questo non significa in nessun modo che ogni interpretazione trans-storica debba forzatamente allo stesso tempo prendere il caso particolare isolato come punto di partenza della costruzione della teoria. Possano andare insieme, ma non necessariamente. Ma è proprio questo che Robert Kurz suggerisce. Specialmente in Hegel - figura chiave della storia intellettuale, di gran lunga il più importante per poter comprendere il metodo di Marx - le due cose sono assolutamente separate. Nel prendere il processo mondiale nella sua totalità come "auto-sviluppo dello spirito", Hegel ha interpretato la storia mondiale come un unico processo generale del divenire delle categorie borghesi.In questo modo, egli continua la tradizione intellettuale trans-storica dell'Illuminismo, che aveva interpretato tutta la storia procedente come proto-forme immature delle relazioni borghesi. Ma allo stesso tempo Hegel è stato il pensatore per eccellenza della totalità. Solamente, disprezzava un pensiero che aveva come centro un individuo empirico, e se esiste qualcosa di simile ad un anti-programma all'individualismo metodologico ante litteram, questo è l'opera principale di Hegel. La scienza della logica.
Robert Kurz constata con ragione che Marx non è coerente nel corso dei suoi scritti con la storicizzazione delle categorie specifiche del modo di produzione capitalista. Almeno nei Grundrisse, Marx voleva realmente riconoscere forme ancora non sviluppate del valore e del lavoro astratto nelle società pre-capitaliste. La colpa di questi impulsi trans-storici è soprattutto dovuta alla separazione incompleta del trans-storicismo della filosofia di Hegel. Ma allo stesso tempo è stata proprio questa vicinanza con l'approccio hegeliano ad aver immunizzato Marx contro l'idea per cui si sarebbe potuta sviluppare la realtà capitalista a partire dal singolo caso individuale empirico.
Non è un segreto che esista una stretta relazione fra il metodo di Marx e la dialettica hegeliana. In una lettera ad Engels, scritta nel 1858, mentre lavorava alla sua opera principale, lo stesso Marx menziona che il suo approccio era legato al metodo hegeliano: "A tal proposito, faccio dei buoni sviluppi. Per esempio ho gettato via la teoria del profitto, così come esisteva finora. Per il metodo di elaborazione, mi è stato di grande utilità, esser tornato a sfogliare per puro caso [...] la Logica di Hegel" (MEW 29, p.360). Per comprendere la struttura dell'opera principale di Marx, bisogna prendere sul serio il passaggio frequentemente citato nella discussione su Marx negli anni 1970. Come ha sottolineato Roman Rosdolsky nel suo pioneristico lavoro sulla genesi del Capitale, Marx presenta la logica del modo di produzione capitalista, seguendo Hegel, come la successiva elevazione al concreto delle determinazioni astratte e più generali delle società basate sulla produzione delle merci. "Qui, soprattutto Marx dimostra che 'andare dall'astratto al concreto' è l'unico metodo scientifico adeguato per 'appropriarsi del concreto, riproducendolo come un concreto pensato'. Nell'introduzione, in un passaggio famoso, dice: 'Il concreto è concreto perché è la sintesi di molteplici determinazioni e, pertanto, è l'unita del diverso'. Per questo solo il pensiero può comprendere il concreto pienamente, in un processo di sintesi, ossia, attraverso la ricostruzione progressiva del concreto a partire delle sue determinazioni astratte più semplici" (Rosdolsky 1968, S. 43 ). Questa "elevazione dell'astratto al concreto" (MEW 42, p.35 ) è qualcosa di totalmente diverso dal partire da un qualsiasi individuo empirico o da un tipo ideale alla Max Weber.
Quando, al contrario, Robert Kurz afferma che ogni punto di vista trans-storico ricade anche nell'individualismo metodologico, ciò è inadeguato non solo in relazione al metodo di Hegel, ma anche a quello di Marx. Nella sua critica di Marx, Kurz respinge fondamentalmente quelle che sono le affermazioni discutibili sulle società pre-capitaliste. Ma così facendo, in nessun modo Kurz rappresenta il metodo di Marx. Egli ingnora che Marx, in contrapposizione ad Hegel, distingue rigorosamente fra esposizione logica ed esposizione storica, e che è proprio la sua opera principale ad occuparsi esclusivamente della logica della produzione capitalista. Ma Kurz non considera sistematicamente questo fatto, cosa evidente soprattutto per il fatto che egli utilizza sempre il concetto storico di "forma embrionale" e quello puramente logico di "forma elementare" come se significassero la medesima cosa.
7. La merce empirica e la categoria della merce nel Libro I de Il Capitale.
Così, Kurz mette in discussione direttamente la forma di esposizione del Capitale. Egli ritiene che l'errore fondamentale risieda nel punto di partenza dell'analisi di Marx: "il problema dell'esposizione in Marx finisce per essere dovuto al fatto che lo "inizio" nella figura dell'analisi della forma del valore conduce, anche senza volere, nella trappola dell'individualismo metodologico" (Kurz, 2012, p.169). Kurz ritiene che Marx avrebbe dovuto scrivere quanto segue: "le determinazioni elementari della forma del valore della merce come momento del capitale non possono nemmeno essere sviluppate sulla base della merce individuale" (Kurz 2012, p.169). Kurz suppone qui che Marx sia stato tentato di spiegare la logica del capitalista a partire dalla "merce empirica individuale". Ma cosa c'è di vero in questa accusa? Se consideriamo le prime due frasi del Capitale come completamente isolate, aderendo al testo immediato ed ignorando sia le somiglianze metodologiche fra la Scienza della Logica di Hegel e la principale opera di Marz, sia il resto del primo capitolo, l'accusa appare plausibile. Marx scrive: "la ricchezza delle società in cui domina il modo di produzione capitalista appare come un'immensa collezione di merci e la mer e individuale come la sua forma elementare. La nostra inchiesta comincia, pertanto, con l'analisi della merce" (MEW 23, p.49).
Se leggiamo le parole di apertura nel loro contesto critico del feticismo, appare, tuttavia, che Marx nel primo capitolo del suo libro non parla in alcun modo di qualsivoglia merce empirica. Invece, egli utilizza il termine "merce" in un senso del tutto diverso da quello che significa comunemente. L'oggetto dell'analisi del primo capitolo del Capitale è determinato dalla seguente forma: "solo i prodotti dei lavori privati autonomi ed indipendenti fra di essi si confrontano come merci" (MEW 23, p.57).
Se Marx qui avesse parlato della merce nella superficialità empirica, tale dichiarazione centrale proverebbe il suo analfabetismo teorico. Naturalmente, lui sapeva bene che, sotto il modo di produzione capitalista, tutto assume potenzialmente la forma della merce, non solo i prodotti del lavoro privato. Né la merce forza lavoro rappresenta un prodotto "separato autonomo, di un lavoro privato svolto indipendentemente", né tanto meno lo rappresenta la terra ed altre risorse naturale - per non parlare della merce capitale-denaro; né i prodotti del cosiddetto "settore primario" (miniere, agricoltura ecc.) rimangono confinari in questa determinazione essenziale, perché nella sua produzione subentra un elemento di appropriazione della natura senza lavoro e la trasformazione di una data natura in merce segue la sua propria logica. Nel primo capitolo del Capitale, Marx restringe il concetto di merce alla merce in quanto rappresentante del valore, di modo che essa incarna la struttura capitalista centrale. È solo nello svolgersi della rappresentazione, nella misura in cui l'analisi del modo di produzione capitalista si sviluppa al di là delle determinazioni astratte più generali, che Marx introduce gradualmente tutti i tipi di merce della cui esistenza inizialmente egli fa astrazione. Nel primo libro del Capitale, il processo di concretizzazione arriva sol all'analisi della merce forza lavoro. Le altre merci, il lettore le incontra solo nel terzo libro, quando finalmente la ricostruzione della totalità capitalista raggiunge uno stadio in cui il concetto selettivo di merce può essere abbandonato. Non è un caso che Marx, nel primo capitolo della sua opera principale, sviluppa le "sottigliezze metafisiche e i trucchetti teologici" della merce, nell'esempio del vestito e della tela, lasciando da parte l'agricoltura, di gran lunga il ramo più importante della produzione di ricchezza del suo tempo. Era necessario restringere il concetto di merce in modo tale da prendere in considerazione soltanto la struttura di base della società capitalista: la socializzazione attraverso i prodotti del lavoro privato. Il dissolversi della produzione sociale nel lavoro privato, tuttavia, non è niente di più che la determinazione più astratta del modo di produzione capitalista, la sua totalità ancora non interamente sviluppata, la sua totalità in nuce. La merce, che si trova all'inizio del Capitale, è altrettanto non empirica della categoria dello "essere" con cui Hegel inizia la sua Scienza della Logica.
Se diamo credito a Robert Kurz, allora il supposto individualismo metodologico di Marx troverebbe la sua continuità nel trattamento del Capitale (Kurz, 2012, p.169). Ma anche l'affermazione secondo cui Marx ha analizzato il ciclo del capitale a partire dal capitale individuale e empirico è insostenibile. La categoria del capitale individuale svolge un ruolo solo nell'analisi dell'interazione di molti capitali, vale a dire, nel terzo volume della sua principale opera. Fino ad allora, la rappresentazione si muove logicamente sul piano del "capitale in generale" (vedi Rosdolsky 1968, p.61 e ss.), una categoria la cui esistenza è stata significativamente soppressa da Kurz.
L'idea secondo cui Marx si sarebbe orientato a partire dalla merce empirica e dal capitale individuale empirico non è nuova. Tale interpretazione era già diffusa nel marxismo tradizionale, sebbene non come rimprovero e piuttosto come interpretazione positiva. È stato il grande merito dei primordi della "Nuova Lettura di Marx" e i loro precursori hanno fatto luce su questa lettura ridotta ed hanno fatto chiarezza sulla differenza qualitativa fra la critica dell'economia politica e la dottrina economica borghese - anche se poi successivamente hanno in gran misura cancellato questa differenza (vedi Lewed, 2016). Naturalmente, Robert Kurz aveva quanto meno altrettanto familiarità di loro con tutti questi dibattiti. Ed è maggiormente degno di nota e necessario spiegare perché, in Denaro senza Valore, egli tratti tutto questo come qualcosa di inesistente, ripudiando in questo modo la forma di esposizione di Marx. Perché Robert Kurz si è dimenticato, nel suo ultimo libro, quello che precedentemente per lui era evidente? Perché ha imboccato il vicolo cieco di una nuova metodologia che parla in maniera permanente della totalità del modo di produzione capitalista, proprio per impedire il metodo che permetterebbe la sua ricostruzione?
8. Individualismo metodologico e sostanza del lavoro.
Uno dei motivi che assume rilievo nelle omissioni di Bernd Czorny a proposito de La Grande Svalorizzazione: il kurziano confesso ha combinato l'accusa di "individualismo metodologico" in maniera del tutto automatica con una seconda accusa. Egli presumibilmente avrebbe adottato un "concetto contraddittorio di sostanza"(Czorny, 2016). E, in effetti, esiste una stretta relazione fra le due questioni.
Negli scritti di critica dell'economia di Marx, si trovano fianco a fianco due differenti versioni della categoria della sostanza del lavoro: un concetto naturalistico-filosofico che proviene originariamente dall'accademica borghese del XIX secolo, ed un concetto genuinamente critico del feticismo. I critici del valore che si riferiscono al primo, si ritrovano con un enorme problema analitico rispetto al capitalismo contemporaneo. Un concetto naturalistico-filosofico della sostanza del lavoro rende impossibile spiegare nelle categorie della critica dell'economia politica come il sistema di produzione di ricchezza capitalista possa anticipare e capitalizzare in anticipo la produzione di valore futuro. Il segreto fondamentale dell'economia politica della formazione di capitale fittizio, l'inversione temporale nella relazione fra il dispendio di valore e la formazione di capitale, può essere rilevato soltanto in base ad un concetto di sostanza che sia critico del feticismo. Robert Kurz non voleva abbandonare l'idea di una sostanza filosofica pseudo-sensibile. In questo modo, egli fu obbligato a continuare con il supporto della contrapposizione fra ricchezza senza sostanza e ricchezza sostanziale. In Denaro Senza Valore, lo fa per mezzo della sostituzione della nozione filosofica di lavoro delle merci particolari e la sua elevazione al piano del processo capitalista globale: "[...]l'energia umana astratta non si 'infiltra' in maniera immediata nella merce individuale prodotta per ciascun caso, ma è oggettivamente aggregata, dietro le spalle degli agenti individuali di produzione, ad una massa totale di sostanza del valore socialmente prodotto" (Kurz, 2012, p.179 ).
Viviamo in un'epoca in cui la maggioranza dei pubblicisti non vogliono né sono capaci di pensare tre frasi di seguito. Robert Kurz ha rappresentato i programma di totale opposizione. Il suo lavoro teorico era motivato dall'impulso sfrenato di portare ogni idea fino al suo fine logico. Il suo ultimo libro documenta anche, a suo modo, questa caratteristica di base della formazione teorica di Kurz. In Denaro senza Valore, Robert Kurz ha sviluppato in un sistema chiuso due punti deboli dell'inizio della critica del valore. Con l'inquietante "pensiero dialettico della totalità" egli eleva la frettolosa confusione dei piani di analisi ad una nuova meta-teoria. Nell'idea oscura di una base di energia sociale globale, che rappresenta la produzione di valore totale, e deve rappresentare qualcosa come il contenuto della totalità capitalista, nella quale, tuttavia, Kurz trova tutt'al più dichiarazioni metaforiche (vedi Kurz, 2012, p.204), l'idea di una sostanza naturalistica del lavoro arriva alla più alta consacrazione teorica.
Roman Rosdolsky aveva già mostrato alla fine degli anni 1950, in maniera incontrovertibile, l'incoerenza nel pensiero di Marx, ed aveva confrontato il marx "essoterico" guidato dal paradigma della lotta di classe con il Marx "esoterico" critico del feticismo. Robert Kurz ha ripreso quest'idea decenni più tardi e l'ha introdotta nel dibattito critico del valore con il teorema del "doppio Marx" (Kurz, 1991, p.16). Il contrasto fra il Robert Kurz di Denaro senza Valore e la mia posizione può essere inteso come un gioco di specchi per determinare in maniera più precisa la linea di demarcazione fra il Marx esoterico ed il Marx essoterico, al fine di continuare a sviluppare ulteriormente la critica dell'economia politica.
Il metodo su cui si è basato Marx nella sua opera principale, l'ascesa graduale della determinazione più astratta del modo di produzione capitalista fino alla totalità sviluppata, è ancora rivoluzionario ed indispensabile come modo di esposizione della totalità capitalista. Dall'altro lato, l'uso sovra-storico del concetto di lavoro e la derivazione naturalizzante della sostanza del lavoro come substrato fisiologico si allontanano dal nucleo della critica del feticismo dell'argomentazione di Marx. Essa oscura l'opposizione fra il concetto di valore storicamente specifico e negativo della critica dell'economia politica, da un lato, ed il concetto sovra-storico affermativo del valore-lavoro dell'economia classica, dall'altro lato.
Ma Robert Kurz si è aggrappato alla malaugurata confusione della critica del feticismo della merce facendo uso di un concetto meccanico-filosofico della sostanza del lavoro, e lo ha messo in contrapposizione alla metodologia di Marx. Il risultato è devastante. Chi, come Robert Kurz nel suo ultimo libro, finge di essere in grado di captare la totalità senza dissolverla in un tutto articolato, finisce inevitabilmente in un argomentazione circolare (vedi anche Samol, 2013, p.12). Oppure deve presupporre che quello che vuole dimostrare ritorna sempre segretamente alla strada che lo condanna ad un supposto "individualismo metodologico". Una "comprensione dialettica della totalità" dove la ricostruzione della totalità sociale ormai non è il risultato dell'ascesa dall'astratto al concreto, ma il processo globale sviluppato diventa il presupposto di ogni determinazione categoriale, diventa impossibile qualsiasi determinazione categoriale degna di questo nome.
Robert Kurz, com'è noto, tende ad esagerare le formulazioni. Se seguiamo questo modello, allora l'importanza del suo ultimo libro, ai fini dell'approccio della critica del valore, può essere riassunta in una frase. In Denaro Senza Valore, Robert Kurz ha distrutto tutto quello che lui ed altri hanno costruito a caro prezzo nel corso di decenni.
- Ernst Lohoff - Pubblicato su Krisis del 17 aprile 2017 -
fonte: KRISIS