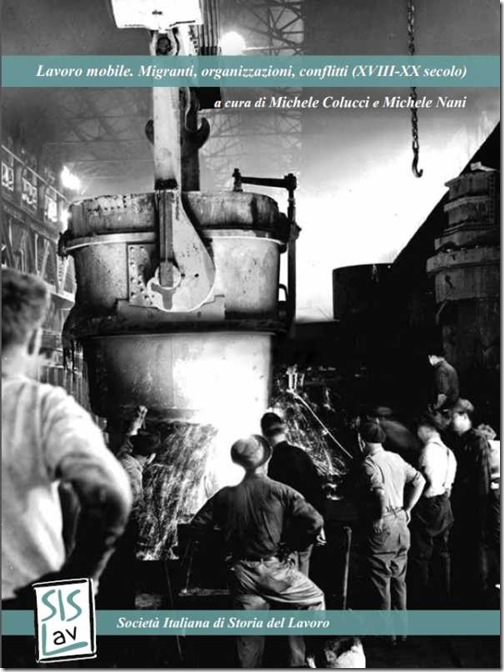Qualcosa ancora succede!
A proposito del sogno della vita eterna del capitalismo attraverso tutte le crisi.
- Lettera aperta alle persone interessate ad EXIT! nel passaggio al nuovo anno 2017 -
Anche il 2016 è stato segnato da tutte le catastrofi riguardo la vita e la morte dei rifugiati. È venuto così apertamente alla luce del sole quello che tanto piace ai mediatori ed alle mediatrici professionali, da chiunque lavori per i media fino ai funzionari della pubblica istruzione: storie personali e destini di vita, che si suppone siano indispensabili per poter mediare i contesti più complessi. Sarebbe stato naturale sommare uno più uno, e farsi venire il sospetto che, con i rifugiati, gli europei si sono trovati immediatamente di fronte quella situazione di crisi globale da cui si erano isolati.
Tuttavia, ancora una volta è stata riscoperta la "lotta contro le cause della fuga". Invece di "rimestare" nei sintomi - questo ci chiedono le voci pacifiche della politica e dei movimenti sociali - bisogna combattere le cause della fuga. Ma quali sono le ragioni per fuggire? Nel numero tematico della rivista "iz3w" [ https://www.iz3w.org/ ] viene discussa tutta una miscellanea di ragioni per la fuga: Il mercato mondiale produce povertà. La politica tedesca di esportazioni di armi sta obbligando le persone a fuggire. Le alterazioni climatiche distruggono i mezzi di vita di molte persone. E la politica dello sviluppo - al contrario di quanto dichiara il suo slogan «combattere le cause della fuga, non i rifugiati!» - con i progetti di infrastrutture, con la politica di liberalizzazione del mercato e con la cooperazione con le élite cleptocratiche, spinge le persone a fuggire. Per non parlare dell'islamismo "taglia-mani e taglia-teste", che, con le sue azioni quotidiane di terrore e di guerra, obbliga le persone a fuggire. Tra le cause di fuga non mancano nemmeno l'omofobia e la persecuzione dell'omosessualità [*1].
Quella che non compare, ancora una volta, fra queste "molteplici cause", è la percezione della crisi del capitalismo, manca il riferimento alla logica della dissociazione-valore, che agisce come una contraddizione in processo: sul piano economico, come contraddizione fra l'utilizzo illimitato dei lavoratori sulla base della logica del capitale - ossia, la produzione senza limiti di plusvalore - e l'aumento della produttività forzato dalla concorrenza, ossia, la riduzione del numero di lavoratori produttori di plusvalore; sul piano politico, come contraddizione fra la tendenza universalista del capitale, orientato al mercato mondiale, ed il suo legame allo spazio funzionale e riproduttivo particolare, nazionalmente costituito.
E, in termini di soggetti, la violenza maschile va esprimendosi sempre immediatamente nei differenti modelli di elaborazione ideologica. È la logica stessa del capitale che si scontra con i propri limiti storici e fa sì che la dinamica del progresso diventi una dinamica di distruzione.
Chi cerca le cause della fuga senza considerare tutto questo rimane intrappolato in una discussione meccanicistica, suggerendo che, se venissero rimosse dal mondo le "molteplici cause", anche i rifugiati rimarrebbero nei luoghi ai quali appartengono. A tale scopo, basterebbe invertire i meccanismi di causa ed effetto. Le soluzioni diventano così semplici e realizzabili: la redistribuzione della ricchezza, la regolazione sociale ed ecologica del mercato mondiale, una politica di sviluppo orientata in tal senso, la lotta contro il terrorismo islamico e contro la repressione sessuale... L'importante è ottenere qualcosa e - soprattutto - che il capitalismo possa continuare il suo eterno cammino. Per far sì che questo cammino possa proseguire, la crisi dev'essere negata.
È esattamente la cosiddetta crisi dei rifugiati che avrebbe potuto mettere in chiaro il fatto che niente funziona. L'impasse immanente della situazione di crisi, nel caso dei rifugiati diventa chiaro: sono sotto gli occhi di tutti i limiti della possibilità di utilizzazione della forza lavoro dei superflui, l'impotenza degli interventi politici di ordinamento mondiale attraverso guerre interminabili, la fine della forma del diritto visibile nello stato di eccezione che diventa lo stato normale, così come nella deportazione e nell'internamento nei campi per i rifugiati. Interventi giornalistici critici della politica dei rifugiati, come quello di Metz/Seeßlen, percepiscono perfettamente alcune di queste relazioni [*2]: per esempio, il fatto che riguardo ai rifugiati diventa visibile «il dominio di uno stato di eccezione esorcizzato, (della) esclusione sociale...» [*3], il fatto che nello stato di eccezione «i grandi progetti della modernità - la democrazia, l'illuminismo, l'umanitarismo - vengono sospesi» [*4]. Ma, dal momento che non riflettono la cosiddetta crisi dei rifugiati sulla relazione sociale totale, il loro intervento rimane impantanato nella sfera politica. Si lamenta la decadenza dell'Europa, diventata visibile nel trattamento dei rifugiati, «un mostro post-democratico, neoliberista e, a volte, infantilmente malevolo, ed un progetto di regresso inesorabile» [*5]. La lamentazione sfocia in un'invocazione astratta di democrazia, di illuminismo e di umanitarismo. Anziché riflettere sul legame costitutivo fra Stati-nazione e democrazia e sulla sua inclusione nella totalità sociale, si invoca l'impossibile, in un "gergo di autenticità" (Adorno): «Una nuova forma transnazionale di democrazia. La democrazia reale, volta a difendere la libertà, la giustizia e la solidarietà» [*6]. Si fa appello ad un universalismo astratto, in cui le persone hanno capacità giuridica solo se hanno anche la capacità di lavorare e di valorizzare, o, quanto meno, possono essere finanziati a partire dalla produzione di valore. L'impossibile dev'essere possibile, dal momento che non può avvenire quello che non deve avvenire: la fine del capitalismo.
Quanto il canone del capitalismo eterno rimanga fermamente ancorato, anche a livello di riflessione teorica, diventa chiaro nel confronto di Roswitha Scholz con le teorie della colonizzazione di Klaus Dörre e di Silvia Federici [*7]. L'argomentazione di Dörre consiste nel fatto che «le colonizzazioni capitaliste in realtà sono illimitate, ovvero il capitalismo crea per sé, incessantemente, un esterno, sia sotto forma di regioni devastate, sia anche sotto forma di forza lavoro che non viene sfruttata» [*8]. Pertanto esiste la speranza per un nuovo regime di accumulazione, che per molti a sinistra è irrinunciabile. Non va dimenticata la mano curativa dello Stato, che - volendo - può superare le leggi economiche. Sulla strada verso un capitalismo eco-sociale, l'esterno e lo Stato, eterni, possono unirsi in un progetto di salvezza.
Per Silvia Federici, il capitalismo rimane vivo nella perpetuazione della società del lavoro. Essa vive nell'accumulazione primitiva, che è proseguita nelle colonizzazioni. In questo modo continua anche lo sfruttamento del lavoro. La fine della società del lavoro è talmente tabù che la superfluità oggettiva della forza lavoro non viene vista in maniera categoriale. «La paura di diventare superfluo è talmente grande che si riesce solo ad identificare teoricamente sé stesso con il diventare precario, essendo tabù considerare la fine assoluta della società del lavoro; questo è puro e semplice horror per il precario, che si vede obbligato a posizionarsi all'interno delle relazioni in via di decadenza per poter mantenere sé stesso come qualcuno che si sforza al massimo» [*9]. Anche quando la società del lavoro ormai non funziona più, si potrà in qualche modo scoprire come continuare l'attività professionale, da mantenere incondizionalmente, in un'imprenditoria individuale postmoderna. La critica di sinistra non ne vuol sapere di una rottura categoriale. In qualche modo, ci sarà sempre una possibilità di salvare il capitalismo da sé stesso, dalla dinamica di distruzione che ne accompagna la crisi.
Quanto peggio vanno le cose, tanto più bisogna fare intravvedere un qualcosa - da qualsiasi parte provenga - che lo Stato dispensa sulla strada per salvare il capitalismo. La speranza nel lavoro, un nuovo regime di accumulazione, un soggetto come portatore di salvezza diventano l'identità marcia di un'illusione quasi trascendentale. Ora, ciò che è realmente impossibile e che non può essere nemmeno sperato può diventare realtà. Il desiderio ardente serve a qualcosa solo nelle favole - ma non serve contro la logica della dissociazione-valore in quanto contraddizione in processo. Questa non può continuare eternamente. La sua dinamica la porta a sbattere, logicamente e storicamente, contro i limiti che nessuno Stato può permetterle di superare, in quanto questo può svolgere le sue funzioni solamente come parte immanente della costituzione del feticcio capitalista. Ma anche i fenomeni evidenti, in cui questa fine diventa visibile - le masse di superflui e le tendenze alla destatalizzazione e all'inselvaggiamento - non riescono a scuotere la speranza in un'eternità inservibile. Andando avanti, qualcosa "deve" succedere! E, laddove ormai niente più funziona, bisogna far apparire fede, speranza e una prassi feticizzata di solidarietà. Ora, neppure la teologia riesce a pensare fede e speranza in contrasto con la realtà. Nemmeno un Dio onnipotente potrebbe perpetuare la contraddizione in processo.
Sinistra e destra sono unite nella negazione della crisi. Mentre con un anelito di sinistra si cerca una nuovo barlume di creazione di valore, si invoca la "vera" democrazia e il diritto internazionale come ancora di salvezza, nei movimenti neofascisti che si stanno rafforzando si mostra la volontà di ricostituire la sovranità nazionale in via di disintegrazione. Tutto ciò avviene in una situazione nella quale, con la crisi del 2007/2009, salta agli occhi anche la fine delle possibilità di poter affrontare la svalorizzazione globale per mezzo degli strumenti neoliberisti. L'illusione che si possa trovare una via d'uscita dalla crisi attraverso la creazione di capitale fittizio, con circuiti di deficit e con interventi statali di salvataggio, ormai è stata negata. Quel che Robert Kurz aveva diagnosticato, circa i processi in corso nel mercato globale internazionale, è diventato evidente in parti sempre più ampie del mondo. «Lo Stato appare come economicamente svuotato, se comparato alla sua funzione precedente, e si è trasformato in una copertura politica cadente e socioeconomicamente al collasso» [*10].
Con la scomparsa dello spazio di manovra della gestione neoliberista della crisi, la crisi si ripercuote nella disintegrazione della sovranità nazionale, anche in forma aggravata negli Stati europei. Lo stato di eccezione diventa lo stato normale - come si evidenzia nell'ultimo anno, specialmente per quel che riguarda le persone che, di fronte alla disgregazione degli Stati, cercano rifugio in un Europa che viene supposta come ancora intatta. L'imperialismo di sicurezza delle "guerre di ordinamento mondiale" (Kurz), ormai non più finanziabili, sta diventando sempre più imperialismo di esclusione, con localizzazione nazionale particolare. Daniel Späth, nella sua presentazione al seminario di EXIT! di quest'anno, ha sintetizzato l'aggravamento dei processi di crisi, che vanno di pari passo con il crollo del 2007/2009, in quanto "svolta immanente postmoderna". Sul piano dell'elaborazione ideologica, alla svalorizzazione immediata del capitale occidentale ed al collasso della sovranità dello Stato corrisponde l'ideologia della ricostituzione della sovranità nazionale, che trova espressione nei movimenti neofascisti.
La contraddizione essenziale consiste nel pretendere di restaurare qualcosa che si decompone per aver perso la sua base in un'accumulazione che funzioni. Perciò, non è per caso che i tentativi di ricostituzione avvengono sempre più sulla base delle regioni, anziché delle nazioni. Esse non sono un'espressione di forza nazionale, ma semmai «un'espressione di disintegrazione della coerenza nazionale in formazione sub-statali di clan e di tribù» (Daniel Späth). Per quanto i movimenti neofascisti si presentino in maniere differenti, condividono tutti la volontà di sovranità e di auto-sviluppo. Si pretende che la sovranità torni ad essere realtà a tutti i livelli: nell'alimentazione, nella cura del proprio corpo, nella regione e perfino nella resurrezione del clan e della tribù.
Lo sfondo sociale di questo sviluppo è la negazione della crisi, come si può vedere nel paradosso di una critica neofascista a sondo neoliberista del neoliberismo. Il neoliberismo e la postmodernità che lo accompagna erano, infatti, reazioni alla crisi, ma sulla base della sua negazione. Le gestione neoliberista della crisi si stabilisce a partire dall'abbandono del paradigma politico-economico e nella transizione verso il culturalismo delle differenze, attraverso il gioco dei segni e dei soggetti. Con la crisi del 2007/2008 la cosa diventa chiara: il gioco è finito, non c'è alcuna base per poterlo prolungare. Si è sentito il fischio finale. In un contesto di elevata pressione della svalorizzazione, l'amministrazione neoliberista della crisi è al capolinea. Avviene una mutazione verso un'amministrazione di emergenza, autoritaria e repressiva. Alla negazione neoliberista della crisi risponde l'affermazione della crisi nei nuovi movimenti di destra - sorretta dall'illusione dell'autarchia economica. Ma anche quest'affermazione deve negare la crisi; perché anche dal fallimento della crisi non nascerà alcun nuovo regime di accumulazione.
Destra e sinistra si uniscono nella volontà di negazione della crisi e nel rifiuto di riflettere sulla totalità sociale. La vita immediata e le preoccupazioni immediate continuano ad essere il punto di partenza, e simultaneamente di arrivo, del pensiero. Continua a riflettere la sua mediazione con la totalità sociale determinata dalla relazione di dissociazione-valore, così come la crisi finale relativa a questa. Al posto di teorie complicate, vengono discusse semplici verità, con un'evidenza che viene supposta come immediata, e personalizzazioni, che trovano espressione nella critica delle élite. Anziché riflettere sulla relazione dei fenomeni isolati con la totalità sociale, quel che ha luogo è «un'invocazione vitalista di "esistenza" immediata [...] nel senso di una falsa immediatezza non-dialettica, un'esistenza che non ha in sé alcun contenuto, né orientamento e che, pertanto può anche spostarsi a destra» [*11].
Il fatto che il capitalismo, di fronte alla fine del prolungamento delle possibilità di accumulazione, porti alla distruzione del mondo, di certo non può essere vero. Ed ecco che qui la negazione della crisi appare ancora più urgente, come ultima ancora contro lo sprofondamento nel nulla. Tuttavia, quanto più, con i processi di svalorizzazione globale, collassano anche le basi della sovranità e del diritto, tanto più si aggrava la situazione di impasse e si marcia verso la distruzione della vita - sia a causa dell'esaurimento delle basi della vita, sia per i processi di inselvaggimento barbaro o per la morte finale.
In tale contesto, si evidenziano due fenomeni, sorti nel 2016 in connessione con la crisi dei rifugiati. In primo luogo, i modi di pensare ed agire xenofobi, razzisti e sessisti, che si sono manifestati attraverso la violenza maschile. Nonostante la necessità di distinguere, rispetto a questi fenomeni, piani differenti, si può tuttavia dire che la crisi associata a timori e fenomeni contraddittori deve essere elaborata dagli individui stregati dalla forma del soggetto, socializzati in maniera postmoderna ed orientati in senso narcisistico. Gli atti di violenza devono essere intesi come auto-posizionamento della soggettività narcisista maschile di crisi. Al contrario, le donne - ora responsabili sia del salario che della famiglia - diventano amministratrici di crisi, nelle situazioni dove si tratta di "nuda" sopravvivenza - e questo senza alcuna prospettiva. Situazioni in cui sono esposte alle proiezioni del sesso maschile, che, in condizioni narcisiste, possono immediatamente trasformarsi in violenza [*12].
In secondo luogo, la cosiddetta crisi dei rifugiati e il relativo dibattito politico-mediatico sono stati accompagnati da azioni terroristiche attuate da individui che avevano una storia di migrazione, o sonnessi in qualche modo con la migrazione. Secondo Gotz Eisenberg, in questo si può riconoscere un "nuovo copione": «Viene suggerito che gli autori di tali gesti, che abbiano o meno origine migrante, si servono di una codifica islamica e si dichiarano simpatizzanti dell'ISIS. Questo stabilisce "senso" e garantisce osservazione e grande attenzione» [*13]. Simultaneamente, attraverso l'attribuzione all'islamismo, si offre alla società scossa dalla crisi un nemico stabilizzatore che è venuto da fuori. Questo assolve e legittima lo stato di eccezione.
A partire da tale assoluzione, Eisenberg dice chiaramente in quale direzione vada cercata la soluzione all'enigma dell'amok e del terrorismo: «La normalità delle nostre condizioni di vita produce mostri: il protagonista della strage terrorista incarna il lato oscuro della vita quotidiana, dei suoi orrori nascosti» [*14]. Il quotidiano del modo di vita capitalista - aggravato dalle crescenti condizioni di crisi - spinge le persone ad una concorrenza incontestabilmente ostile, e la mancanza di senso e di prospettive porta all'autodistruzione, facendo in modo che scompaia il confine fra l'omicidio ed il suicidio [*15].
In questo modo si rivela, nei limiti della riproduzione sotto forma di merci del sistema, «la metafisica reale della modernità nella sua forma più ripugnante. Dopo che il soggetto borghese illuminato si è spogliato dei suoi abiti, appare evidente che sotto quegli abiti non c'è nascosto NIENTE: che il nucleo di tale soggetto è il vuoto; che si tratta di una forma "in sé", senza alcun contenuto» [*16]. Dietro questo vuoto c'è il vuoto della relazione di valore e di sovranità, insieme alla sua vuota forma del diritto fatta di "validità senza significato" (Agamben), in quanto relazione di coercizione politica in dissoluzione.
Il vuoto, in termini di contenuto, di una forma vuota sottomette a sé tutto il processo della vita. Nella crisi, manca la sostanza per questa coercizione di esposizione e sottomissione. Si scontra con il suo limite assoluto e sviluppa il suo potenziale di annientamento: l'annientamento dell'altro, in una concorrenza selvaggia, e l'annientamento di tutta l'organizzazione, senza senso perché vuota. La riduzione a "vita nuda" (Agamben) dell'essere umano sfocia nell'«ultima ed assoluta riduzione [...] a materia morta» [*17].
Benché l'illusione di eternità del capitalismo si presenti in maniera ancora più virulenta, come ancora di salvezza rispetto alla situazione ancora più drammaticamente aggravatasi con la crisi del 2007/2009, l'eternità del capitalismo è impensabile. Altrettanto impensabile è il suo fine emancipatore, nell'immagine di una ricostituzione qualsiasi, a prescindere. Quel che resta è l'insistenza sulla crisi categoriale, continuamente legata agli sviluppi empirici. Solo quando, in questo contesto, viene riconosciuto e negato ciò che costituisce il limite dell'immanenza capitalista, ci può essere un'opportunità di trascendere questo limite, per mezzo della negazione. Quel che è emancipatore non attiene alla famosa questione delle alternative, ma riguarda bensì la critica consistente della società delle merci e la riflessione sulla dinamica distruttiva della crisi che l'accompagna.
Affinché EXIT! possa continuare su questa strada, anche quest'anno chiediamo espressamente delle sottoscrizioni, e ringraziamo tutti coloro che, così, contribuiscono a garantire le basi materiali per il nostro progetto.
- Per la redazione e per la direzione di EXIT!, Herbert Böttcher -
Note:
[*1] - Vedi Informationszentrum 3. Welt (Hg.), Eine Frage der Existenz – warum Menschen fliehen [Una questione di vita o di morte - Perché le persone fuggono] Sept./Okt. 2016.
[*2] - Vedi Markus Metz/Georg Seeßlen, Hass und Hoffnung. Deutschland, Europa und die Flüchtlinge [Odio e speranza. La Germania, l'Europa e i rifugiati], Berlin 2016.
[*3] - Ivi
[*4] - Ivi
[*5] - Ivi
[*6] - Ivi
[*7] - Vedi, su EXIT! Krise und Kritik der Warengesellschaft, Nr. 13 (2016): Roswhita Scholz - Cristoforo Colombo forever? - Per la critica delle attuali teorie della colonizzazione nel contesto del "Collasso della modernizzazione" - [ http://francosenia.blogspot.it/2016/06/i-fiori-recisi.html ]
[*8] - Ivi
[*9] - Ivi
[*10] - Robert Kurz, Das Weltkapital. Globalisierung und innere Schranken des warenproduzierenden Systems [Il capitale mondiale. Globalizzazione e liniti interni del sistema produttore di merci.] Berlin, 2005.
[*11] - Roswhita Scholz - Cristoforo Colombo forever? [ http://francosenia.blogspot.it/2016/06/i-fiori-recisi.html ]
[*12] - Vedi Elisabeth Böttcher, „Die sozialpsychologische Matrix des bürgerlichen Subjekts in der Krise. Eine Lesart der Freud'schen Psychoanalyse in wertabspaltungskritischer Sicht“ [La matrice socio-psicologica del soggetto borghese nella crisi. Una lettura della psicoanalisi freudiana dal punto di vista della critica della dissociazione-valore], in Netz-Telegramm des Ökumenischen Netzes Rhein Mosel Saar, März 2016.
[*13] - Götz Eisenberg, "Von Orlando bis München: Amok oder Terror“? [Da Orlando a Monaco, Amok o Terrore?] in Nachdenkseiten, online: http://www.nachdenkseiten.de/?p=34349, Letzter Zugriff: 3.12.2016.
[*14] - Ivi
[*15] - Vedi Robert Kurz, Weltordnungskrieg. Das Ende der Souveränität und die Wandlungen des Imperialismus im Zeitalter der Globalisierung [La guerra di ordinamento mondiale. La fine della sovranità e le metamorfosi dell'imperialismo nell'era della globalizzazione], Bad Honnef 2003, 71.
[*16] - Ivi
[*17] - Ivi. Vedi anche Robert Kurz, "Ausgrenzungsimperialismus und Ausnahmezustand“, in: EXIT! Krise und Kritik der Warengesellschaft, nº. 13 (2016), Traduzione in "Imperialismo di esclusione e stato di eccezione" [ http://francosenia.blogspot.it/2016/10/la-guerra-di-ordinamento-mondiale.html ]
Pubblicato su www.exit-online.org il 13/12/2016
fonte: EXIT!