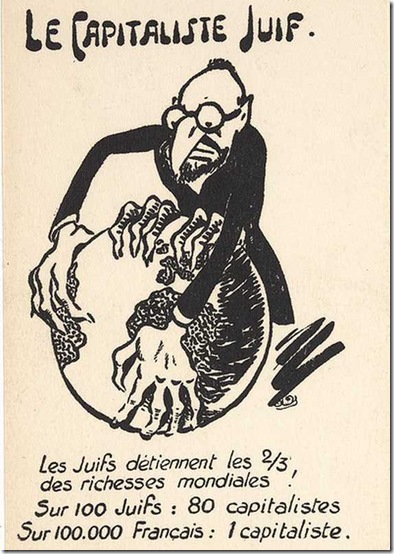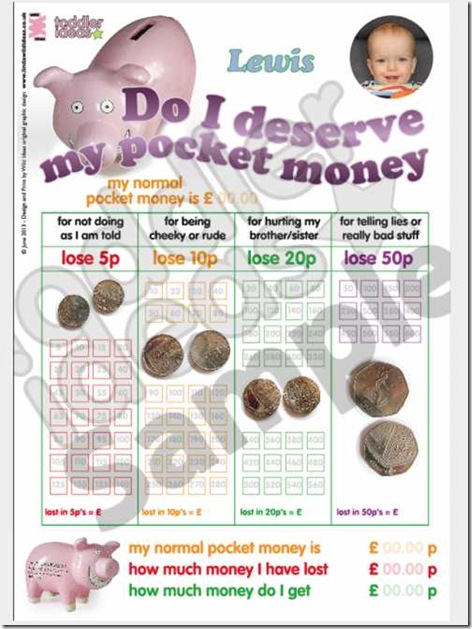Negatività spezzata
- Note sulla critica de l'Aufklärung [*1] in Adorno ed Horkheimer -
di Norbert Trenkle
L’Aufklärung non è mai stato criticato più radicalmente di quanto lo sia stato in "Dialettica dell'Illuminismo" - né prima né dopo la pubblicazione di quest'opera. Consiste in questo l'attualità permanente, così come il fascino (che oscilla fra identificazione entusiasta e rifiuto feroce), che il libro continua ad esercitare fino ad oggi. Chiaramente, la Dialettica dell'Illuminismo segna un limite critico davanti al quale la coscienza borghese arretra, in quanto dovrebbe mettersi fondamentalmente in discussione. I due autori stessi hanno sempre provato una certa apprensione di fronte alle conseguenze del loro pensiero. Horkheimer finì addirittura per ritornare nel giro dell'Aufklärung e della democrazia occidentale. E anche se Adorno non ha mai ritrattato la sua critica, in lui si possono trovare - nelle sue opere tardive - evidenti segni di frenata. In sostanza, la Dialettica dell'Illuminismo costituisce la testimonianza di una critica che, nell'aver paura di sé stessa, continua sempre a ritrarsi parzialmente. Almeno in parte, il suo movimento argomentativo non è inerente alla dialettica della cosa, bensì arriva a resisterle. Qui cercherò di mostrare e di svelare le cause - viste come prerequisiti affinché la critica dell'Aufklärung possa essere pensata fino alle sue conseguenze ultime.
1.
La critica dell'Aufklärung fatta da Horhkheimer ed Adorno riguarda essenzialmente il formalismo della ragione così come lo si trova espresso nel modo più puro in Kant, vale a dire l'indifferenza della ragione riguardo ad ogni contenuto particolare e la subordinazione della materia alla forma supposta dalla ragione. In tale formalismo risiede l'origine dell'hybris che costituisce allo stesso tempo la prigione del soggetto: finché l'oggetto che viene affermato essenzialmente come identico alla natura esteriore e (soprattutto) interiore non appare come qualcosa che dev'essere sottomesso, il soggetto non potrà liberarsi dalla costrizione cieca della seconda natura: del dominio. La ragione formalista si rivela quindi come principio del dominio, il contrario dell'emancipazione. Ed è precisamente in questo che si rivela strettamente legata al suo preteso avversario, il «contro-Aufklärung» o l'irrazionalismo. Questi non sono per niente «ciò che è radicalmente differente» ed ancor meno sono un qualche residuo del pensiero di prima dell'Aufklärung; essi rappresentano il lato oscuro della ragione e le sono irrimediabilmente legati. Alla fine, gli «scrittori oscuri e pessimisti» dell'epoca borghese - come hanno giustamente osservato Horkheimer e Adorno - non hanno fatto altro che dire esplicitamente ciò che l'Aufklärung implicitamente contiene. È per questo che sono sempre stati un tabù per la borghesia, odiati e ripudiati: «Il fatto di non aver mascherato, ma proclamato ad alta voce l’impossibilità di produrre, in base alla ragione, un argomento di principio contro l’assassinio, ha alimentato l’odio di cui proprio i progressisti perseguitano ancora oggi Sade e Nietzsche. Diversamente dal positivismo logico, l’uno e l’altro hanno preso in parola la scienza.» ("Dialettica dell'Illuminismo", p.129).
E un po' prima in questo libro, si può leggere: «Gli scrittori "neri" della borghesia non hanno cercato, come i suoi apologeti, di palliare le conseguenze dell’illuminismo con dottrine armonicistiche. Non hanno dato ad intendere che la ragione formalistica sia in rapporto più stretto con la morale che con l’immoralità. Mentre i chiari o sereni coprivano, negandolo, il vincolo indissolubile di ragione e misfatto, società borghese e dominio, gli altri esprimevano senza riguardi la verità sconcertante.» ("Dialettica dell'Illuminismo", p.126).
Evidentemente, quest'idea costituisce un vero e proprio affronto per tutti i portabandiera dell'Aufklärung che, fino ad oggi, ci vogliono far credere che la ragione moderna costituisce il culmine dell'evoluzione umana, del «progresso» e dell'umanità. Il verdetto è devastante. Ovvero, che cosa rimarrebbe ancora da salvare del pensiero dell'Aufklärung dal momento che la sua ragione è incapace di fornire un argomento di principio contro la morte e contro il fatto che essa intrattiene un legame indissolubile con il crimine. Si è detto che queste frasi sono state scritte sotto l'effetto del nazionalsocialismo e dei suoi crimini. Da qui, il loro pessimismo. È sicuramente vero, ma simili affermazioni non spiegano affatto quello che pretendono di spiegare. In quanto è proprio in seguito a questa felice congiunzione storica di una forte alleanza militare-politica che, nel nome dell'Aufklärung (interpretato da un lato come libertà e democrazia, e dall'altro come socialismo) ha lottato contro la barbarie nazista, che si è potuto concepire che la ragione non è stata affatto critica, ivi compreso dal punto di vista filosofico. Non verrà mai stimato abbastanza il fatto che Horkheimer e Adorno siano tuttavia rimasti coerenti con il loro pensiero [*2].
Osserviamo gli argomenti un po' più da vicino. La stretta relazione esistente fra la ragione formalista e il suo contrario oscuro si esprime attraverso il fatto che l'indifferenza riguardo il contenuto particolare va di pari passo con una razionalizzazione conseguente delle attuazioni. Horkheimer e Adorno lo dimostrano in maniera paradigmatica con l'esempio di Sade: «La ragione è l’organo del calcolo, della pianificazione; neutrale verso i fini, il suo elemento è la coordinazione. L’affinità di conoscenza e piano (fondata trascendentalmente da Kant), che dà all’esistenza borghese, razionalizzata fin nelle sue pause, un carattere, in tutti i particolari, di finalità ineluttabile, è stata esposta empiricamente da Sade un secolo prima dell’avvento dello sport.» ("Dialettica dell'Illuminismo").
Dal punto di vista della ragione formalista, in linea di principio è indifferente che uno organizzi una fabbrica, in cui si fabbricano delle moto o vi si torturi e si martirizzi un essere umano. Gli sforzi di Kant per distinguere una cosa dall'altra si infrangono - come dimostrano Horkheimer e Adorno - contro la logica del suo proprio sistema: «L’opera di Sade, come quella di Nietzsche, rappresenta invece la critica intransigente della ragion pratica, rispetto alla quale anche quella dello «schiacciatutto» appare come una ritrattazione del suo pensiero. [...] Kant, è vero, aveva già purificato la «legge morale in me» da ogni fede eteronoma al punto che il rispetto, contro le sue stesse assicurazioni, non era più che un dato naturale psicologico, come il cielo stellato su di me un dato naturale fisico. [...] Ma i fatti non contano dove non sono presenti.» ("Dialettica dell'Illuminismo").
Ciò diventa particolarmente evidente nel dovere kantiano di apatia secondo il quale l'essere umano non dovrebbe lasciarsi guidare dai suoi sentimenti, dalle sue inclinazioni e sensazioni, ma dovrebbe seguire esclusivamente la «legge morale», vale a dire il principio di forma astratto, trascendente ed epurato da ogni sensualità, il motto supremo della ragion pratica: «Agisci in maniera tale che il motto della tua volontà possa sempre valere allo stesso tempo come principio di una legislazione universale» ("Critica della ragion pratica"). Per l'applicazione di questo principio, i sentimenti e le inclinazioni non possono che essere dannosi, in quanto si riferiscono all'individuale, al particolare e non all'astratto né al generale; esitanti ed inaffidabili, bisogna eliminarli senza pietà. In questo contesto, il tipo di sentimento è senza importanza. Che si tratti dell'odio o dell'amore, del piacere che si prova a torturare o della compassione, tutto cade indistintamente sotto il verdetto dello «impuro» e del «patologico» [*3]. Perciò Kant sottolinea espressamente: «Anche questo sentimento di pietà e di tenera simpatia, se precede la considerazione di ciò che dev'essere il dovere e diventa un principio determinante, è un peso per le persone che pensano bene, porta il disordine nelle loro massime riflessive, e produce in loro il desiderio di sbarazzarsene e di essere sottomessi unicamente alla ragione e dalle sue leggi» (Critica della ragion pratica). E altrove si può leggere: «La virtù, [...] in quanto è fondata sulla libertà interiore, contiene per gli uomini anche un precetto affermativo, che è quello di ridurre sotto il proprio potere (sotto il potere della ragione) tutte le proprie facoltà e inclinazioni, e cioè quello del dominio su di sé, che si aggiunge al divieto di lasciarsi dominare dai propri sentimenti e dalle proprie inclinazioni (al dovere dell’apatia): poiché se la ragione non prende in mano le redini del governo, sono quelli a spadroneggiare sull’uomo»» (Principi metafisici della dottrina della virtù, citato in "Dialettica dell'Illuminismo).
Nel «dovere dell'apatia», Kant incontra sia Sade che Nietschze, che, a questo proposito, si esprimono in maniera pressoché identica. Per Nietschze, la compassione è «più dannosa di qualsiasi vizio», ed egli vede in essa una perfida invenzione del cristianesimo per impedire ai «forti» di fare ciò che viene loro di fare per «natura», ossia sottomettere i «deboli» per disporne a loro piacimento. ««Pretendere dalla forza, [...] che essa non si manifesti come forza, che non sia volontà di sopraffare, di abbattere e di dominare, sete di nemici, di resistenza e di trionfi, è esattamente altrettanto assurdo che volere che la debolezza si manifesti come forza».» ( Genealogia della morale, citata in "Dialettica dell'illuminismo" ).
Ciò di cui qui Nietschze fantastica, naturalmente è tutt'altra cosa da un'arcaica volontà di potenza, bensì è l'espressione del tutto moderna della disposizione interiore del soggetto della concorrenza capitalista liberata da ogni freno. Dichiarazioni simili si possono trovare negli innumerevoli manuali di management e negli opuscoli di propaganda social-darwinisti del liberalismo e del neoliberismo - un po' meno patetici, cero, ma non meno marziali. L'invocazione della natura non è infatti nient'altro, come sempre nel pensiero borghese (come lo è beninteso anche in Kant [*4]), che l'affermazione mistificata ed inconscia dell'ordine esistente e delle sue leggi della giungla secondarie [*5]. Questa è la «seconda natura» del valore, il movimento della valorizzazione come fine in sé, che impone agli uomini il «dovere dell'apatia», vale a dire l'indifferenza totale nei confronti del contenuto e delle successive conseguenze delle loro azioni e soprattutto nei confronti degli altri esseri, percepiti unicamente come dei concorrenti. Alla dinamica della violenza, della distruttività e dell'inumanità in tal modo scatenate, la ragione formale non ha niente da opporre, in quanto è inerente a tale dinamica. Ogni tentativo di farlo, come ad esempio l'intenzione kantiana di sostituire la compassione con il principio della «benevolenza universale del genere umano», rimane anch'esso prigioniero di questa logica che consiste nel sussumere la realtà sotto dei principi astratti e generali e che di conseguenza si vede condannato al fallimento: «L’illuminismo non si lascia truffare; in esso il fatto universale non è privilegiato rispetto a quello particolare, l’amore onnicomprensivo rispetto a quello limitato. La compassione è sospetta» ("Dialettica dell'illuminismo").
È questa logica che lega intimamente l'Aufklärung ed il contro-Aufklärung. La cosa diventa manifesta laddove Nietschze sembra distinguersi in maniera più netta da Kant, vale a dire nel rifiuto della legge universalmente valida e trascendente della ragione. È proprio qui che, senza volerlo, Nietzsche si trova profondamente d'accordo con Kant: «Egli nega bensì la legge, ma vuol appartenere all’"io superiore": non a quello naturale, ma a quello più-che-naturale. Vuole sostituire il superuomo a Dio, poiché il monoteismo, specie nella sua forma corrotta, quella cristiana, si lascia ormai scrutare come mitologia. Ma come, al servizio di questo "io superiore", i vecchi ideali ascetici vengono elogiati da Nietzsche come superamento di sé "per lo sviluppo della forza di dominio", così l’io superiore si rivela un disperato tentativo di salvare Iddio che è morto, il rinnovamento dell’impresa kantiana di trasformare la legge divina in autonomia, per salvare la civiltà europea che ha reso l’anima nello scetticismo inglese. Il principio kantiano di "agire sempre in base alla massima della propria volontà considerata come tale che possa avere insieme a oggetto se stessa come volontà universalmente legislatrice", è anche il segreto del superuomo. La sua volontà non è meno dispotica dell’imperativo categorico» ("Dialettica dell'Illuminismo").
Che da queste constatazioni di Horkheimer ed Adorno derivino necessariamente pessimismo e rassegnazione, sembra inevitabile. Poiché se è la ragione stessa ad essere totalmente penetrata dal dominio e ad essere inseparabile dal suo polo opposto irrazionalista (contreaufklärerisch), come può essere ancora possibile un'emancipazione sociale? In senso stretto, non sarebbe nemmeno più pensabile e non si capirebbe più neppure perché una critica dell'Irrazionale esistente dovrebbe essere possibile dal momento che ogni pensiero guidato dalla ragione si rovescia necessariamente in irrazionalità. Tuttavia, questo pessimismo radicale non risulta - come è stato spesso detto - da una critica dell'Aufklärung che si è spinta troppo avanti ma, al contrario, deriva dal fatto che Horkheimer ed Adorno condividono alcune delle premesse fondamentali e dei presupposti intellettuali dell'Aufklärung, e questo non lo tematizzano né lo mettono in discussione, ma se ne servono come base di partenza, sia in maniera esplicita che implicita. È proprio per questo motivo che la loro critica non va troppo lontano ed è principalmente per questo che si trovano continuamente costretti a revocarla al fine di proteggersi dalle conseguenze pessimistiche del loro stesso pensiero. Solo mettendo in evidenza questi punti ciechi, si potrà venir fuori dalle aporie della Dialettica dell'Illuminismo senza relativizzare il progetto che viene attuato.
2.
Il problema fondamentale consiste nel fatto che Horkheimer e Adorno si misurano con dei concetti di Aufklärung e di ragione che, storicamente parlando, sono assai poco specifici. In sostanza, identificano l'Aufklärung con il pensiero razionale tout court, vale a dire con ciò che avrebbe reso possibile all'uomo di liberarsi dalla mitologia. Concepiscono l'Aufklärung come il «disincantamento del mondo» - un evidente debito nei confronti di Max Weber - come si può leggere nella prima frase della Dialettica dell'Illuminismo: «L’illuminismo, nel senso più ampio di pensiero in continuo progresso, ha perseguito da sempre l’obiettivo di togliere agli uomini la paura e di renderli padroni. [...] Il programma dell’illuminismo era di liberare il mondo dalla magia. Esso si proponeva di dissolvere i miti e di rovesciare l’immaginazione con la scienza.» ("Dialettica dell'Illuminismo"). Ma, come accade sempre quando il ragionamento diventa trans-storico e storicamente non specifico (e quindi implicitamente antropologico), si tratta di una proiezione - di una retro-proiezione delle condizioni di vita borghese su tutta la storia precedente. In questo caso, si tratta del concetto specificamente moderno di ragione di Aufklärung che, va da sé, viene assunto in senso trans-storico e reso retrospettivamente universale.
Jappe: «In generale, si ha l'impressione che, in Adorno, i tratti specifici delle diverse epoche storiche spariscano di fronte all'azione di alcuni principi eternamente simili, quali il dominio e lo scambio, che esisterebbero fin dall'inizio. Nella Dialettica dell'Illuminismo, la genesi storica dei concetti identificatori viene situata in un'epoca assai lontana. La logica nasce dai primi rapporti di subordinazione gerarchica, laddove il "me", identico nel tempo, da inizio all'identificazione delle cose attraverso la loro classificazione in un genere. L'affermazione: "Unità rimane la parola d’ordine, da Parmenide a Russell. Si continua a esigere la distruzione degli dei e delle qualità."[Dialettica dell'Illuminismo], questa affermazione significa che agisce la stessa "ragione" sia nell'era pre-socratica che al giorno d'oggi. Quindi, in sostanza, per Adorno, superare la reificazione dovrebbe essere impossibile, dacché la vede radicata nelle strutture più profonde della società» [*6].
È vero che, concretizzando la loro critica, Horkheimer e Adorno (nella Dialettica dell'Illuminismo, così come nella maggior parte dei loro scritti più tardivi) criticano sempre la filosofia classica dell'Illuminismo dell'era borghese, o dei suoi successori, così come la sua critica irrazionalista; si tratta quindi di un'epoca storica assai particolare quella che loro hanno in mente. Ciò diventa evidente soprattutto quando la critica contro il formalismo della ragione in Kant si fa più precisa. Ma, allo stesso tempo, si suppone che questa critica assuma come bersaglio anche le epoche precedenti ed il loro pensiero. Ma questa ambizione storica globale rimane un programma non realizzato - e non è affatto a caso, dal momento che il tentativo di realizzare questa pretesa rende visibile il suo carattere proiettivo, come si vede nel celebre passaggio su Ulisse, che viene descritto come il prototipo del carattere borghese (anche se ancora in parte prigioniero del mito) [*7].
Naturalmente, Horkheimer e Adorno non negano affatto che la ragione e l'Aufklärung si siano sviluppate solamente nel corso di un processo storico, per diventare ciò che esse sono diventate nell'epoca borghese e quello che sono sempre state. Ma questo processo, così come lo descrivono, o piuttosto così come lo suggeriscono, reca indubitabilmente i tratti della filosofia razionalista e borghese della storia (aufklärerisch). In sostanza, questo processo viene descritto come un'evoluzione teologica, come l'emergere di qualcosa che era contenuto nelle prime scintille della ragione o, più precisamente, nella prima tappa della separazione dalla natura (poiché la magia ed il mito avrebbero anch'esse contenuto in nuce la razionalità, di modo che così potessero, da parte loro, continuare a sopravvivere nella razionalità). In generale, il punto centrale si trova nella mancata separazione con la natura, che si sarebbe trasformato in rapporto di dominio - un pensiero che sta alla base di tutta la Dialettica dell'Illuminismo [*8]. Per citarne solo un passaggio: «Ogni tentativo di spezzare la costrizione naturale spezzando la natura, cade tanto più profondamente nella coazione naturale. È questo il corso della civiltà europea.» ("Dialettica dell'Illuminismo").
A tal proposito, Horkheimer e Adorno affermano espressamente di non limitarsi a voler descrivere il passaggio dalla bestia all'uomo ed il rapporto fra l'uomo e la natura così come esisteva nella preistoria e nella storia primitiva - cosa che, del resto, non potrebbe essere altro che speculazione: l'inizio dell'umanità si perde nella notte dei tempi. Piuttosto, Horkheimer e Adorno pensano di aver trovato in quest'evoluzione il punto di partenza determinante, la base di tutta la storia dell'uomo e, a partire da questo, la base di ogni evoluzione della storia intellettuale. All'inizio, si trova una sorta di peccato originale secolarizzato, un peccato originale che - in quanto prezzo dell'umanizzazione - probabilmente è stato inevitabile, ma che estende il suo dominio su tutti gli eventi successivi. La storia viene interpretata come subordinazione progressiva della natura esteriore e (soprattutto) interiore, un processo in cui si può dedurre anche il dominio dell'uomo sull'uomo che si prolunga e si addensa incessantemente. Così si può leggere in un frammento alla fine della Dialettica dell'Illuminismo: «Una costruzione filosofica della storia universale dovrebbe mostrare come, nonostante tutti i détours e le resistenze, il dominio coerente della natura si impone sempre più nettamente e integra ogni interiorità. Da questo punto di vista bisognerebbe dedurre anche le forme dell’economia, del dominio, della cultura.» ("Dialettica dell'Illuminismo").
Questa frammento reca il titolo di «Per la critica della filosofia della storia», un titolo un po' abusivo. In quanto ciò che viene qui presentato in maniera esplicita (e che implicitamente costituisce la base della Dialettica dell'Illuminismo nel suo insieme, e in line di principio anche la base del pensiero tardivo di Horkheimer e Adorno) non è altro che un abbozzo filosofico-storico del tutto nella tradizione dell'Aufklärung. La differenza non consiste altro che nella sua costruzione rassegnata. Non è più la marcia trionfale del progresso, che viene descritta, bensì la marcia fatale del destino. Tutt'al più, la liberazione del dominio appare come una possibilità che è stata intravvista in maniera intermittente e che non può più essere fondata; in ogni caso, non appare più come il punto finale necessario della storia. Questa critica del pensiero del progresso, per quanto sia giusta ed importante, rimane nondimeno prigioniera dello stesso pensiero che vuole assumere come bersaglio. Limitandosi a rifiutare l'ottimismo (la pretesa necessità della liberazione), non fa altro che riprodurre negativamente la costruzione filosofico-storica sulla quale tale pensiero si fonda: «Dal momento che la storia come oggetto di una teoria unitaria, come qualcosa di costruibile, non è il bene, ma - appunto - l’orrore, il pensiero è, in realtà, un elemento negativo.» ("Dialettica dell'Illuminismo").
L'interpretazione teleologica della storia, in quanto tale, è già una proiezione arci-borghese. A tal riguardo, il fatto che essa rivesta un aspetto negativo o positivo è secondario [*9]. L'idea per cui la storia dell'umanità progredisce verso uno stadio finale determinato, dominato e guidato da un impulso interiore irresistibile, porta troppo visibilmente il marchio dell'agitazione febbrile, della volontà di espansione e della dinamica della concorrenza della società capitalista moderna. La retro-proiezione sulla storia nel suo insieme di questo rapporto è essa stessa l'espressione (inconscia) dell'hybris e delle pretese universalistiche e dominatrici della modernità produttrice di merci, che non risparmia nemmeno la storia pre-borghese. Se quest'ultima non può essere accaparrata retrospettivamente in maniera reale, bisogna almeno recuperarla ideologicamente. In quanto il valore, proprio come il Dio del monoteismo, non tollera niente fuori da esso [*10]. Horkheimer e Adorno, da parte loro, fanno precedere questo recupero da un segno negativo. La ragione formalista e la forma specificamente moderna della formazione della natura (esteriore ed interiore) che l'accompagna, non vedono tutto questo come un aspetto essenziale di un rapporto sociale determinato, costituito dalla merce e dal valore, ma inversamente come la prosecuzione conseguente e come l'aggravarsi di una tendenza la cui origine sarebbe proprio questa mancata separazione dalla natura. «Il pensiero è sorto nel corso della liberazione dalla natura terribile, che - alla fine - viene totalmente asservita.» ("Dialettica dell'Illuminismo").
E anche: «Per sfuggire al timore superstizioso della natura, esso ha smascherato implacabilmente le unità e le forme oggettive come travestimenti di un materiale caotico e ha condannato come schiavitù l’influsso di questo materiale sull’istanza umana, finché il soggetto è interamente diventato - in teoria - la sola, illimitata e vuota autorità. [*11]» ("Dialettica dell'Illuminismo").
Ciò che Horkheimer e Adorno non vedono, è il fatto che così non fanno altro che riprodurre simmetricamente una delle ideologie di legittimazione della società produttrice di merci, ideologia secondo la quale la forma moderna del rapporto dell'Uomo con la natura potrebbe essere dedotto direttamente e in linea retta dalla lotta che il primo avrebbe condotto contro la seconda a partire dal primo istante della storia. Secondo tale concezione, le scienze naturali moderne ed il dominio della natura mediato da esse costituirebbero la conseguenza logica di un'evoluzione che sarebbe cominciata con un pugno per raggiungere temporaneamente il suo culmine con l'ingegneria genetica. Certo, Horkheimer e Adorno presentano in modo critico ciò che serve ufficialmente a giustificare ogni crimine e misfatto commesso nel nome della «Scienza» e del «Progresso». Nondimeno, rimane il fatto che il carattere proiettivo dell'argomentazione non viene spezzato, ma anzi viene ad essere confermato e rafforzato.
Anche qui, l'anello argomentativo consiste nel fatto che, dietro il requisito indispensabile più generale della cultura e della società, vale a dire lo smarcamento dell'uomo rispetto alla natura, le forme specificamente storiche e qualitativamente del tutto differenti, in cui si è svolta tutta la storia passata, si confondono. La forma moderna del concetto di natura e del rapporto con essa non è pertanto il prolungamento e l'aggravarsi di un'evoluzione più o meno continua ed identica a sé stessa, da quando l'essere umano ha smesso di essere una scimmia; ma essa rappresenta, al contrario, una rottura radicale con tutto ciò che l'ha preceduta. Tutto questo, possiamo capirlo solo se consideriamo questa forma moderna come il riflesso della forma sociale e del modo di produzione che si sono imposti a partire dall'inizio della modernità europea e non l'inverso, come affermano Horkheimer e Adorno [*12].
È questa la ragione per cui - come hanno dimostrato Hartmut e Gernot Böhme (Das Andere der Vernunft, 1985) – l'immensa paura che prova l'individuo borghese davanti alla natura interiore ed esteriore non è semplicemente il retaggio represso di un'ancestrale «superstiziosa paura davanti alla natura» (Horkheimer e Adorno) e la causa primaria della costituzione della forma moderna del dominio imposto alla natura, ma è al contrario co-originaria; è allo stesso tempo il prodotto della forza motrice interiore del soggetto in seno ad un processo storico specifico.
«Esiste una tensione di angoscia fra la ragione [moderna] e la natura interiore ed esteriore che essa domina. Questa tensione viene negata nella coscienza di sé guidata dalla ragione ed a maggior ragione nel discorso filosofico. La paura reale che riempie l'essere umano pre-razionale nel suo comportamento a fronte delle forze naturali, a fronte degli irresistibili movimenti emotivi del proprio corpo e di fronte a degli individui potenzialmente pericolosi, lascia il posto ad una paura interiore ed irrazionale davanti al rimosso. Tale paura non può apparentemente essere superata se non al prezzo della rovina dell'Io nel quale l'uomo pensa di essere entrato in possesso di sé stesso» (H. et G. Böhme, Das Andere der Vernunft, p. 18) [*13].
Quindi non si tratta solamente della ragione moderna che è storicamente specifica, ma anche del suo «altro», del suo «rovescio» tanto desiderato quanto temuto, e che si trova separato da essa. Questo rovescio si forma via via e nella misura in cui la ragione moderna delimita il suo territorio, escludendo tutto ciò che non può (o non può ancora) sottomettere, dichiarandolo a partire da quello «naturale» e «irrazionale». Si tratta di un processo che è legato in maniera costitutiva al rapporto fra i sessi nel modo in cui è caratteristico per l'era moderna e borghese [*14] La «Donna» ed il «Selvaggio» si densificano in figure di proiezione centrali per tutto ciò che non trova il suo posto nella Ragione: «La ragione moderna si pone da sé sola i suoi propri limiti. Il suo territorio si estende fino al punto in cui essa può ancora appropriarsi del suo "altro". Di conseguenza, la formazione della ragione moderna è un processo di smarcamento, di selezione e di redistribuzione. Noi lo chiamiamo "Illuminismo" come se si trattasse solo di chiarire [klären] ciò che è. In realtà, è della definizione della realtà che si tratta [...]. La ragione [pre-moderna] rispettava il suo "altro" come il Papa rispettava l'Imperatore. È solo con l'Illuminismo che la ragione trasforma in irrazionale tutto ciò che esce dal suo quadro» (idem, p.13).
Se non si percepisce questa specificità storica della ragione moderna, la rottura radicale che rappresenta in rapporto ad altre forme della riflessione umana in generale, ed in rapporto ad altre forme della riflessione umana in generale, ed in rapporto con la natura in particolare, allora l'orrore del 20° secolo in effetti non può accadere - secondo Horkheimer e Adorno - se non come il punto culminante di una fatalità inerente (il che non vuol dire per forza necessaria ed inevitabile in senso stretto) alla storia dell'Uomo a partire dall'inizio. Il dominio sociale si lascia presumibilmente dedurre dal dominio dell'uomo sulla natura, il capitalismo sviluppato si fissa allora sotto la forma della comparsa, storicamente la più avanzata, di un'essenzialità trans-storica: punto culminante del dominio razionalizzato, il capitalismo è allo stesso tempo l'espressione più estrema del rapporto di dipendenza dalla natura, il fascismo ed il nazionalismo rappresentano, quanto ad essi, l'aggravamento più estremo di questa tendenza. Ma, ancora una volta, si assiste qui di fatto alla retro-proiezione nella storia del rapporto sociale e del dominio moderno - o piuttosto di una certa interpretazione di questi -, cui viene conferita una dignità negativa sovratemporale. Allo stesso tempo, i suoi contorni si confondono nella nebbia grigia di un'oscura preistoria.
È precisamente questa visione essenzialmente trans-storica e in definitiva antropologizzante che Horkheimer e Adorno hanno in comune con il pensiero dell'Illuminismo che, com'è noto, ipostatizza la società borghese in «società tout court» opponendola ad un presunto stato di natura. Le culture e le società non capitaliste appaiono tutt'al più come i logici precursori della modernità, come delle tappe intermedie più o meno arretrate sulla strada che porta allo stadio supremo dell'evoluzione dell'Uomo (come espresso, ad esempio, dal termine «popolo primitivo» che oscilla fra razzismo ed esotismo). Di conseguenza, tutti gli aspetti e tutti i fenomeni negativi della società capitalista passano per essere l'eredità del supposto stato di natura, il quale - evidente proiezione della concorrenza spietata del capitalismo - viene fantasticato come la lotta crudele di tutti contro tutti. La civiltà viene sempre descritta come un sottile strato di vernice sopra questo stato di natura supposto come violento, sono necessari continui sforzi per frenare «il vecchio Adamo». In questo modo, si può esternalizzare ideologicamente ogni focolaio di violenza e di irrazionalismo in quanto irruzione della «barbarie», di una natura che si pretende pre-civile o di una semi-cultura pre-moderna, che giustifica ogni possibile ed immaginabile «sforzo civilizzatore» - in caso di bisogno, anche a colpi di bombe e di missili.
Certo, Horkheimer e Adorno si attaccano in maniera virulenta a questa auto-giustificazione tanto grossolana quanto sfacciata mostrando così che l'irrazionalismo non è altro che la faccia nascosta della ragione dell'Aufklärung e che non ci può essere l'uno senza l'altro. Ma dal momento che essi stessi retro-proiettano anche l'immagine occidentale deformata della «barbarie» - anche e sotto una forma più riflessiva: «Estirpare dalle radici l’odiata, irresistibile tentazione di ricadere nella natura, ecco la crudeltà che ha origine dalla civiltà fallita, la barbarie come rovescio della cultura.» (Dialettica dell'Illuminismo).
È vero che, in Horkheimer e Adorno, «la barbarie» in cui la civiltà minaccia di ricadere in ogni momento non deriva direttamente dalla prima natura ma ha le sue radici, così come la ragione stessa, nella mancata separazione con essa. Horkheimer e Adorno vanno al di là dell'Illuminismo e di Kant nella misura in cui, ricorrendo alla teoria freudiana, sviluppano il rapporto fra cultura e natura come un rapporto dialettico. La «natura interiore» si vede essa stessa trasformata nel corso del processo di sublimazione della cultura - quindi essa non rimane ciò che è stata o avrebbe potuto essere: non è affatto «originaria»: I comportamenti preistorici che la civiltà dichiara tabù, trasformati in comportamenti distruttivi stigmatizzati come bestialità, avevano continuato a condurre un'esistenza sotterranea. «Juliette [l'eroina di Sade] li esegue, non più come naturali, ma proprio perché vietati. [...] Quando essa ripete le reazioni primitive, esse non sono più, così, primitive, ma bestiali.» (Dialettica dell'Illuminismo).
Per quanto giusta sia quest'idea (essa mette in luce la repressione della ragione), rimane nondimeno, per la sua concezione antistorica della cultura e della civiltà, prigioniera dell'universo proprio al pensiero dell'Aufklärung [*15]. Le conseguenze sono considerevoli. Se si rompe con il progressismo ottimista dell'Aufklärung, conservandone la costruzione storica presentata negativamente, ne consegue necessariamente un pessimismo integrale così come lo si trova del resto in numerosi rappresentanti dell'irrazionalismo, ma anche nell'opera tardiva di Freud. Bisogna allora scartare la possibilità di un'emancipazione del dominio e del rapporto feticista. Per sfuggirvi, Horkheimer e Adorno sono obbligati a proibirsi di pensare fino alle sue ultime conseguenze il rapporto intrinseco fra la ragione e l'irrazionalismo. La dialettica della ragione dovrebbe contenere malgrado tutto - quasi smentendo così anche la propria critica - un potenziale di emancipazione che aspetterebbe sempre di essere realizzato. A tal proposito, si può leggere nell'introduzione alla Dialettica dell'Illuminismo: «[...] l’illuminismo deve prendere coscienza di sé, se non si vuole che gli uomini siano completamente traditi. Non si tratta di conservare il passato, ma di realizzare le sue speranze.» (Dialettica dell'Illuminismo).
Se ci si accontentasse di leggere queste frasi in un testo generale secondo cui il pensiero critico-riflessivo sarebbe la condizione della possibilità dell'emancipazione sociale, allora ci sarebbe poco da ridire. Ma identificando implicitamente l'Illuminismo, vale a dire la ragione moderna (o Aufklärung), al pensiero riflessivo tout court, Horkheimer e Adorno ne prefigurano la sua riabilitazione come l'ulteriore evoluzione teorica dei due autori avrebbe mostrato (sebbene in maniera differente).
3.
Infatti, se in "Critica della Ragione Strumentale" Horkheimer e Adorno avevano già difeso l'Aufklärung contro la loro stessa critica formulata in "Dialettica dell'Illuminismo", possiamo vedere la medesima preoccupazione in "Dialettica negativa" di Adorno. A tal riguardo, la celebre prima frase di questo libro può essere letta come un programma: «La filosofia, che una volta sembrò superata, si mantiene in vita, perché è stato mancato il momento della sua realizzazione» ("Dialettica negativa"). Benché Adorno non riprenda affatto la critica della ragione formale e della logica dominatrice che le è immanente, si sforza allo stesso tempo di scoprire continuamente dei potenziali emancipatori, cercando in questo modo di salvare malgrado tutto l'Aufklärung. Si possono vedere benissimo le aporie in cui si impiglia, quando, nella terza parte della Dialettica negativa, intraprende la sua discussione della nozione kantiana della libertà.
Adorno mette l'accento - giustamente - sul carattere terribilmente repressivo del concetto kantiano di libertà che mostra tutti i tratti del dominio borghese: «In Kant libertà significa la ragion pura pratica che produce da sé i suoi oggetti; essa non tratterebbe "degli oggetti per conoscerli, ma della propria facoltà di produrli (secondo la conoscenza di essi)". La qui implicata autonomia assoluta della volontà sarebbe il dominio assoluto sulla natura interna. Kant esalta che "essere coerente è il dovere piú grande di un filosofo, eppure è quello che vien soddisfatto piú di rado". Ciò sottende non soltanto la logica formale della pura deduzione come massima istanza morale, ma al contempo la subordinazione di ogni pulsione all’unità logica, il suo primato sul diffuso della natura, in fondo su ogni varietà del non identico; nel cerchio chiuso della logica quella appare sempre come incoerente. Nonostante la soluzione della terza antinomia la filosofia morale kantiana resta antinomica: conformemente all’intera concezione, essa è in grado di rappresentare il concetto di libertà solo come repressione. Tutte le concretizzazioni della morale hanno in Kant tratti repressivi. La sua astrattezza è sostanziale, perché espelle dal soggetto ciò che non corrisponde al concetto puro di esso. Da qui il rigorismo kantiano.» ("Dialettica negativa").
Ma mentre nella Dialettica dell'Illuminismo si metteva ancora in evidenza il legame di parentela fra Kant e gli «scrittori oscuri» del «contro-Aufklärung», stavolta il verdetto è significativamente più clemente- La critica, in sé devastante, secondo la quale Kant non saprebbe «concepire la libertà se non come costrizione» (Dialettica negativa) viene relativizzata, essa non costituirebbe più il vero nucleo del suo pensiero ma sarebbe soltanto la prova di una contraddizione interna: «il paradosso della dottrina kantiana della libertà» (Dialettica negativa). Per cui, Kant rappresenterebbe in particolare - così come l'Illuminismo rappresenterebbe in generale - l'idea di libertà, ma avrebbe finito per arretrare di fronte al compito di pensarla fino alle sue ultime conseguenze, vale a dire nel senso di una vera e propria liberazione dal dominio. Tuttavia, quest'idea continuerebbe a sopravvivere nel suo pensiero- spezzata e tradita - come un aspetto residuale e contraddittorio, come «residuo». Gli sforzi di Adorno tendono perciò a rivelare tale «residuo» per difenderlo contro la logica dominatrice del razionalismo stesso. Tenta quindi di spiegare la (pretesa) contraddizione interna del concetto kantiano di libertà sviluppandolo a partire da una logica storica: «Dal secolo XVII la grande filosofia aveva definito la libertà come il suo interesse piú proprio; con l’implicito mandato della classe borghese di fondarla in modo trasparente. Quell’interesse è però internamente antagonistico. Va contro la vecchia repressione e incrementa quella nuova insita nello stesso principio razionale. Viene cercata una formula comune per la libertà e la repressione: quella viene ceduta alla razionalità che la limita e l’allontana dall’empiria in cui non la si vuole affatto vedere realizzata. Questa dicotomia si connette anche alla progressiva scientifizzazione. La classe borghese è alleata con questa in quanto incrementa la produzione, e deve temerla non appena intacca la fede nell’esistenza della sua libertà, già rassegnata all’interiorità. Questo sta realmente dietro la dottrina delle antinomie.» (Dialettica negativa).
Ciò che in primo luogo colpisce, è il fatto che questa storicizzazione reca anch'essa innegabilmente i tratti della filosofia della storia dell’Aufklärung e del suo erede: il «materialismo storico». Tutta la storia fino ai nostri giorni viene concepita come una successione di differenti forme di dominio di classe: il motore generale è lo sviluppo delle forze produttive che rappresenta qui, in Adorno, la separazione con la natura. Alla luce di questa pretesa logica trans-storica dello sviluppo, la classe borghese appare relativamente progressista, ma, al fine di garantire il suo dominio, avrebbe finito per neutralizzare la libertà relegandola in una sfera idealizzata dell'interiorità per liquidarla nella vita reale. In quanto rappresentante di questa classe, Kant avrebbe anticipato quindi già nel suo pensiero ciò che è stato realizzato più tardi nella società reale: «Kant, come gli idealisti dopo di lui, non può sopportare una libertà senza coercizione; già a lui la concezione non deformata di essa procura quella paura dell’anarchia che poi raccomandò alla coscienza borghese di liquidare la sua libertà.» (Dialettica negativa).
Ciò che differenzia questa prospettiva da quella del marxismo tradizionale, è innanzitutto il «pessimismo critico» (Postone, "Time, Labor and Social Domination", Cambridge, 1993, p. 84) - anche se qui il tono è un po' meno cupo di quanto lo sia in Dialettica dell'Illuminismo. In generale, l'inversione della metafisica storica borghese viene ad essere anche la base su cui riposa l'opera tardiva di Adorno. A riapparire in differenti varianti, è sempre la medesima idea di base secondo la quale una dialettica di razionalità e di irrazionalità, di libertà e di dominio, sarebbe stata contenuta fin dal primo passo della separazione dell'Uomo dalla Natura; è questa dialettica che avrebbe determinato ogni ulteriore evoluzione. Anche se, altrove, Adorno ha sostenuto questo punto di vista dal punto di vista della teoria freudiana della cultura (anch'essa rassegnata), qui si riferisce all'aspetto della teoria di Marx che è rimasta ancora totalmente dipendente dal mito del progresso dell'Aufklärung, presentandolo in maniera pessimistica. In base a tutto questo, la società borghese appare fondamentalmente come una tappa storica necessaria sulla strada che porta alla liberazione da ogni potere (di classe) e da ogni repressione. Ma la fede in una classe che sarebbe l'erede della borghesia e che farebbe il passo successivo e decisivo verso il socialismo o il comunismo, quella fede che il marxismo tradizionale ha celebrato alla maniera di una religione secolarizzata, è un ferrovecchio. Il potenziale emancipatore di una liberazione dalle costrizioni naturali e dal dominio doveva essere contenuto nello sviluppo delle forze produttrici, e quindi la classe borghese ne doveva essere essa stessa il portatore sociale, ma non ha realizzato questo potenziale, essendo stata un consolidamento del dominio. Tutto ciò si vedrebbe già in Kant quando questi non arriva ad immaginare la liberà se non nel senso di un imperativo categorico: «Che Kant si affretti a pensare la libertà come legge tradisce che egli non la prende sul serio, come da sempre la sua classe. Quando ancora non aveva timore del proletariato industriale, essa uní, in specie nell’economia di Smith, al prezzo dell’emancipazione individuale l’apologia di un ordine, in cui da un lato la invisible hand provvederebbe sia al mendicante che al re, mentre dall’altro in esso pure il libero concorrente dovrebbe comportarsi con feudale fair play.» (Dialettica negativa).
Tuttavia, questa interpretazione della concezione kantiana della libertà come potenzialmente emancipatrice, o come stadio transitorio di un progresso storico dell'emancipazione umana mai realizzata, anche se possibile, non è affatto fedele ai propositi dello stesso Kant. Quando Kant parla esplicitamente della libertà come di una «stretta causalità», come di una legge e di una «costrizione», questo viene pensato in maniera del tutto conseguente. «Conseguente», di certo non in rapporto a questa o a quell'altra posizione di classe o logica di sviluppo trans-storica, ma in rapporto alla forma della società capitalista che è il presupposto - in quanto costituente - di tutte le categorie sociali borghesi: la forma merce o la forma valore. È proprio essa che impone agli esseri umani le sue leggi come se si trattasse di leggi naturali eterne, quando in realtà queste sono le sue proprie relazioni sociali che, sotto la forma di una «oggettività» apparentemente immutabile, si oppongono a loro in quanto potenza pretesamente straniera per dominarli. A questo feticismo della forma merce decifrato da Marx, Kant (come più tardi Hegel), con le sue categorie idealistiche, si avvicina assai più - anche se per niente in una visione critica - dei tentativi ulteriori dei marxisti che cercano di analizzarlo in maniera materialistica. Ciò che regolarmente sfugge a questi ultimi, è che l'idealismo non ha torto quando attribuisce alla società borghese un carattere metafisico, anzi ha perfettamente ragione a farlo, solo che qui non si tratta di una trascendenza in senso idealista ma del carattere metafisico-reale della forma valore e della forma merce. Il fatto che Kant comprenda la massima suprema della ragione pratica, l'imperativo categorico, come una forma pura e non empirica, deprivata di ogni contenuto, e precedente ad ogni contenuto determinato, dev'essere visto come un riflesso idealista di questo rapporto feticistico. La libertà, come egli la concepisce, è perciò la condizione necessaria che rende possibile questa legge oggettivata e spietata della ragione. È solo quando questa condizione viene soddisfatta che si può supporre una volontà che dev'essere, in quanto tale, una volontà libera. Ed è perciò che, in Kant, questa volontà viene definita nel modo più rigoroso: «La volontà è una sorta di causalità degli esseri viventi, in quanto ragionevoli, e la libertà sarebbe la proprietà che avrebbe questa causalità di poter agire indipendentemente dalle cause estranee che la determinano [...] Così come il concetto di una causalità implica in sé il concetto delle leggi, secondo cui qualsiasi altra cosa che noi chiamiamo effetto dev'essere posta da qualcosa che sia la causa, la libertà, benché essa non sia una proprietà della volontà che si conforma a delle leggi della natura, tuttavia non si trova al di fuori di ogni legge; al contrario, essa dev'essere una causalità che agisce secondo delle leggi immutabili, ma delle leggi di una specie particolare, in quanto diversamente una volontà libera sarebbe un'aberrazione [...]. In che cosa, dunque, può consistere la libertà della volontà, se non in un'autonomia, vale a dire nella proprietà che essa ha di essere allo stesso tempo la sua legge? Ora, questa proposizione: la volontà in tutte le azioni è essa stessa la sua legge, è un'altra formula di questo principio: bisogna agire solo secondo una massima che possa anche essere presa essa stessa come oggetto di una legge universale. Ma questa è precisamente la formula dell'imperativo categorico ed il principio della moralità; una volontà libera ed una volontà sottomessa a delle leggi morali sono di conseguenza una sola ed una stessa cosa» (Fondamenti della metafisica dei costumi"). Dunque, in Kant, la libertà è per natura autocontrollata e questo non significa altro se non il dominio dei soggetti borghesi su sé stessi sotto il diktat presupposto della forma valore e della forma merce. È quindi a giusto titolo che Kant le conferisca un carattere di legge rigorosa, cosa che non contraddice in niente la logica interna della sua teoria. Poiché la libertà kantiana non è libertà liberata dal dominio tout court, ma è una dimensione strutturale necessaria di una forma assolutamente specifica di dominio: di un dominio astratto dove tutti gli esseri sono diventati - in un modo o nell'altro - le categorie funzionali e le «maschere di carattere» (Marx) del valore e, in quanto tali, da sempre non autonomi ed assoggettati a questo principio sociale. La loro «autonomia», tanto invocata da Kant, non è altro che la costrizione a sottomettersi in permanenza alle leggi del funzionamento generale della forma merce. La «legge della libertà» che li ha costituiti in quanto soggetti borghesi non ordina nient'altro che l'indifferenza («l'apatia») nei confronti di ogni sentimento, di ogni bisogno sensibile, di ogni relazione personale e di ogni emozione particolare che fuoriesca dal quadro fissato dalla logica della valorizzazione e della concorrenza. Questo, Adorno lo ha constatato, egli stesso, ma in una maniera differente. Lo ha anche scritto espressamente in uno dei suoi ultimi saggi dal titolo «Soggetto ed Oggetto»:
«In un certo senso - che l'idealismo sarebbe il primo ad ammettere, è vero - il soggetto trascendentale è più reale, vale a dire più determinante per il comportamento effettivo degli individui e della società cui essi hanno dato origine di quanto non lo siano gli individui psicologici che hanno astrattizzato la parte trascendentale e che, nel mondo, non hanno voce in capitolo; sono diventati a loro volta delle appendici della meccanica sociale e infine un'ideologia. L'individuo vivente, che è costretto ad agire in un certo modo e che è stato modellato per questo, somiglia, in quanto incarnazione dell'homo oeconomicus, più al soggetto trascendentale che all'individuo vivente che deve credere di essere. È in tale misura che la teoria idealista era realista e non si vergognava di affrontare gli avversari che le rimproveravano il suo idealismo. La dottrina del soggetto trascendentale traduce fedelmente la priorità delle relazioni astratte e razionali che si sono staccate dagli individui e dai rapporti che essi intrattengono fra di loro, rapporti il cui modello è lo scambio. Una volta che la forma dello scambio diviene la struttura determinante della società, la sua razionalità costituisce l'essere umano; il come gli uomini si percepiscono l'un l'altro, e allora ciò che essi credono di essere diventa secondario» (Adorno, Modelli critici).
Così, alla fine Adorno smentisce la sua stessa affermazione della Dialettica dell'Illuminismo secondo cui Kant non è mai stata tanto rigoroso come con la libertà. In quanto quest'affermazione implica un concetto di libertà che Kant non ha mai sostenuto e che, qualunque cosa si faccia, non può essere rintracciato nella sua opera. Nelle condizioni che costituiscono la base del suo pensiero, nessuno ha pensato la libertà borghese con altrettanto rigore e conseguenza di Kant. La contraddizione del suo pensiero risiede non nel fatto che la libertà non realizzi la sua pretesa emancipatrice, ma nel fatto che egli rimanga prigioniero delle sue aporie. È vero che, misurata sul metro di una concezione enfatica di liberazione, liberazione da ogni dominio, le categorie kantiane possono e devono essere criticate come repressive. Ma è altra cosa dall'affermare che Kant avrebbe tradito la sua idea di libertà. Se malgrado tutto Adorno lo fa, ciò è dovuto piuttosto al fatto che, sullo sfondo della sua filosofia della storia (che rimane in ultima analisi "illuminista"), l’Aufklärung in generale, ed il pensiero kantiano in particolare, devono necessariamente apparire come uno stadio transitorio - per quanto mutilato sia - del progresso emancipatore, anche laddove la lucidità critica arretra davanti ad una simile constatazione.
4.
Questo freno alla critica si fa sentire proprio laddove Adorno approccia da vicino la decrittazione dell'idealismo e della metafisica. Lo si vede chiaramente anche nella Dialettica Negativa dove, appoggiandosi a Sohn-Rethel, decifra il soggetto trascendentale di Kant in quanto riflesso idealistico del lavoro, del dominio e del principio di equivalenza. Anche se qui compie un passo decisivo al di là dell'Aufklärung e del marxismo tradizionale e del suo crasso materialismo [*16], non riesce comunque a staccarsi dall'universo intellettuale di quest'ultimo. Il problema risiede innanzitutto nel fatto che Adorno - come Sohn-Rethel prima di lui [*17] - si basa su un concetto di lavoro secondo il quale questo sarebbe identico al metabolismo con la natura. Ciò che il lavoro ha di specifico, vale a dire il fatto che esso costituisce un'astrazione reale capitalista e costituisce e mediatizza il contesto sociale nella società produttrice di merci (e unicamente in questa), gli sfugge in quanto egli proietta il lavoro - in parte in maniera esplicita, in parte in maniera implicita - sulla storia passata e lo appiattisce falsamente sulle società non capitaliste. Ma questo in definitiva mina il suo tentativo di rintracciare il soggetto trascendentale da Kant al feticcio della merce: «Alfred Sohn-Rethel ha per primo fatto notare che in esso [il principio trascendentale, NdT], attività universale e necessaria dello spirito, si cela inalienabilmente il lavoro sociale. Il concetto aporetico del soggetto trascendentale, di un inesistente che però agirebbe, di un universale che però percepirebbe il particolare, sarebbe una bolla di sapone, mai creabile a partire dall’autarchico contesto immanente di una coscienza necessariamente individuale. Tuttavia, rispetto a questa, il soggetto trascendentale rappresenta non solo il piú astratto, ma anche il piú reale grazie alla sua capacità di plasmare. Al di là del cerchio magico del pensiero identico, il soggetto trascendentale è decifrabile come la società inconsapevole di sé. Anche questa inconsapevolezza è deducibile. Da quando il lavoro spirituale si è diviso da quello fisico all’insegna del dominio spirituale, della giustificazione del privilegio, lo spirito scisso dovette rivendicare, con l’esasperazione della cattiva coscienza, proprio quella pretesa di dominio che deduce dalla tesi del suo primato e originarietà, e perciò sforzarsi di dimenticare da dove viene la sua pretesa, se non vuole decadere. Lo spirito ha l’intimo presentimento che il suo dominio stabile non è affatto spirituale, ma ha la sua ultima ratio in quella violenza fisica di cui il dominio dispone. Del suo segreto non deve far parola per non tramontare. L’astrazione che sola semmai fa del soggetto il constituens, come è testimoniato anche da idealisti estremi come Fichte, rispecchia la separazione dal lavoro fisico che si può scorgere dal confronto con esso. [...] Ciò che a partire dalla Critica della ragion pura è l’essenza del soggetto trascendentale, la funzionalità, l’attività pura che si attua nelle prestazioni dei singoli soggetti e al tempo stesso li trascende, proietta il lavoro liberamente fluttuante sul soggetto puro in quanto origine di esso. [...] Come estremo caso-limite di ideologia il soggetto trascendentale combacia con la verità. L’universalità del soggetto trascendentale non è solo un autoelevamento narcisistico dell’io, non la hybris della sua autonomia, bensí ha la sua realtà nel dominio che si afferma e si perpetua per mezzo del principio di equivalenza. Quel processo di astrazione che la filosofia ha trasfigurato e attribuito unicamente al soggetto conoscente si svolge nell’effettiva società di scambio» (Dialettica Negativa).
La retro-proiezione trans-storica delle forme borghesi del lavoro, del dominio e della ragione, non è qui spezzata ma viene completata in un insieme chiuso. Per cementare un tale insieme, si ricorre al principio di scambio o di equivalenza nel quale confluiscono il pensiero identificatore ed il dominio, ed il cui concetto rimane così necessariamente tanto sfuocato quanto non specificato, così come le categorie con le quali viene messo in relazione. La distinzione fra lo scambio primitivo di doni, lo scambio semplice di merci (al margine e nei porti delle società non capitaliste) e lo scambio di equivalenti basi sulla produzione di merci capitalista sotto il dettame dell'autovalorizzazione del valore nel migliore dei casi rimane vago. I due primi tipi di scambio non sembrano essere altro che gli stadi che precorrono le logiche dell'ultimo tipo, così come forme del dominio e della ragione non capitaliste sembrano essere solo una tappa all'interno di un processo storico già tracciato. «Quando Adorno ne parla a volte come divisione del lavoro, a volte come società di scambio, considerando sempre implicitamente i due termini nel loro rapporto con la genesi della forma dell'identità, lo si può spiegare solo col fatto che non ha compreso il lato specifico del contesto sociale inconscio costituitosi attraverso lo scambio di prodotti del lavoro sotto forma di merci. Ciò vuol dire [...] che non ha percepito lo sviluppo verso il rapporto di capitale contenuto nel rapporto di scambio e nel quale la "società dello scambio" si riunisce al suo concetto» (R.W. Müller, Geld und Geist, p. 193) [*18].
Adorno non vede affatto la rottura specifica rappresentata dal moderno scambio di equivalenti (ed il principio di identità in esso contenuto) in rapporto alle differenti altre forme storiche di scambio. Ecco perché disegna un'immagine distorta della storia, che non ignora soltanto le culture e le società non europee ma che sussume anche tutta l'evoluzione dell'Occidente sotto la società borghese e le sue categorie. Qui, il punto decisivo è che è nuovamente la prospettiva proiettiva che ostruisce lo sguardo e nasconde l'essenziale. Quando Adorno cerca l'origine del soggetto trascendentale kantiano nella separazione fra lavoro intellettuale e lavoro manuale, ciò è più che discutibile, e non solo dal punto di vista della storia della filosofia (Kant appare allora - insieme ad Hegel - come la conseguenza necessaria e come il punto più alto di tutta la filosofia occidentale a partire dall'Antichità); gli è che allo stesso tempo suppone un'ontologia del dominio interamente nella tradizione dell'Aufklärung e del marxismo ortodosso. Essendo la prima causa del dominio - secondo Adorno - la mancata separazione con la prima natura, la sua caratteristica sociale essenziale e trans-storica sarebbe l'appropriazione del plusprodotto da parte di una classe dominante a spese della grande maggioranza della popolazione laboriosa. Certo, ciascuna forma di dominio nella storia ha messo a punto dei metodi specifici di assorbimento delle ricchezze e dei metodi specifici di sfruttamento (tributi, imposte, tasse, schiavitù, ecc.); ma da qui a farne il criterio decisivo del dominio, lo può pensare solo il pensiero borghese. Si tratta di una proiezione del proprio contesto di dominio astratto costituito dal lavoro e dalla produzione di merci e dell'imperativo della valorizzazione in tal modo generato.
Il significato (inconscio) di questa proiezione è senza dubbio un'apologia del capitalismo. Non solo il suo principio costitutivo viene ad essere nobilitato in principio trans-storico, universalmente umano, perfino naturale, e quindi posto al di sopra di ogni sospetto. Ma, allo stesso tempo, l'economia di mercato può venire ideologicamente presentata (come nel caso dell'economia politica) come la liberazione dal dominio, in quanto sarebbe esente dallo sfruttamento e ciascun individuo beneficerebbe della ricchezza sociale in funzione del suo contributo personale. Com'è noto, il marxismo tradizionale fondamentalmente non ha messo in discussione questa visione del mondo, l'ha solo criticata in maniera immanente in quanto chimera. Così, lo scambio di equivalenti alla superficie del mercato non farebbe che nascondere lo sfruttamento e l'ineguaglianza che avrebbero luogo nella sfera della produzione. La società borghese appare così essenzialmente come una nuova variante della società di classi nella quale la classe dominante si appropria del plusprodotto in maniera particolarmente intelligente: sotto la forma del plusvalore e facendo allucinare un'uguaglianza generale che - in realtà - non esiste.
Postone ha insistito giustamente sul fatto che il marxismo tradizionale, malgrado il suo focalizzarsi costantemente sul processo di produzione, ha formulato una critica del capitalismo che rimane fissata sulla circolazione, del tutto prigioniero dell'universo proprio all'economia politica classica. Di conseguenza, l'obiettivo della rivoluzione non è quindi quello di liberarsi dal lavoro ma di liberare il lavoro dallo sfruttamento e realizzare i valori della libertà e dell'uguaglianza che la società borghese aveva promesso, ma che ha tradito. Anche Adorno rimane dipendente da questa prospettiva. Fondamentalmente ciò che lo distingue dal marxismo tradizionale, è che egli rompe la riduzione della critica allo sfruttamento nella produzione per allargarla al contesto sociale del capitalismo nel suo insieme. Il concetto di società dello scambio è a tal proposito di un'importanza capitale e, tuttavia, egli rimane in questo modo radicato nell'universo intellettuale del marxismo. Se la critica produttivista del marxismo era paradossalmente il risultato di un concetto di lavoro e di dominio che lascia da parte la sfera della circolazione, Adorno orienta la critica verso la sfera della circolazione senza però superare l'apparato concettuale di cui non si è mai sbarazzato. Arriva così ad una perspicacia che sarebbe stata impossibile con una visione sociologica semplicistica svolta in termini di sfruttamento di classe. Tuttavia, i limiti del marxismo tradizionale traspaiono continuamente [*19]: «Il principio di scambio, la riduzione del lavoro umano all’astratto concetto universale del tempo di lavoro impiegato mediamente, è l’antenato del principio identificante. Nello scambio esso ha il suo modello sociale, e lo scambio non ci sarebbe senza di esso; grazie a quello singole entità e prestazioni non identiche divengono commensurabili, identiche. La diffusione di questo principio obbliga il mondo intero all’identico, alla totalità. Tuttavia se questo principio venisse negato astrattamente; se si annunciasse come ideale che per il piú alto onore dell’irriducibilmente qualitativo non si debba piú scambiare alla pari, ciò sarebbe un pretesto per la ricaduta nell’antica ingiustizia. Infatti lo scambio di equivalenti è consistito da sempre nello scambiare in suo nome il diseguale, nell’appropriare il plusvalore del lavoro. Se si annullasse semplicemente la categoria di misura della comparabilità, al posto della razionalità, insita sí ideologicamente nel principio di scambio, ma anche come promessa, comparirebbero l’appropriazione immediata, la violenza, oggigiorno: il nudo privilegio di monopoli e cliques. La critica al principio di scambio in quanto principio identificante del pensiero vuole che si realizzi l’ideale di uno scambio libero ed equo, sino a oggi solo un pretesto. Solo questo potrebbe trascendere lo scambio. Se la teoria critica lo ha svelato come scambio dell’uguale e tuttavia del diseguale, allora la critica della disuguaglianza nell’uguaglianza mira anche all’uguaglianza, pur con tutto lo scetticismo contro il rancore nell’ideale borghese ugualitario, che non tollera niente di qualitativamente diverso. Se non venisse piú sottratta a nessun uomo una parte del suo lavoro vivo, si raggiungerebbe l’identità razionale e la società oltrepasserebbe il pensiero identificante » (Dialettica Negativa).
Quel che qui colpisce innanzitutto è la ripresa del classico marxista secondo cui lo scambio di equivalenti è una finzione che in realtà serve solo a mascherare l'appropriazione di plusvalore; un'interpretazione che Adorno arriva a retrodatare in un'epoca lontana della storia ("originariamente") per poter mantenere il parallelo proiettivo del dominio e del lavoro. Questo va di pari passo con l'appello ad una presunta promessa contenuta nello scambio, ma che è rimasta fino ad ora irrealizzata. Certo, per Adorno, la realizzazione dello "scambio libero ed equo" non costituisce il punto finale della liberazione, ma nondimeno rimane (cosa che va del tutto nel senso di una teologia della storia) lo stadio transitorio storicamente necessario. Tutto ciò serve a rivendicare paradossalmente la realizzazione degli ideali del capitalismo (realizzazione di cui dunque il capitalismo non sarebbe capace) per poterli così allo stesso tempo superare.Questa dialettica per quanto non sia un po' strana non è - come pretende Adorno - negativa, ma paradossalmente è positiva ed anche, volenti o nolenti, affermativa per quanto attiene la moderna società delle merci. Essenzialmente, torna a vestire, ridicolmente, tutti le costrizioni del capitalismo con gli epiteti «progressista e civilizzatore», benché tali epiteti siano stati riconosciuti e criticati in quanto costrizioni. Si tratta perciò del tentativo, un po' vergognosamente camuffato, di salvare malgrado tutto la teologia hegeliana della storia trasfigurando un dato storico in necessità storica e logica. Gli è che Adorno non si accontenta di dire - anche nella prospettiva di una possibile emancipazione sociale - che non abbiamo altra scelta se non quella di tener conto delle condizioni sociali così come si sono costituite ed evolute nel corso della lunga storia del capitalismo. Non ci sarebbe stato niente di male, visto che questo va da sé. Ma non era affatto obbligato ad arrivare a sublimare quest'affermazione nel senso di una metafisica della storia. Eppure è precisamente questo che ha fatto Adorno - almeno implicitamente - quando legge nel principio di scambio e nel principio di identificazione che ad essi si lega una promessa non mantenuta di emancipazione e di "razionalità" [*20].
Con questo apriori teorico (anzi pre-teorico), Adorno si scontra incessantemente nel corso della sua interpretazione del concetto di libertà in Kant. Che faccia di tutto per liberare la libertà da ogni «contaminazione empirica», come abbiamo già detto, lo si può facilmente decifrare come effetto dell'assoluta indifferenza della forma valore e della forma merce riguardo ad ogni contenuto determinato e specifico; «l'autonomia della volontà» è in realtà «l'autonomia» del valore, vale a dire che la autoreferenzialità gli fa esercitare la sua violenza contro il mondo empirico e sensibile. È vero che, da un lato, Adorno cerca l'origine della «subordinazione di ogni impulso all'unità logica» (Dialettica Negativa) nel «principio dello scambio». Ma, dall'altro lato, vuole anche vedere nello sforzo di Kant, di determinare la libertà come strettamente trascendentale, il tentativo di salvarlo in un modo o nell'altro dalle costrizioni esercitate dalla realtà della società dello scambio: «La libertà positiva è un concetto aporetico, escogitato per conservare l’essere in sé di uno spirituale di fronte al nominalismo e alla scientifizzazione. In un passo centrale della Critica della ragion pratica Kant ha confessato che ne va appunto della salvazione di un residuo» (Dialettica Negativa).
Ma guardando un po' più da vicino il passaggio cui Adorno si riferisce, questa interpretazione non regge. Kant scrive: «Ma siccome questa legge riguarda inevitabilmente ogni causalità delle cose, in quanto la loro esistenza è determinabile nel tempo, cosí, se questo fosse il modo in cui si dovesse immaginare anche l’esistenza delle cose in se stesse, la libertà dovrebbe essere rigettata come un concetto nullo e impossibile. Quindi, se si vuole ancora salvare la libertà, non rimane altra via che attribuire l’esistenza di una cosa in quanto è determinabile nel tempo, e quindi anche la causalità secondo la legge della necessità naturale, semplicemente al fenomeno, e la libertà invece allo stesso essere, come cosa in sé» (Critica della ragion pratica).
In primo luogo, la legge cui Kant si riferisce è la legge naturale che egli stesso ha già costruito e alla quale sarebbero sottomessi tutti i fenomeni sensibili, fra cui, secondo lui, si deve contare la «natura interiore» dell'Uomo, vale a dire tutti i suoi bisogni sensibili, i suoi impulsi e le sue sensazioni particolari. Di fronte a questo preteso determinismo rigoroso, Kant postula allora una «legge della libertà» altrettanto rigorosa, la quale, tuttavia, date le condizioni presupposte, non può aver luogo che in una sfera della ragione epurata da ogni sensibilità e da ogni empiria e, in questo senso, trascendentale. Tutto questo viene pensato in maniera del tutto conseguente nelle categorie del sistema kantiano che si basa, com'è noto, su una stretta opposizione fra «ragione» e «natura». le quali, di conseguenza, rientrerebbero anch'esse in delle sfere rigorosamente separate. Il discorso del «salvataggio» qui si riferisce chiaramente all'autoaffermazione della «autonomia del libero arbitrio» di fronte alla «legge della necessità naturale» e quindi non è altro che la base metafisica del concetto di libertà. Si tratta perciò del nucleo più centrale della teoria kantiana, della conclusione di una catena argomentativa logica che legittima la subordinazione del mondo sotto l'astratto formalismo del valore, e che l'aiuta ad imporsi. Tuttavia, secondo l'interpretazione di Adorno, il «salvataggio» si riferisce, al contrario, al salvataggio di un «essere-in-sé» della libertà di fronte ad un concetto di libertà formulato nelle categorie della costrizione e in tal modo tradito. Niente di più lontano dalle intenzioni di Kant. Evidentemente, Adorno scambia i propri desideri per realtà. In sostanza, ricade nell'idealismo kantiano anziché risolverlo nel senso di una critica della forma merce. Invece di rapportare rigorosamente, come fa Kant, il carattere metafisico di questo concetto di libertà alla «forma di una legge generale» e di decifrare il riflesso metafisico del «soggetto automatico», Adorno ci presenta qui un'interpretazione piuttosto comune dell'idealismo simile a quella che ci presenta il marxismo tradizionale, ma anche la critica democratica di sinistra. Secondo tale interpretazione, la società borghese ha relegato i suoi ideali nel regno delle idee in quanto sarebbe incapace di realizzarli effettivamente. La metafisica dell'idealismo kantiano corrisponde quindi non ad una metafisica inconscia reale del feticcio della merce, ma è assai banalmente ideologia, nel senso che mente sulla cattiva realtà: «Chiamare la libertà all’esistenza è vietato dalla critica della conoscenza di Kant; egli si aiuta evocando una regione esistenziale, che sarebbe certo esente da quella critica, ma anche da ogni giudizio su cosa essa sia. Il suo tentativo di concretizzare la dottrina della libertà, di attribuire la libertà ai soggetti viventi si involve in affermazioni paradossali» (Dialettica Negativa) [*21].
La conseguenza logica della contraddizione constatata fra l'ideale e la realtà sarebbe quella di prendere l'ideale in parola e stabilire alla fine la società effettivamente a partire da esso. Questa conclusione, Adorno si rifiuta di trarla, ma allo stesso tempo è incapace di staccarsi completamente dalla figura intellettuale che la presuppone, e che ossessiona la sua argomentazione come una sorta di ombra. Almeno, la possibilità di liberazione rimane conservata nella sfera dell'idea! Così crede di scoprire i resti del potenziale di emancipazione persino laddove la repressività del pensiero kantiano ha il suo noccio duro. A proposito del «carattere intellegibile» per mezzo del quale l'essere umano parteciperebbe, secondo Kant, della sfera della ragione e che serve in tal modo da mediatore fra il soggetto trascendentale e quello empirico, Adorno scrive: «Alla fine il carattere intellegibile sarebbe la paralisi della volontà razionale. Per contro ciò che di esso è considerato elevato, sublime, non deturpato dalla bassezza, è essenzialmente la sua miseria, l’incapacità di cambiare l’umiliante; la frustrazione stilizzata come scopo in sé. Eppure non vi è niente di piú prezioso tra gli uomini che quel carattere; la possibilità di essere altro da come si è, mentre invece tutti sono carcerati nel proprio Sé e perciò anche esclusi dal proprio Sé. Il difetto eclatante della dottrina kantiana, l’inafferrabilità, l’astrattezza del carattere intellegibile somiglia anche un po’ alla verità di quel divieto delle immagini che la filosofia post-kantiana, Marx incluso, ha esteso a tutti i concetti del positivo. Come possibilità del soggetto il carattere intellegibile è, come la libertà, in divenire, non è un ente. Esso verrebbe tradito non appena venisse incorporato all’ente tramite una descrizione, sia pur la piú prudente» (Dialettica Negativa).
Tuttavia, l'astrazione estrema dei concetti kantiani, il loro «lato sfuggente» non indica un potenziale di emancipazione, ma è dovuta al tentativo di pensare la forma borghese in tutta la sua conseguenza affermativa. Tutto il pensiero di Kant punta a pensare, fino alle sue ultime conseguenze, la logica di questa forma nella maniera idealista più rigorosa possibile. Se ciò non avviene senza aporie, è a causa di due fattori: in primo luogo, è perché questa logica alla fine non può essere compresa se non nei termini di una critica del feticismo, mentre Kant appare essere l'ideologo della legittimazione e del trionfo di questa forma. In secondo luogo, perché questo è dovuto alla cosa stessa, al fatto che la realtà non si lascia ridurre completamente al concetto identificante e, pertanto, alla forma valore, per quanto forte sia la maniera in cui essa fa valere la sua pretesa imperialista - il che è, com'è noto, una delle idee di base dello stesso Adorno (anche se lui si riferisce sempre al «principio di scambio», troppo poco specifico, sia dal punto di vista storico che da quello concettuale). È vero che questa non-riducibilità è contenuta nel pensiero di Kant nella misura in cui nomina, quanto meno nella «problematica della cosa in sé», il rimosso è ciò che è separato, mentre Hegel rimuove il rimosso, come fanno giustamente notare Hartmut e Gernot Böhme. [*22] Ma questa non-riducibilità è contenuta soltanto come qualcosa di puramente negativo, come qualcosa che ha la sfortunata proprietà di non volersi piegare al diktat della forma; il «progresso infinito» designa la pretesa di spingere sempre più lontano in direzione della subordinazione totale del mondo sensibile, ciò che Kant definisce in maniera significativa come l'avvicinarsi di un «ideale di santità». Ma in realtà ciò che corrisponde maggiormente allo stato delle cose, è quel che Hegel afferma un maniera cinicamente innocente: «Tanto peggio per la realtà!».
La dialettica negativa ha il compito di decifrare, nella sua logica repressiva, questa subordinazione riuscita ed allo stesso tempo mancata del mondo sotto il diktat del valore, così come la postula Adorno. Ma quando crede di svelare un «essere in sé» della libertà nella metafisica kantiana, si ritira in fondo al suo stesso metodo. Sono queste le aporie irrisolte dei suoi stessi concetti ed il loro rinchiudersi nella filosofia della storia progressiva (aufklärerisch) che portano Adorno a voler ancora salvare l’Aufklärung contro la sua stessa logica interna distruttiva. Ma quando non identifica più l’Aufklärung con il pensiero riflessivo in sé comprendendolo come una forma di pensiero del tutto specifico e legato ad una forma feticcio storicamente determinata - come la ragione moderna -, allora lo si può criticare in tutte le sue conseguenze negative senza, tuttavia, cadere nel pessimismo assoluto. «Il desiderio di salvataggio» che Adorno attribuisce falsamente a Kant è in realtà il suo. Se perdura, non è a causa dell'Aufklärung e della società della merce, ma malgrado loro. Che l'Aufklärung sia incapace, malgrado tutti i suoi sforzi di cancellare l'idea della liberazione dal dominio, questo non gli va attribuito come merito ma dimostra soltanto il suo carattere intrinsecamente insostenibile, il fatto che esso non può che fallire in maniera disastrosa di fronte alla sua stessa pretesa, ma questo non indica affatto una promessa non mantenuta.
- Norbert Trenkle - Dicembre 2002 -
(membro del gruppo tedesco Krisis, autore di numerose opere sulla critica del valore - WertKritik - e coautore con Ernst Lohoff e Robert Kurz del Manifesto contro il lavoro.)
fonte: KRISIS
NOTE:
[*1] - Ne "La dialettica dell'Illuminismo" (Adorno/Horkheimer), la parola « Aufklärung » designa più generalmente il «pensiero in progresso». Nella maggior parte dei casi, è stata mantenuta questa parola, laddove era necessario, al posto di «Illuminismo» o al posto di «pensiero razionalista». La parola «Ragione» traduce l'idea trans-storica di «Vernunft», «ragione», in senso generale. «Gegenaufklärung» è stato tradotto sia con «contro-Aufklärung», sia con «irrazionalismo».
[*2] - Soprattutto di fronte alla situazione, del tutto cambiata, del mondo attuale dove è per mezzo dei bombardieri che una certa sinistra intende diffondere i «valori dell'Aufklärung» nel «mondo islamico» denunciato come «premoderno» o «anti-moderno».
[*3] - «Il carattere essenziale di ogni determinazione della volontà da parte della legge morale, è che essa sia determinata semplicemente dalla legge morale come libera volontà, pertanto non solo senza il concorso di attrazioni sensibili, ma anche con l'esclusione di tutte queste attrazioni, e a danno di ogni inclinazione, in quanto esse possono essere contrarie alla legge morale» (Kant, Critica della Ragion pratica).
[*4] - «Ringraziamo perciò la natura per questo umore poco conciliante, per la vanità che compete nel desiderio, per l'appetito insaziabile di possesso o perfino di dominio. Senza questo, tutte le eccellenti disposizioni naturali dell'umanità sarebbero soffocate in un sonno eterno. L'uomo vuole la concordia, ma la natura sa meglio di lui quel che è buono per la sua specie: essa vuole la discordia» (Kant, Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolita).
[*5] - Si veda più in dettaglio, Robert Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, Francfort/M, Eichborn, 1999, p. 33 ainsi que p. 273 passim.
[*6] - Anselm Jappe, "Sic transit gloria artis. Teorie sulla fine dell'arte in Adorno e in Guy Debord", in Krisis 15. [Questo testo è stato tradotto in francese in "L’avant-garde inacceptable. Réflexions sur Guy Debord", Lignes, 2004.
[*7] - Quel che è illuminante in questo passaggio, è il modo in cui viene utilizzato il mito di Ulisse, come superficie di proiezione per descrivere ed analizzare il tipo di carattere borghese in maniera del tutto giusta sotto molti aspetti. Ma anche questo rimane valido solo nella misura in cui si è coscienti di tale proiezione, utilizzando ad esempio il personaggio di Ulisse nel sesso di un effetto di distanziamento, o come un «mito scientifico» (Freud), al fine di chiarire qualcosa che questo personaggio non può chiarire di per sé. Müller formula una critica del genere: «Identificando nel personaggio di Ulisse il proprietario terriero o il viaggiatore borghese, si cela una differenza essenziale [...]. Bisognerebbe che la differenza fra lavoro manuale e lavoro intellettuale, e la sua determinazione da parte del diretto potere di classe, venisse chiaramente distinta dalla forma della divisione del lavoro il cui contesto sociale deve formarsi ciecamente sotto il dominio del valore» (R. W. Müller, Geld und Geist, 1976, p. 193).
[*8] - Vedi anche: R. Wiggershaus, L’Ecole de Francfort, Paris, PUF, 1993, pp. 372-376.
[*9] - Infatti, il pensiero borghese ed ottimista del progresso si trova ad essere affiancato, al più tardi dopo il 19° secolo, da un pessimismo che non è altro che la sua immagine riflessa. Si pensi a "Il disagio della civiltà" di Freud o a "Il declino dell'occidente" di Spengler ed al suo erede Samuel Hutington.
[*10] - Quando Postone, nella sua critica della lettura "materialista" della filosofia della storia di Hegel fatta da Lukacs, mostra come lo spirito universale non sia altro che il riflesso idealista del "soggetto automatico", vale a dire di un principio di socializzazione specifico e storicamente unico, allora questa critica tocca indirettamente anche la filosofia della storia sviluppata nella Dialettica dell'Illuminismo.
[*11] - In fin dei conti, che questa costruzione storico-filosofica sia un po' traballante, Horkheimer e Adorno stessi se ne sono indubbiamente accorti. Gli è che le caratteristiche specifiche della modernità capitalista e della ragione che la caratterizza sono troppo evidenti. Per questo si spiegano delle osservazioni come: «L’illuminismo dell’età moderna si è posto fin dall'inizio all’insegna del radicalismo; ciò che lo distingue da ogni fase precedente della lotta contro il mito.» ("Dialettica dell'Illuminismo"). Frasi come questa tuttavia non mettono per niente in discussione lo sviluppo generale dell'argomentazione e di conseguenza servono a colmare le crepe e le fratture invece di prenderle veramente sul serio. Il termine «radicalismo» significa che la ragione formalista borghese risale alla radice del «divenire uomo». Costituisce il punto logico finale di una linea di evoluzione: «È la linea della distruzione e della civiltà a un tempo. Ogni passo è stato un progresso, una tappa dell’illuminismo. Ma mentre tutte le trasformazioni precedenti, dal preanimismo alla magia, dalla civiltà matriarcale a quella patriarcale, dal politeismo dei proprietari di schiavi alla gerarchia cattolica, mettevano mitologie nuove (anche se più illuminate) [...] alla luce della ragione illuminata si è dissolta come mitologica ogni devozione che si ritenesse oggettiva e fondata nella realtà.» ("Dialettica dell'Illuminismo"). Oppure: «Il borghese, nelle forme successive del proprietario di schiavi, del libero imprenditore, dell’amministratore, è il soggetto logico dell’illuminismo» ("Dialettica dell'Illuminismo").
[*12] - Vedi C. P. Ortlieb, «Bewusstlose Objektivität», in Krisis, n°21-22, 1998 ; riguardo la genesi storica di questo rapporto con la natura, vedi G. et H. Böhme, «Das Andere der Vernunft», 1985 e R. zur Lippe, «Vom Leib zum Körper, Reinbek bei Hamburg», 1988. (1974).
[*13] - «Questa relazione fra la paura e la ragione è sia tanto strategicamente necessaria quanto rimossa [...]. La morale [nel senso della dottrina morale di Kant] rappresenta il tentativo di scacciare questa paura che essa stessa innanzitutto produce. La doppia morsa interiore in cui la morale incatena inesorabilmente il soggetto alla legge. Senza questa paura, non ci sarebbe questa forma di ragione» (Böhme, Das Andere der Vernunft, op. cit., p. 331).
[*14] - A tal proposito, vedi R. Scholz, « Der Wert ist der Mann », in Krisis 12, 1992 e «Das Geschlecht des Kapitalismus», Bad Honnef, 1999 ; così come C. P. Ortlieb, art. cit., p. 40.
[*15] - L'idea antropologizzante di base, che si appoggia a Freud, secondo la quale bisogna cercare l'origine dell'irrazionale (quel che la ragione reprime e che finisce sempre per aprirsi una strada - e che sarebbe perciò il rovescio della civiltà fino ai nostri giorni) nella separazione mancata con la natura, questa idea si trova anche alla base della "Dialettica negativa", anche se viene espressa piuttosto «di passaggio» e viene trattata implicitamente in un certo numero di argomenti. Un esempio: «Il segno distintivo delle forze civilizzatrici sta nel fatto che esse non rimettono in discussione l'evidenza che ci sia solo l'unico, l'invariabile, l'identico in quanto bene. Ciò che non si piega, tutta l'eredità del momento naturale pre-logico, viene immediatamente rinviato al male, in tal modo astrattamente inteso come il principio del suo contrario. Il male, per la borghesia, è la sopravvivenza dell'elemento antico, sottomesso, sottomesso in maniera incompleta» (Dialettica Negativa). Vedi "Dialettica Negativa" anche a proposito del rapporto fra la ragione e la natura.
[*16] - Qui, Adorno ha indubbiamente preparato il terreno ad un decrittaggio più avanzato del feticismo della merce. Non è un caso se sono per lo più i suoi allievi (Krahl e Backhaus, ad esempio) che hanno continuato questo lavoro.
[*17] - A questo proposito, si veda Robert Kurz, «Abstrakte Arbeit und Sozialismus», in Marxistische Kritik 4, Erlangen, 1987 (www.krisis.org).
[*18] - «Va ad Adorno (ed anche ad Horkheimer) il merito di aver attirato l'attenzione sul rapporto fra la forma logica dell'universalità, il principio di socializzazione attraverso il lavoro che aleggia al di sopra delle diverse attività produttive reali in quanto punto di riferimento. Il loro difetto è quello di essersi fermati a questa indicazione sul più alto livello mai raggiunto dalla coscienza borghese del proprio mondo. L'idea del soggetto trascendentale come punto di fuga, che, in ogni tempo, organizzerebbe socialmente i soggetti intellettuali pensanti "intellettualmente in azione", può essere compreso come la ripresa a livello di critica epistemologica della dottrina formulata dall'economia classica secondo la quale l'armonia del lavoro totale di una società nasce dalle attività individuali degli individui partecipanti allo scambio» (Müller, ivi, p. 201).
[*19] - Postone dimostra che Horkheimer e Pollock non riescono a superare i limiti del marxismo tradizionale, cosa che spiegherebbe la loro visione pessimistica. Questo vale anche- seppure in maniera differente - per Adorno.
[*20] - La costruzione storico-filosofica del capitalismo in quanto stadio necessario di transizione sulla strada dell'emancipazione, perde completamente la bussola laddove viene mantenuta con la violenza contro la logica del crollo intrinseca al sistema produttore di merci, e quando perfino il bombardamento, vomitato dal mercato mondiale, di un paese può passare per essere un fatto civilizzatore. Adorno se ne sarebbe probabilmente discostato con orrore e, tuttavia, questa conseguenza cinica, in cui il pensiero dell'Aufklärung diviene immediatamente identico con il suo «rovescio oscuro», si trova incluso, in un certo modo, nella sua paradossale filosofia della storia.
[*21] - Altrove si può leggere: «L’idea di libertà perse non da ultimo il suo potere sugli uomini perché era stata concepita sin dall’inizio in modo soggettivo-astratto, cosicché l’oggettiva tendenza sociale non fece fatica a seppellirla sotto di sé» (Dialettica Negativa). Quindi: il concetto di libertà dell'Aufklärung non esprime in sé la relazione interiore con «la tendenza sociale oggettiva», ma si mantiene all'esterno rispetto ad essa e rimane alla fine sconcertato davanti ad essa.
[*22] - «In questa dialettica dell'appropriazione del rimosso si è realizzata la definizione moderna della realtà. Quando Hegel finisce per identificare il reale con il razionale, rimuove ancora una volta il rimosso» (H. et G. Böhme, op. Cit., 1985, p. 14).