Della vita di Miguel de Cervantes – di cui molto, soprattutto intorno agli anni di gioventù, è rimasto avvolto nel mistero – i pochi documenti irrefutabili che ci sono pervenuti riguardano proprio i periodi e i fatti all’apparenza più inverosimili. Di lui, Thomas Carlyle disse: «In un secolo lontano, visse un certo tale, uomo energico, che combatté valorosamente a Lepanto, lavorò coraggiosamente ad Algeri come schiavo, sopportò con sereno valore fame, miseria e ingratitudine del mondo e che poi, stando in carcere, scrisse con l’unica mano rimastagli il libro più gioioso e insieme più profondo del tempo moderno, intitolandolo Don Chisciotte». In questo romanzo biografico di Bruno Frank, con un perfetto equilibrio tra ricostruzione storica e densità narrativa, prende corpo la trasformazione di un giovane poeta, un uomo solo e disperato che, sconfitto dalla vita, creò uno dei più grandi capolavori della letteratura.
Bruno Frank (Stoccarda, 1887 – Beverly Hills, 1945) Romanziere, drammaturgo e sceneggiatore tedesco. Di origini ebraiche, si trasferì negli Stati Uniti dopo la presa del potere di Hitler. Autore di poesie, racconti, romanzi e testi teatrali, collaborò come sceneggiatore con la Metro-Goldwyn-Mayer. Fu attivo al fianco di Klaus Mann e Lion Feuchtwanger nell’organizzazione degli intellettuali antinazisti.
(dal risvolto di copertina di: Bruno Frank: "Cervantes", Castelvecchi)
Cervantes, vita nell’ombra
- di Pietro Citati -
I grandi scrittori che fondarono la civiltà moderna vissero sconosciuti. Shakespeare abitò l’ombra. Nel 1600, Miguel de Cervantes Saavedra aveva cinquantatré anni: il pittore Francisco Pacheco pubblicò un libro in cui raccolse i ritratti e le biografie di tutti gli spagnoli celebri. Di Cervantes nemmeno un cenno. Non si è conservata una sua lettera, né un manoscritto. Possediamo soltanto alcuni documenti giudiziari, suppliche o ricevute. Bruno Frank, uno scrittore tedesco, che si trasferì negli Stati Uniti quando Hitler conquistò il potere, fu attratto da questa ombra e da questo silenzio. Nel 1934 scrisse un eccellente libro su Cervantes, che in questi giorni viene pubblicato da Castelvecchi (traduzione di Lavinia Mazzucchetti). Poiché non conosceva tutte le notizie, Frank le inventò: ma la sua invenzione è altamente possibile e probabile.
Il Cervantes di Frank ha un’immensa capacità visiva. Combatte, fugge, viaggia: in Spagna, Italia, Algeria: guarda; e tutto ciò che vede si imprime nella sua fantasia e nella sua intelligenza. Nulla gli sfugge: quanto accade si deposita in lui, che non cerca di raccontare gli eventi, ma di trasformarli. Possiede una fantasia accesa e sfrenata, che lo porta lontano. Quando giunge una sventura, la sfida, si adatta, la sopporta, e rimane tranquillo. Non gli importa affatto che la sua esistenza sia miserevole, senza utilità e senza grandezza. Non gli importa di fallire sempre di nuovo. Porta tutto all’estremo, obbedendo ciecamente al destino. Si curva su sé stesso come su uno specchio d’acqua, senza riuscire a sondarne la profondità. Forse pensa che un giorno, verso la fine dei suoi giorni, questa profondità verrà alla luce, illuminando il mondo.
Bruno Frank è molto abile nel raccontare in modo doppio gli eventi: sia con gli occhi di Cervantes, sia con gli occhi propri, che hanno acquistato una scienza che il suo modello non possedeva. Così conosciamo Madrid: un misero borgo di quindicimila abitanti, con le case di argilla, a un piano solo: conosciamo la Mancia, questo paese uniforme, triste, con il terreno riarso e screpolato da estati senza pietà; e Siviglia, che i moriscos e gli ebrei hanno reso bella, ricca, e piena di una misteriosa felicità e saggezza. Vediamo il re, Filippo II, al suo tavolo di lavoro: depone la penna e fissa gli interlocutori con due grandi occhi sporgenti, indicibilmente tranquilli. Pensa alla fede e all’eresia. «Se mio figlio — aveva detto un giorno — divenisse preda dell’eresia, porterei io stesso la legna per arderlo sul fuoco». Per ore e ore, senza farsi notare, osserva, da una finestra nella parete del carcere, la lenta agonia del figlio ribelle. Indossa l’uniforme del Toson d’Oro, col berretto, il mantello aperto, sui cui risvolti si ripete l’immagine dell’Agnello. Pensa che al mondo non esiste nulla tranne la dinastia degli Asburgo; e considera la propria esistenza come un’anticamera della morte.
Il libro di Frank si concentra: via via che racconta i fallimenti sempre più gravi di Cervantes, acquista spessore e grandezza. Appena pare che gli si schiuda un avvenire più luminoso, una ferrea porta si richiude: è un povero mutilato, uno zero in una folla, e sembra che il suo destino sia quello di morire in catene. Fugge da Algeri, dove è schiavo: torna in Spagna; ma la sua vita non è meno desolata. Conosce Lope de Vega: mentre la sua penna è sterile, il grande rivale riesce a portare a fine, da un tramonto all’altro, un dramma di tremila versi, veloce come il copista che lo trascrive.
Quando Cervantes si sposa, insorge contro di lui un nemico più tremendo dei guerrieri turchi: un nemico senza voce e senza forma, contro il quale non esiste arma di difesa. Lo trova tra le braccia di Catalina, la moglie: la noia onnipresente. Una volta vestito, al mattino, ha già compiuto il lavoro della giornata. Come un vero hidalgo, siede alla finestra: guarda la strada del villaggio, sulla quale non si mostra quasi mai un viandante; dopo duecento passi, si arriva alla fine del borgo, dove comincia un paese sconfinato, piatto, o appena lievemente ondulato, dove soffia gelida la bufera: la Mancia. Lo sguardo di Cervantes si posa su otto o dieci mulini che spiccano all’orizzonte, grandi mulini a vento, le cui ali gemono e stridono. Egli è stanco e rassegnato. Sa tutto: sa che, dalla capanna di fronte a sinistra, alle dieci di mattina sarebbe uscita una vecchia per andare a comprare, cinque case più avanti, una pagnotta d’orzo, mentre la capanna di destra sarebbe rimasta chiusa fino a sera. Le donne di casa vanno in chiesa due volte al giorno: presto egli rinuncia ad accompagnarle. I discorsi con lo zio prete si esauriscono subito, e sempre più brevi diventano le sue visite alla parrocchia.
Alle cinque, quando è già notte, Cervantes accende un lumino ad olio. Va all’osteria, dove trova il mediocre vinello del paese. Siede accanto ai contadini, che indossano un camice scuro, una fune per cintura, e rozze scarpe di pelle non conciata. Dapprima la sua presenza suscita un certo imbarazzo: non era mai successo che un hidalgo sedesse tra i contadini. Alcuni di essi provano diffidenza: altri rimangono in attesa, con cortesia riservata e severa; infine Cervantes viene accettato come si accetta una cosa. Intanto, a casa, la moglie legge appassionatamente dei libri di cavalleria, che considera come l’unico universo reale. Esistono solo storie di giganti e di draghi, di spiriti protettori e di stregoni, di fate e di destrieri alati: palazzi di cristallo, isole natanti, laghi in fiamme.
La vecchiaia di Cervantes è ancora più desolata. Viene nominato requisitore. Raggiunge il fondo. Scortica e spreme la povera gente: questo è il suo compito. Diventa una sanguisuga. Dovunque c’è la stessa miseria. Dovunque arriva, i contadini serrano i granai, nascondono le botti, staccano le mute dei cani. Alcuni affilano le falci. La notte Cervantes dorme in un ufficio statale, spogliandosi solo a metà, con la pistola a portata di mano. Per dodici real al giorno, vive nell’inferno. Non è più un uomo, ma uno strumento del complicatissimo meccanismo statale: un rastrello, destinato a raccogliere fondi, per rifornire la Grande Armada. Incassa denaro, requisisce viveri, lotta con le autorità locali, si accapiglia con i contadini: immerso in un caos di conti, ricevute, rapporti, liste, relazioni, suppliche, denunce, verbali. Talvolta cede improvvisamente, sopraffatto dalla stanchezza, dalla pietà e dal disgusto. Un giorno di settembre viene rinchiuso nel carcere dei debitori, per ordine di chissà quale istanza. Pochi giorni dopo viene liberato: nessuno sa per quale ragione.
La storia si ripete. Presto Cervantes deve rendere conto di entrate fiscali per 2.577.029 maravedì; e viene constatato un ammanco di 79.084 maravedì. Lo Stato lo rinchiude di nuovo in prigione: dove non c’è niente di gratuito, tranne una pagnotta di pessimo pane. Nella cella non riesce a dormire. Si guarda in uno specchio. La barbetta a punta, che poco tempo prima era color oro, adesso è color argento sporco: pieghe profonde e flosce attorno al naso; pochi denti. Solo gli occhi appaiono quelli di una volta, e conservano la loro vivacità coraggiosa.
Un giorno Cervantes fa uno schizzo di sé stesso. Si disegna, mentre a cavallo di un povero ronzino scheletrico, procede per le strade sassose e desolate della Spagna: troneggia sul ronzino con la magra persona, trascinando malinconicamente a terra le gambe troppo lunghe. Continua a disegnare. Ora indossa una specie di corazza, e uno strano copricapo a forma di elmo, ma senza visiera. Ecco la moglie seduta a terra; e tutt’attorno, in disordine, volumi laceri pieni di invenzioni cavalleresche. Pensa a sé stesso, e a un eroe. Come sarebbe stato divertente condurre questo eroe in cerca di avventure, con la ferma fede che esiste ancora l’epoca della cavalleria. Comincia a scrivere: «In un paese della Mancia, di cui non voglio fare il nome, vive un gentiluomo...». Così, quasi per caso, in prigione, nasce Don Chisciotte, e l’immenso libro di illusioni che prende nome da lui. Cervantes aggiunge: «Io, sebbene sembri padre, sono patrigno di Don Chisciotte».
- Pietro Citati - Pubblicato sul Corriere della Sera del 4 marzo 2016 -

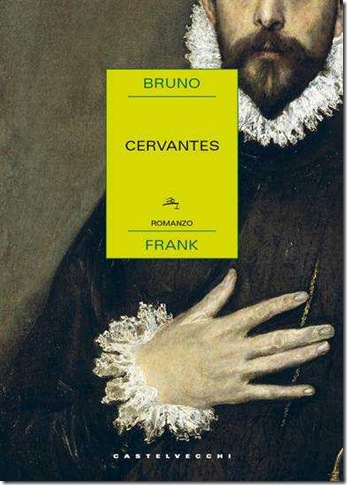
Nessun commento:
Posta un commento