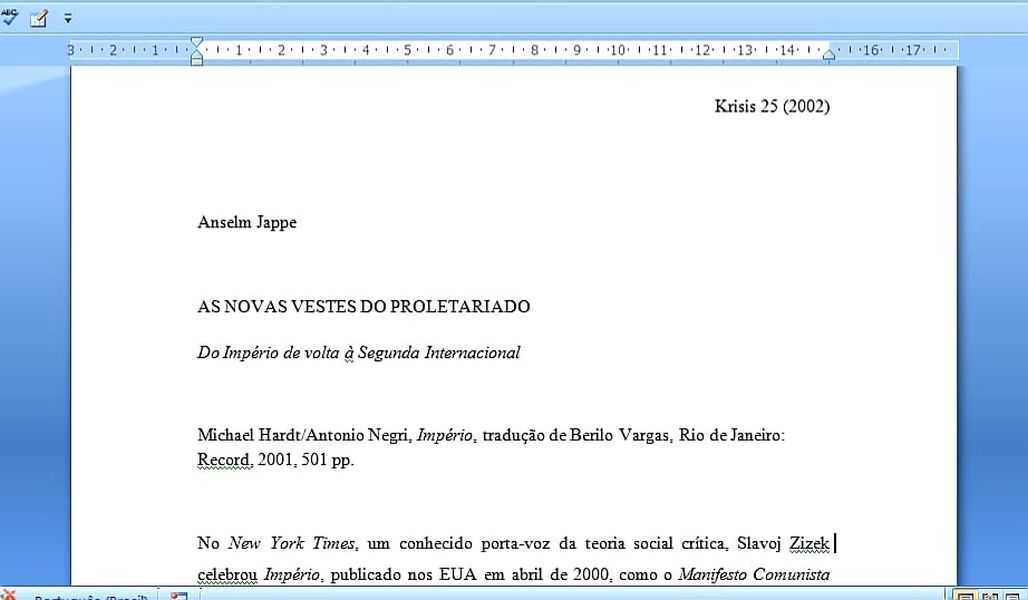Piccola cosmologia dell'universo delle merci
Documento di lavoro n. 5, settembre 2024
- di Ernst Lohoff -
7. La composizione modificata del cosmo delle merci
In Marx, non esiste niente che equivalga a una distinzione sistematica tra ricchezza di valore e ricchezza astratta. Sebbene il terzo volume del Capitale si occupi di formazioni di capitale basate sull'anticipazione del valore in relazione al capitale fruttifero e al prezzo della terra, Marx equipara l'accumulazione totale capitalistica alla valorizzazione del valore. Un simile approccio era giustificato nella misura in cui nel capitalismo del XIX secolo - che era quello che Marx aveva in mente - la valorizzazione del valore coincideva effettivamente con il processo di accumulazione, e il movimento del capitale fittizio aveva importanza solamente rispetto al corso dei cicli economici. Il fatto che il capitalismo potesse entrare in una fase in cui l'anticipazione del valore sostituiva la valorizzazione del valore in quanto vero motore dell'accumulazione totale, era al di là dell'immaginazione di Marx. Ed è proprio questo tipo di capitalismo inverso altamente precario, dove la sovrastruttura finanziaria si è mutata in quella che è l'industria di base del sistema complessivo, emersa negli anni '80 con lo scatenarsi delle dinamiche dei mercati finanziari (Lohoff/Trenkle 2012). Una critica dell'economia politica che non ne tenga conto, e pretenda che l'aumento della ricchezza astratta possa essere ricondotto all'utilizzo reale del lavoro, alla fine degenera in una palese ideologia di negazione della crisi. Con lo sviluppo del capitalismo, la composizione del cosmo delle merci cambia. È risaputo che a un certo punto le carrozze e le macchine da scrivere meccaniche sono scomparse, e che sono entrati in scena nuovi beni, come automobili e smartphone . Tuttavia, a quanto pare, non si deve essere sparsa la voce che con lo sviluppo delle forze produttive, il peso delle varie classi merceologiche cambia, e che questo processo ha assunto forme drammatiche, soprattutto negli ultimi 50 anni. Rispetto alla situazione degli anni '70, la percentuale di beni riconducibili allo svolgimento di un lavoro privato, e che quindi costituiscano l'oggetto del valore, è praticamente crollata. Il fatto che i prodotti dell'industria finanziaria abbiano sostituito la forza-lavoro utilizzata per svolgere il lavoro privato visto come merce di base, era già una conseguenza della perdita di importanza di questo tipo di merce. Con il cambiamento della merce di base e con il passaggio al capitalismo inverso, tuttavia, questo sviluppo ha subito un'enorme accelerazione, e non solo perché il peso delle merci del mercato dei capitali è aumentato enormemente, ma anche per quel che riguarda la composizione della cosiddetta economia reale. Oggi, una parte sempre maggiore dei profitti aziendali non si basa più sull'estorsione del plusvalore, ma sull'informazione e sulle rendite naturali. La redditività dell'economia reale, e l'aumento esplosivo del capitale fittizio, negli ultimi decenni, sono state due facce della stessa medaglia. Nel capitalismo inverso, da un punto di vista capitalistico, le rendite hanno un significato fondamentalmente diverso ai fini dell'aumento della ricchezza astratta, rispetto quello che anche avevano nel capitalismo classico. Finché la sola valorizzazione del valore sostiene il processo di accumulazione, l'informazione e le rendite naturali rappresentano solamente una redistribuzione della ricchezza astratta. Come "faux frais" (Marx), esse limitano il processo di accumulazione. Nel capitalismo sostenuto dalle dinamiche espansionistiche dell'industria finanziaria, la situazione è diversa. La formazione di capitale fittizio rimane sempre legata alle aspettative di profitto "economico" reale, ma diventa irrilevante che si tratti dei profitti delle aziende produttive, oppure della prospettiva di un aumento dei prezzi dei terreni, o di quelli delle rendite informative attese.
8. Cosa rimane ancora in sospeso
I marxismi attuali hanno prestato poca attenzione al carattere mercantile della ricchezza capitalistica, e hanno erroneamente liquidato la merce analizzata nel primo capitolo del Capitale come se si trattasse di un fenomeno superficiale. Al contrario, è sempre stata consuetudine raggiungere il più rapidamente possibile quel presunto unico decisore, vale a dire il capitale. Solo lì, secondo l'interpretazione comune, si può trovare l'accesso all'essenza del modo di produzione dominante. Sebbene la "Nuova Lettura di Marx" abbia posto il primo capitolo del Capitale, e l'analisi della forma-valore ivi sviluppata, al centro della sua ricezione della critica dell'economia politica, ha finito per riprodurre a modo suo questo capovolgimento, facendo uso di una categoria derivata dall'essenza. Anziché illuminare nel senso del primo capitolo la connessione tra il lavoro privato e le merci e la sostanza del valore, si sono lasciati coinvolgere in un problema illusorio, e hanno cercato di sostituire la teoria del valore, presumibilmente pre-monetaria, con una teoria monetaria. Come ha spiegato Karl-Heinz Lewed (Lewed 2016, p.31 ss.), sulla base delle opere di Hans-Georg Backhaus, ciò ha finito per non significare altro che voler stravolgere Marx a partire dal fatto che egli distingue coerentemente tra la forma del valore e la forma del denaro che nasce dalle sue contraddizioni interne, ed è quindi derivata. Fin dai suoi inizi, il Gruppo Krisis ha seguito un orientamento diverso e ha preso le distanze dal trattamento matrigno della categoria merceologica che ne fa il marxismo tradizionale. Invece di parlare sempre di capitalismo, come è consuetudine nei dibattiti di sinistra, ci piaceva piuttosto riferirci al modo di produzione e di vita prevalente nella società delle merci, ed è per questo che dal 1992 viene pubblicata anche la rivista Krisis con il suo sottotitolo "Contributi alla critica della società delle merci". La scelta di questa etichetta, aveva lo scopo di far capire che, categoricamente parlando, la forma mercantile della ricchezza sociale, e non solo il capitale, è la caratteristica decisiva del nostro modo di produzione e di vita prevalente. Alla luce di questo orientamento, è nella linea di casi dell'approccio teorico sviluppare una comprensione della critica dell'economia politica che riempia di contenuto il concetto di società delle merci e che definisca coerentemente la categoria della merce. Una tale riformulazione della critica dell'economia politica deve raggiungere soprattutto due obiettivi. In primo luogo, deve prendere in considerazione anche quei tipi di merce da cui Marx astrae nel primo capitolo del Capitale, ma senza i quali non si può comprendere il capitalismo del nostro tempo. La ricezione della critica dell'economia politica di Marx, che si conclude con il primo volume, non è adatta ad analizzare le leggi di movimento del capitalismo di oggi. D'altra parte, è necessario esaminare più da vicino la connessione tra la costituzione del valore, la sostanza del valore e il lavoro privato, e farlo da una prospettiva di lavoro critico. I sostenitori della Nuova lettura di Marx hanno ragione nell'affermare che il resoconto di Marx nel primo capitolo del Capitale presenta lacune non trascurabili. Tuttavia, sbagliano a localizzare il problema fondamentale. Non è il carattere pre-monetario della sua teoria del valore a essere responsabile di varie incoerenze, ma il fatto che egli operi con un concetto sovrastorico di lavoro nella sua opera principale. Per quanto riguarda il primo settore, sono disponibili studi individuali per la maggior parte dei principali tipi di prodotti derivati.(*1) Naturalmente, il compito rimane quello di sviluppare sistematicamente il nesso logico tra i vari tipi di prodotti e di combinarlo in una presentazione globale. Tuttavia, finora è mancata un'analisi dei prodotti del lavoro privato che tenga costantemente conto delle implicazioni categoriche della critica del lavoro. Naturalmente, rimane ancora il compito di sviluppare sistematicamente la connessione logica tra i vari tipi di prodotti e di combinarli in una presentazione complessiva. D'altra parte, manca ancora un'analisi dei prodotti del lavoro privato che tenga conto in modo coerente delle implicazioni categoriali della critica del lavoro. Certo, anche in questo caso è possibile basarsi su lavori precedenti. Tra questi, in particolare, il concetto di Moishe Postone sul lavoro come istanza che assume la mediazione sociale nel capitalismo. Tuttavia, nel suo libro Tempo, lavoro e dominio sociale (Postone 2003), rimane poco chiaro cosa questo significhi per il rapporto tra le categorie di lavoro, lavoro privato, sostanza del lavoro e potere del lavoro e come si relazionino tra loro. Aggiornare la critica dell'economia politica non può che significare liberarla dalle scorie ideologiche del lavoro che ancora la avvolgono nel Capitale di Marx. Una critica coerente della forma di ricchezza capitalistica della merce e una critica della forma di attività capitalistica del lavoro sono due facce della stessa medaglia.
- Ernst Lohoff - Fonte: Krisis
NOTE:
1 - Questi includono "Die Ware im Zeitalter ihrer arbeitslosen Reproduzierbarkeit" (Lohoff 2002), il saggio "Il valore della conoscenza" (Lohoff 2004), che si occupa dell'economia politica dei beni della conoscenza, l'articolo 1/2014 di krisis "Accumulazione di capitale senza accumulazione di valore" (Lohoff 2014), che tratta delle leggi del movimento del capitale denaro-merce, il saggio correlato "La merce generale e i suoi misteri" (Lohoff 2018) e "Perché l'edilizia abitativa sta diventando inaccessibile e cosa fare al riguardo" (Lohoff 2020), che dà un'occhiata alla terra delle materie prime. Un'analisi generale della trasformazione delle risorse naturali in merci è ancora in sospeso.